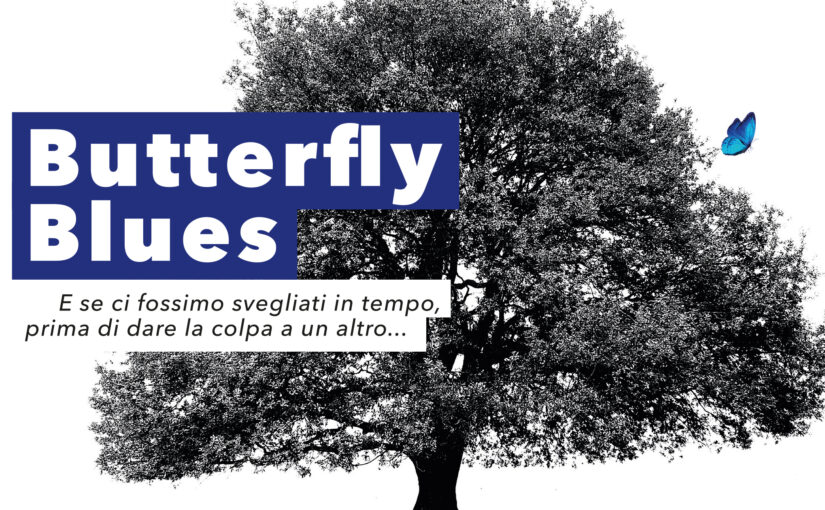Arriva un momento in cui può capitare di aver bisogno di cambiare. Di cambiare tutto.
A me accadde sedici anni fa, nel modo più tranciante. A un certo punto mi resi conto che non ero più soddisfatto di quello che facevo, non mi divertivo più e anzi, a dire il vero, mi rompevo abbastanza le scatole per ogni giorno che il Signore mandava in terra. Decisi così la mia personale rivoluzione, una rivoluzione nella quale – va detto – fui molto fortunato giacché partivo, lancia in resta, con molte possibilità di fallire e addirittura di farmi male.
Nel giro di pochi mesi mollai un posto da viceredattore capo al Giornale di Sicilia (un posto di quelli ritenuti allora sicuri, ben retribuito), chiusi porte e portoni di ogni genere e finii a gambe all’aria. Vi dico solo che per una settimana dormii in auto, dato che non avevo più neanche una casa in cui stare.
Non sono mai stato ricco, provengo da una famiglia borghese ma di certo non ricca, quindi la situazione era abbastanza complicata. Fu così che una sera decisi di andare a casa dei miei genitori, fino a quel momento all’oscuro di tutto, e di metterli al corrente dei miei casini. Mi ero preparato al peggio, i miei mi avevano sempre ritenuto (almeno sino a quel momento) una testa calda ed ero pronto se non allo scontro, a sorbirmi una ramanzina.
Invece andò diversamente. E credo che lì, quella sera, tutto cambiò davvero.
Non appena cominciai a raccontare degli sfaceli che deliberatamente avevo scelto come estemporanea filosofia di vita (perché accade che le migliori scelte siano quelle che a prima vista sembrano le peggiori, ma lo veniamo a sapere sempre troppo tardi) mio padre aprì una bottiglia di vino mentre mia madre si mise ai fornelli. Eravamo tutti e tre in cucina ed il loro modo di ascoltare fu un misto di attenzione e cura; volevano fare con semplicità quello che sino ad allora non gli era riuscito facile, prevalentemente per colpa mia, cioè darmi una sensazione di sicurezza.
Fu così che in una sera feci il più importante giro di boa della mia vita.
Decisi di farmi una casa tutta mia, niente più affitti, convivenze in proprietà altrui, falso godimento della provvisorietà. Volevo mettere radici in un mondo in cui vivere soddisfatto. Imparai mestieri nuovi, grazie sempre alla scrittura: scoprii che c’erano pochi ghostwriter in Italia e riuscii in pochi mesi a trovare lavoro in un paio di importanti gruppi editoriali; scrissi da perfetto fantasma di tutto per tutti, dalle radio alla carta stampata; condussi una rivoluzione web in un paio di periodici nazionali; scrissi qualche libro e così via.
Ma soprattutto affrontai la prova delle prove: vivere a casa dei miei genitori, con i miei genitori, per sei mesi. In pratica a 43 anni mi ritrovai ragazzino, alle prese con riti che avevo dimenticato, con antiche usanze domestiche (tipo che si pranza e si cena sempre a una certa ora). Dovetti riprendere confidenza con la cura culinaria di mia madre che, pensandomi sempre denutrito nonostante la testimonianza inoppugnabile del girovita, alle 8 di mattina assieme al caffè serviva il menù della cena per il quale si era messa ai fornelli già alle 5 (perché certe cose se non le cucini all’alba non sono buone…). Imparai a condividere i cazzi miei con mio padre, il quale con amorevole candore riteneva naturale sedersi accanto a me quando ero al computer e commentare tutto, ma proprio tutto, ciò che scrivevo mentre lo scrivevo: soprattutto le cose più personali (la curiosità spudorata deve essere un tratto genetico). Insomma ero un figlio ritrovato e mio padre, affamato di storie, esercitava legittimamente il meraviglioso diritto all’invadenza affettiva.
Questa storia ha un paio di passaggi che, ancora oggi, mi sembrano irreali: sapete, quei ricordi che col tempo diventano un film e vivono per decenni in un limbo tra fantasia e realtà…
Una mattina, la prima in cui mi svegliai in quella casa nella rinnovata veste di figliol prodigo, rimarrà memorabile negli annali della mia famiglia.
Mi alzai ed ero solo poiché i miei avevano programmato una gita fuori porta. Poco male, mi dissi, così mi ambiento senza rompere le scatole a nessuno (ovviamente i miei sensi di colpa erano alle stelle). Feci colazione con vista sul mare, poi stancamente fumai la prima sigaretta. Dopo andai a lavarmi i denti nel bagno dei miei. Mentre agivo di spazzolino sentivo qualcosa di strano, ma pensai che era colpa di quella sigaretta prematura (solitamente non fumavo mai di mattina, ma in quei giorni ero incasinato, preoccupato, scazzato e fumavo il fumabile sempre e dappertutto). Quando mi accorsi che l’impasto tra i denti aveva assunto una preoccupante consistenza oleosa decisi di inforcare gli occhiali e presi il tubetto.
Crema per i piedi.
Così imparai la prima regola del manuale del figliol prodigo più figliol che prodigo: casa che vai stranezze che trovi e più non dimandar.
I miei genitori nella loro categorizzazione delle cose tenevano in buon conto quella dei tubetti, a prescindere da ciò che essi contenevano. Quindi la crema per i piedi stava insieme al dentifricio, e non ho mai avuto l’opportunità – perché da allora misi attenzione (e occhiali) prima di compiere un’azione in cui c’era da spremere un contenitore – di verificare altre coesistenze balzane: chissà, con un po’ di impegno un giorno avrei spalmato della maionese per contrastare le occhiaie o avrei usato del Lasonil per lucidare le scarpe. Comunque ci misi un’ora per sciacquarmi la bocca e cinque sigarette per riacquistare lucidità. Poi, data la bella giornata, decisi di mettermi al sole.
Sparai musica a palla dalla radio dell’auto parcheggiata vicino, e chiusi gli occhi.
Uno spruzzo in volto.
La sensazione di qualcosa che viene giù dal cielo.
“Cazzo, piove!”
Apro un occhio ma il sole è abbagliante.
Altra roba addosso. Frammenti umidi, sempre di più.
Non era pioggia. Ma… sardine.
Sì, sardine. O comunque pesciolini che venivano giù dal cielo.
In un paio di minuti dovetti fuggire perché ero tempestato da una pioggia di animali (io, vegetariano!).
Ci misi un bel po’ a razionalizzare come accade quando ci si trova dinanzi a un evento che si annuncia figlio (indegno) del paranormale.
Alzai gli occhi e vidi una battaglia di gabbiani che si disputavano qualcosa proprio sopra la mia sedia a sdraio. Capite bene che il passaggio dal “tubetto selvaggio” al “piovono pesci” fu traumatico. E soprattutto indelebile.
Tutto ciò accadde nel primo giorno della mia emancipazione da una vita insoddisfacente. E, ne sono certo, ci fu una “mano de Dios” per darmi una lezione: della serie impara a vivere, non ti meravigliare troppo per ciò di non sai e non rompere il cazzo con ciò che credi di sapere.
Da lì la convivenza coi miei fu una discesa. Mi abituai a discutere di pasta coi broccoli arriminati e di peperoni ripieni appena sveglio, e a rispondere a mio padre che all’una di notte, allarmato perché non ero ancora rientrato a casa (a 43 anni!), mi telefonava e affettuosamente si diceva preoccupato: “Tranquillo pa’, sto bene. Tra poco torno”, biascicavo da un pub la cui unica attrattiva era la birra era che costava poco.
La cosa che ho imparato da quell’esperienza – che qui ho riassunto togliendo il 90 per cento degli aneddoti (alcuni dei quali mi riservo di raccontarvi) – è che non è mai troppo tardi per tornare sui nostri passi, che i pregiudizi non sono giudizi anticipati ma cazzate definitive.
Soprattutto mi preme dirvi perché vi ho raccontato questa storia.
Sedici anni fa, in quel ciclone di follie, mi inventavo una casa virtuale mentre costruivo una casa reale.
Esattamente sedici anni fa nasceva questo blog. Con una consapevolezza: che avrei vissuto giorni da radice e giorni da foglia in un’esistenza, virtuale e reale, che è sia albero che vento.
Per ora, buon vento.
Mi piace:
Mi piace Caricamento...