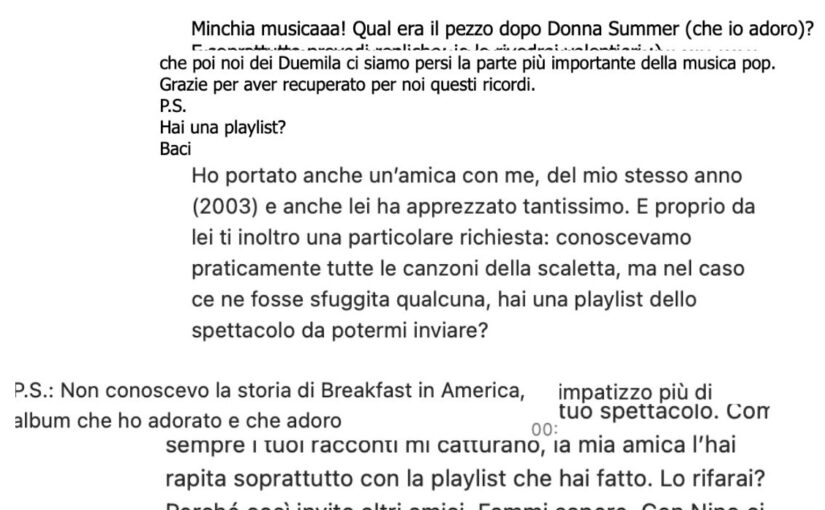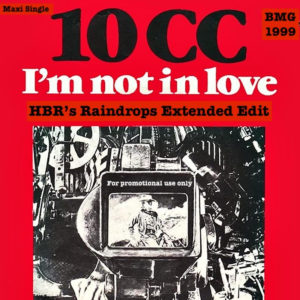Ci sono cose importanti che stanno a margine. Soprattutto nei ragionamenti, negli incastri della socialità vera, nel semplice rapporto tra una domanda e una risposta.
Così, dopo “1979”, la principale domanda che mi è stata rivolta (dopo “ma come ti è venuta ‘sta cosa?” o tipo “chi te lo fa fare?”) è stata: dove possiamo trovare la playlist dello spettacolo? E, elemento di gran soddisfazione, la maggior parte di quelli che me lo hanno chiesto sono giovani (mai visti tanti giovani a un mio spettacolo, uuuh!).
È l’inaspettata conferma di quel che dico della musica proprio nei primi minuti di “1979”:
“…Serve perché per raccontare bisogna essere liberi e per ascoltare bisogna essere pronti a mettere a frutto la libertà che qualcuno ci porge. Soprattutto lasciarsi tentare dalla realtà che non è sempre triste e nefasta”.
Quindi, come si diceva una volta “a gentile richiesta”, eccovi in rigoroso ordine di apparizione, l’elenco delle canzoni dello spettacolo. Mentre qui trovate i link per la playlist su Apple Music e su Spotify
That’s the Way of the World – Earth, Wind & Fire
Fatti più in là – Sorelle Bandiera
Love to Love You Baby – Donna Summer
My Sharona – The Knack
Bad Girls – Donna Summer
Higway to Hell – AC/DC
Le Freak – Chic
Boogie Wonderland – Earth, Wind & Fire, The Emotions
Y.M.C.A – Village People
Ma come fanno i marinai – Lucio Dalla e Francesco De Gregori
Too Much Heaven – Bee Gees
Je so’ pazzo – Pino Daniele
Another Brick In The Wall, pt. 2 – Pink Floyd
Don’t Stop ‘til You Get Enough – Michael Jackson
London Calling – The Clash
Message in a Bottle – The Police
Buona Domenica – Antonello Venditti
Last Train to London – Electric Light Orchestra
I Will Survive – Gloria Gaynor
I Can’t Tell You Why – Eagles
All My Love – Led Zeppelin
The Logical Song – Supertramp
Goodbye Stranger – Supertramp
Take the Long Way Home – Supertramp
Breakfast in America – Supertramp
Viva l’Italia – Francesco De Gregori
Mi piace:
Mi piace Caricamento...