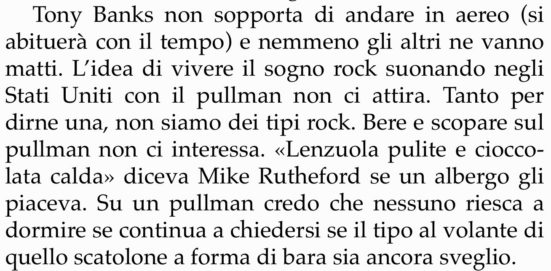Di nottate elettorali è fatta la vita di un giornalista. Modestamente le ho affrontate sin dagli anni ’80 e ho attraversato tutte le difficoltà tecniche possibili. Dalla fotocomposizione all’impaginazione digitale, dalle telescriventi alle agenzie online, dai dimafonisti alle chat di internet, dalla carta al web, non c’è notte elettorale che sia semplice: perché per assioma se uno spoglio è semplice o stai sognando o sei nel Donbass.
Coi colleghi che al contrario di me ancora oggi resistono in trincea, abbiamo rievocato spesso quelle notti in cui un corrispondente si dava latitante (famoso il caso di uno che approfittò dell’alibi elettorale per andarsene con l’amante) e tutto si fermava, o abbiamo rivissuto l’incubo delle elezioni nel Messinese dove con 108 comuni, alcuni di pochissime anime, era praticamente impossibile avere i definitivi entro l’ora stabilita e a volte entro le ore che seguivano. A tutto ciò si aggiunga la grottesca esigenza delle aziende editoriali di anticipare sempre più l’orario di chiusura e quindi il crescente ricorso, da parte nostra, ai salti mortali per mandare in edicola una versione almeno plausibile di ciò che era accaduto e stava ancora accadendo.
All’alba del suo pensionamento un anziano caporedattore del giornale in cui lavoravo, ripescando le collezioni, scoprì addirittura che in questa foga di anticipare, anticipare, anticipare, di alcune tornate elettorali non avevamo mai pubblicato i risultati definitivi.
Ancora oggi con alcuni colleghi di cui sopra abbiamo una sorta di parola d’ordine che facciamo circolare via whatsapp a ogni elezione. È una frase: “La lunga notte…”. E rievoca, appunto, una notte che nella nostra memoria si arricchisce col tempo – sapete, i vecchi quando non ricordano, inventano – di particolari fantasiosi.
Elezioni del 1996. Avevamo mandato Enrico del Mercato, allora cronista parlamentare del Giornale di Sicilia, a fare un reportage nel quartier generale della Rete e lui, in assenza di un briciolo di dati che non fossero quelli scarni dell’affluenza, aveva temporeggiato sino all’ultimo per cercare di mettere più sostanza possibile in quelle cento righe di pezzo. Solo che era tardi. Anzi tardissimo. Fumavamo nervosamente intorno a lui, mentre scriveva una frase che avrebbe dovuto imboccare la fine agognata dell’articolo, ma lui stava ancora lì a scegliere le parole, a cercare un’arguta metafora.
Aveva appena digitato “la lunga notte…” quando il caporedattore Nonuccio Anselmo mi scansò di peso, letteralmente vista la stazza, tolse la tastiera dalle mani di Enrico e scrisse: “…finisce qui”.
Poi schiacciò i comandi “control – assegna” e la lunga notte, almeno per quel pezzo, finì davvero lì. Per poi entrare nella nostra minima leggenda di giornalisti sopravvissuti e non rassegnati.
Ancora oggi una notte elettorale non si evita, si scampa.