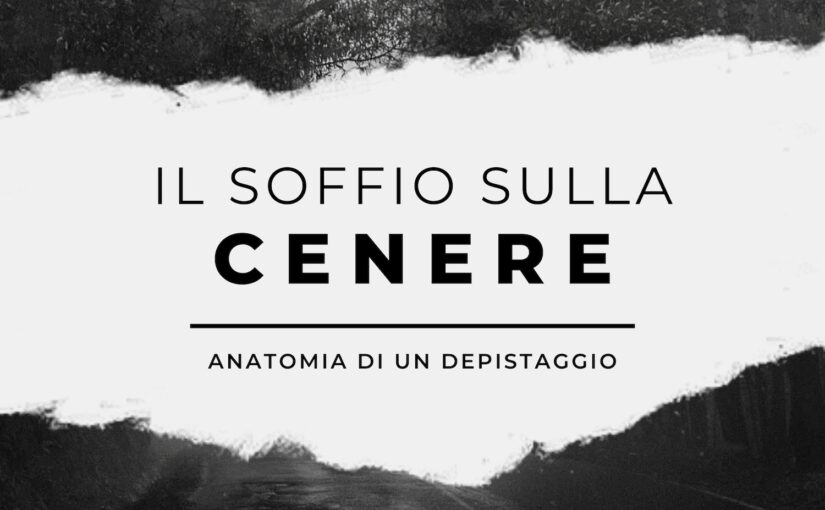L’articolo pubblicato su Il foglio.
Sentenze, libri, cortei, convegni, navi, musei, orazioni civili, ricordi, comparsate in tv, slogan sferraglianti, impegni solenni. E ancora “pentiti”, suggeritori, veggenti, traditori, impuniti troppo impuniti e colpevoli perfetti troppo perfetti. Nel labirinto di via D’Amelio ci si illude di intravedere l’uscita e invece ci si rende conto, anno dopo anno, di aver sbagliato addirittura l’entrata.
A trentadue anni, celebrati proprio ieri, dalla strage in cui morirono a Palermo il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina poche certezze lambiscono una cronaca nota, cristallizzata nel tempo.
Schematizzando.
Il depistaggio ci fu.
I finti “pentiti” hanno tutti nome e cognome.
I magistrati e i poliziotti che li hanno creati, gestiti e difesi sono stati tutti prosciolti e/o promossi o comunque se la sono fatta franca.
Gli unici colpevoli sono due morti: l’ex capo della Squadra Mobile di Palermo Arnaldo La Barbera e l’ex procuratore della Repubblica di Caltanissetta Giovanni Tinebra.
A oggi il più grande depistaggio della storia della Repubblica italiana (definizione dei giudici di Caltanissetta) non ha un colpevole punito tra i viventi, ma solo (soliti) noti impuniti.
Ci sarebbe da armare rivoluzioni, da stendere catene umane. Eppure questa strage non interessa a nessuno. A parte qualche sporadico titolo di giornale, perlopiù nelle pagine interne o nei dorsi locali, quel boato riecheggia solo nelle orecchie dei pochi sopravvissuti e dei parenti delle vittime che ci ricordano che non c’è democrazia nel dolore, non c’è una livella delle ingiustizie.
La verità è che se fregano tutti. E non solo a Palermo che è la capitale mondiale dell’amnesia organizzata, ma nell’Italia intera di ogni governo, di ogni colore, di ogni riforma.
Falcone e Borsellino. Nel binomio partorito dalla cronaca e ancor prima dalla crudeltà degli uomini (perché siamo anche ciò che non ci è stato permesso di essere) c’è tutto il sottotesto di un’antimafia di sussurri, di carriere, di protagonismi, di ingenuità, di coraggio, di forza interiore, di sangue acido, di lavoro silenzioso, di ostentazione, di modestia, di vita con le virgole che ognuno sa darsi.
È un teatro delle evanescenze in cui una scena si apre, un’altra si chiude e una si perde. Come si è persa non solo la ragione di dare un senso definitivo a quei boati, ma anche il tentativo di un racconto diverso oltre che dei caduti in questa lotta tremenda contro Cosa Nostra, dei loro seguaci, degli epigoni, dei parenti acquisiti (le vittime di mafia sono un territorio di grande saccheggio), degli orecchianti che sul ricordo hanno costruito business, politiche, show.
Eppure l’epopea era lì, davanti ai nostri occhi, pronta per essere narrata.
C’era Vincenzo Scarantino, il finto collaboratore di giustizia inventato da La Barbera e Tinebra che mandava in tilt la macchina giudiziaria per 16 anni, cioè fin quando non veniva smentito da Gaspare Spatuzza, un “pentito” assassino ma non farlocco. Eppure Scarantino, ragazzotto della Guadagna senza arte né parte, poteva essere stoppato subito. Cioè ben prima che le sue fandonie portassero a tre processi con altrettanti gradi di giudizio (centinaia e centinaia di udienze) su un presupposto falso. Lui non sapeva nulla della strage di via D’Amelio ed erano La Barbera e suoi a imbeccarlo affinché desse le risposte che il pool di Tinebra si aspettava. Nella storia del nefando traccheggio dal quale scaturisce il depistaggio c’è una data cruciale: 13 gennaio 1995. In quel periodo Scarantino stava accusando alla cieca, ma sempre sotto dettatura. Nei mesi precedenti era stato irritualmente sottratto alla cura del Servizio centrale di protezione dei pentiti e affidato a un’entità creata ad hoc: il “gruppo Falcone e Borsellino” di La Barbera. Già allora Scarantino era stato subito sbugiardato da altri collaboratori di giustizia come Totò Cancemi, Gioacchino La Barbera (soltanto omonimo del capo della squadra mobile) e Santo Di Matteo, padre del piccolo Giuseppe strangolato e sciolto nell’acido da Giovanni Brusca per ritorsione contro il pentimento. Quindi il depistaggio poteva morire in culla già nel 1995. Ma quel 13 gennaio i pm di Caltanissetta fecero qualcosa di inspiegabile. Decisero di non depositare gli atti in cui il pentito farlocco risultava sbugiardato e di conseguenza nulla di quelle contraddizioni venne reso noto ai difensori degli imputati. Ergo, niente di tutto ciò che poteva disinnescare per tempo la bomba Scarantino entrò nel processo che si aprì il 4 ottobre 1994: il processo Borsellino, che allora era ancora il processo Borsellino e basta, e che pochi mesi dopo diventerà il Borsellino primo, per via di una strana sindrome tutta siciliana, quella della moltiplicazione dei processi. Qui comincia l’ottovolante delle udienze e bisogna aggrapparsi al calendario per non perdersi. Il Borsellino primo arriva a sentenza di primo grado il 26 gennaio 1996. Quello stesso anno, a ottobre, inizia il Borsellino bis. Ma nel frattempo inizia l’appello, cioè il secondo grado, del Borsellino primo e un processo nuovo nuovo, il Borsellino ter. Intanto arrivano anche la sentenza di appello del Borsellino primo e la prima sentenza del Borsellino ter. Mentre nel dicembre del 2000, c’è la sentenza di Cassazione del processo primigenio, il Borsellino primo. La Cassazione: uno pensa, finalmente un punto fermo. Macché, tutta la macchina giudiziaria per i primi tre processi è impantanata nelle fandonie costruite ad arte dal falso pentito.
La mitosi giudiziaria non si ferma. Sempre nel 2000 arrivano le sentenze di appello del Borsellino bis e del Borsellino ter. Tre anni dopo tocca alla Cassazione dire l’ultima parola su questi due processi. Ultima parola che non sarà l’ultima.
Infatti bisognerà attendere altri dieci anni per assistere all’inizio di un ennesimo processo, il Borsellino quater, nato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza che, mentre ci aggrovigliavamo in primo bis ter e via numerando, aveva svelato il depistaggio e indicato i veri responsabili della strage: era lui che aveva rubato la 126 fatta esplodere in via D’Amelio e non Scarantino, con quel che ne consegue.
Solo il 20 aprile 2017, cioè 25 anni dopo la strage, si arriverà a una sentenza di primo grado che finalmente non è drogata. Sarà solo l’inizio, un nuovo inizio dopo nove false partenze (primo bis e ter per tre gradi di giudizio) e altrettanti finali fasulli. Nove processi, centinaia di udienze, nessuna verità.
Un labirinto di numeri.
Cento, centodieci, centoventuno.
Avrebbero potuto essere metri, chilometri. O chili, quintali, tonnellate. Avrebbero potuto essere peso o distanza. Invece cento, centodieci, centoventuno sono i “non ricordo” pronunciati da tre dei quattro poliziotti che testimoniarono al processo di Caltanissetta per il depistaggio che ha visto imputati l’ex dirigente Mario Bò, gli ex ispettori Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, tutti prescritti nel processo di Appello. La sentenza, come tutto in questa storia, offre una lettura bifronte e racconta che i poliziotti concorsero a depistare ma che comunque andavano rimandati a casa perché era passato troppo tempo, che guaio ci fu ma non ci possiamo fare niente.
È così la vicenda della strage di via D’Amelio. Appena si mette a fuoco una soluzione spunta una lettura di senso opposto. Appena si tira un respiro, un nuovo cappio stringe il collo.
Nel dedalo giudiziario attraversato da verità vaganti spunta periodicamente il dossier “mafia e appalti”. Si tratta un voluminoso fascicolo scaturito, nei primi anni ’90, da un’informativa del Ros dei Carabinieri su un comitato di affari illegale composto da politici, imprenditori e mafiosi. Quel dossier, indicato tra le cause di un’accelerazione degli attentati a Falcone e Borsellino, sembra un’eterna fonte di guai per chi ci mette mano, che sia per esaminare o per cancellare, per indagare o per proteggere. A cominciare dai carabinieri che lo stilarono, il colonnello Mario Mori e il capitano Giuseppe De Donno, additati per anni come traditori dello Stato per una presunta trattativa con la mafia e assolti definitivamente dopo un estenuante calvario giudiziario. Sino ad arrivare ai giorni nostri con l’ex pm del pool antimafia di Palermo Gioacchino Natoli finito sott’inchiesta a Caltanissetta con l’accusa di aver insabbiato un filone di indagini per proteggere alcuni politici e imprenditori. Lui si è difeso dicendosi estraneo alla losca vicenda, e ha persino incassato la stima di Maria Falcone.
Gira la giostra, tra coraggiosi e traditori, tra nudi e puri e pataccari. Ed è molto difficile orientarsi senza prendere cantonate.
Il caso di Massimo Ciancimino è emblematico. In principio considerato attendibile dalla Procura di Palermo, ma non da quelle di Caltanissetta e Firenze, il figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo tentò di accreditarsi come collaboratore di giustizia. Fu così che, tra una decina di comparsate in tv e un libro autobiografico, la sua pulsione dichiaratoria strabordò sui grandi misteri. Si esibì su tutto, dalla morte di Calvi alla strage di Ustica, dagli eccidi del ’92 alla famosa Trattativa, il suo vero capolavoro, finito però, come abbiamo visto, con assoluzioni a raffica. Insomma quella che per un certo momento fu salutata come una messa cantata si rivelò, qualche procuratore dopo, cabaret.
Il labirinto non risparmia nessuno, neanche le figure dolenti che meriterebbero migliore sorte. Salvatore Borsellino, fratello del magistrato assassinato, ha intrapreso da anni una crociata sulla strada della verità, anzi di una sua verità. Questa missione solitaria lo ha messo in dura contrapposizione con Maria Falcone che non replica più alle sue argomentazioni: “Meglio ignorarlo”. Persino i suoi nipoti, i figli di Paolo – Lucia, Fiammetta e Manfredi – e il loro avvocato Fabio Trizzino sono finiti nelle sue invettive. La loro colpa? Aver criticato aspramente i magistrati, come ad esempio Nino Di Matteo, che invece lui difende a spada tratta. L’emblema della crociata è una foto del 2014: Salvatore Borsellino abbraccia Massimo Ciancimino in via D’Amelio in quella che Giuseppe Di Lello, ex membro del pool antimafia, definì “l’immagine più distruttiva dell’antimafia”.
Al netto delle indagini a colpo freddo, delle rivelazioni tardive e dei tentativi di filtraggio delle acque torbide in cui uomini delle istituzioni e uomini della mafia si mossero indisturbati, non si può non tenere conto che a quei tempi c’erano due procure che si davano battaglia, tenendosi in ostaggio a vicenda, mentre una guerra vera, terrorizzante, infuriava a Palermo e non solo: la guerra che la mafia aveva dichiarato allo Stato. Su ogni cosa la procura di Palermo di Gian Carlo Caselli la pensava all’opposto di quella di Caltanissetta di Giovanni Tinebra. Sui “pentiti” cruciali soprattutto: Caltanissetta aveva uno Scarantino telecomandato, Palermo aveva una pattuglia di collaboratori di giustizia che lo smentivano. Perché Palermo non intervenne per tempo? C’erano patti da rispettare? C’era forse un filo di tensioni incrociate che imbarazzava i due uffici giudiziari?
La battaglia non si limitò al 1992, ma arrivò sino ai giorni nostri quando, ad esempio, nel processo sulla presunta trattativa Stato-Mafia, Palermo ipotizzò che la strage Borsellino potesse essere stata accelerata proprio da quella trattativa. Ma se così fosse stato, non avrebbe dovuto occuparsene la Procura di Caltanissetta che proprio su quella strage indagava?
Un labirinto. Un sistema di domande che ne figliano altre, un complicato intrico di persone e personaggi impossibili da recensire.
Come Bruno Contrada, alto esponente del Sisde, irritualmente chiamato a collaborare alle indagini sull’eccidio di via D’Amelio che dice, oggi, che se allora gli avessero affidato Scarantino avrebbe “scoperto subito che si trattava di un cialtrone”. Eppure lui stava lì e le dichiarazioni di Scarantino le conosceva, cosa ci voleva per smascherarlo, una presentazione ufficiale, una cena aziendale?
Come i “signori nessuno” estranei a Cosa Nostra che si materializzarono nei luoghi in cui si custodiva l’esplosivo delle stragi e che suscitarono perplessità persino tra i mafiosi.
Come i due colpevoli perfetti, perché deceduti. L’ex procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra che di mafia ammetteva serenamente di sapere poco e l’ex capo della Squadra Mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, al soldo dei servizi segreti, che invece sapeva troppo e che si curava di sceneggiare la storia a modo suo: famosa la sua preveggenza sul tipo di auto usata per la strage Borsellino con cui anticipò di un giorno il risultato di una perizia tecnica.
La verità processuale, labirintica anch’essa, ci dice che il depistaggio c’è stato, ma non si sa bene perché. Il succo è che in una congerie di situazioni spesso grottesche si inventò un castello di falsità per trovare in fretta una soluzione qualunque e che il tutto fu agevolato dalla scarsa qualità professionale dei magistrati che ci lavorarono.
Poco importa se, al netto del mistero dell’agenda rossa scomparsa, nulla si è mai saputo di quali carte avesse con sé Borsellino il pomeriggio del 19 luglio 1992. E soprattutto non si sa ancora cosa gli inquirenti prelevarono quel giorno nel suo ufficio perché non fu mai prodotto un verbale di sequestro dei documenti. Di certo sappiamo che di quelle carte a Riina e compari non gliene fregava nulla.
Ascolta il podcast sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio
La foto è di Franco Lannino.