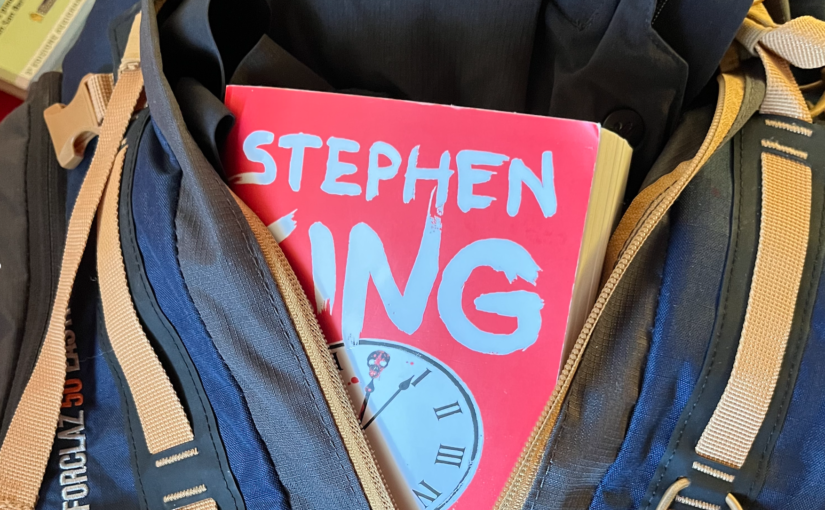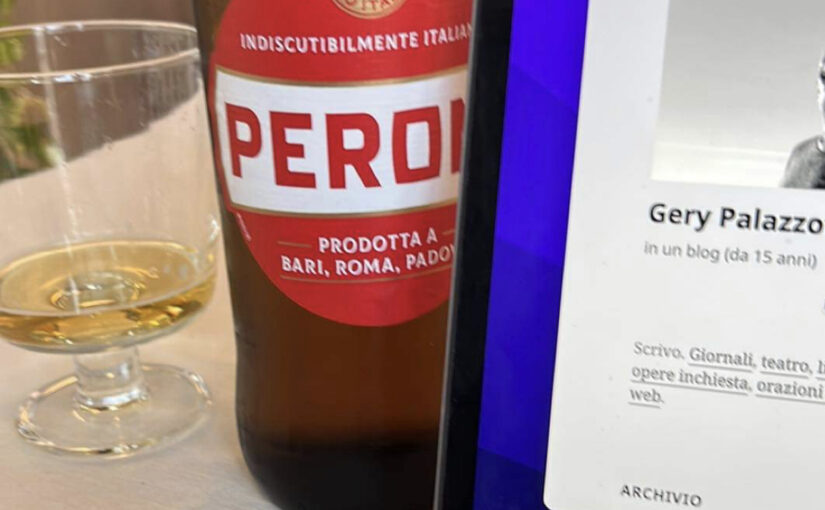Siamo zaino e portatori di zaino. Viviamo per caricarne uno e svuotarne un altro. Lo teniamo in spalla ma ci siamo anche dentro. Perché uno zaino è casa, e una casa è vita.
Chi ha mai viaggiato con uno zaino con dentro tutto tranne che le mura e il letto di casa, conosce il livello di amore e odio che si instaura con un manufatto del genere. Parliamo di una cosa che ti metti in spalla come una croce, che ti trascini come un peccato originale, che proteggi come un tabernacolo.
Per la maggior parte di quelli della mia generazione lo zaino è protesta, controcultura, passato che non ritorna. Per quelli che sono venuti dopo è perlopiù un attrezzo desueto, quasi da barboni o comunque una cosa poco pratica, poco igienica, da tenere nel ripostiglio.
Per me invece – e per un manipolo di altri viaggiatori di ogni latitudine generazionale – lo zaino è un raro esempio di simbolo che diventa catalizzatore: libertà è la parola che mi viene, e non so se a voi ne viene una migliore (minchia, meglio di “libertà” cosa c’è nella vita?).
Ora che la mia porzione di Francigena è terminata ho chiare alcune cose.
Innanzitutto che la mia esperienza con questo cammino italiano è conclusa. La Francigena è un itinerario di persone più che di luoghi, è bistrattata da chi si occupa di turismo e cultura, ed è bellissima malgrado tutto. Ha passaggi di traffico pericolosissimi, ha Comuni che se ne fottono delle sue potenzialità, ha tappe dove non c’è nulla da mangiare e da bere in agosto mica a dicembre. Ma ha soprattutto un patrimonio umano pazzesco, tanti piccoli centri arroccati in posti impossibili, un campionario di ospitalità ineguagliabile, un assortimento di storie, sacrifici, scommesse che diventano tesoro non appena varcano la soglia del ritegno familiare, della discrezione paesana. Io mi sono immerso, per delicata volontà dei miei interlocutori, in storie memorabili. Ho camminato nel buio della notte senza luna senza mai aver paura di perdermi e ho goduto di una pizza nel posto più improbabile per una pizza, ho costeggiato ettari di terra coltivata a pomodori e ne ho mangiato il giusto per rimanere al di sotto della quota umana possibile, ho trovato chi voleva ascoltare le mie storie in una piazza improvvisata (che gioia, che emozione!) e chi invece voleva raccontarmi le sue all’ombra di un castagno, ho scalato con fatica l’ignoto e mi sono confessato con sincerità con ignoti (più difficile la seconda).
Poi con la mia amica Sarah (la trovate qui) abbiamo imbastito, nei rari momenti di connessione social, un parallelismo di Cammini: io sulla Francigena, lei sul Cammino Portoghese. E lì ho stravolto la mia bibbia sociale applicata a queste cose. Lei che è molto cattolica, e altrettanto femmina, va in chiesa con la naturalezza con cui va dal parrucchiere. Che, se ci pensate, è un bel messaggio: non è mai troppo tardi per una bella messa in piega dell’anima. “Perché ‘sta storia che la pellegrina deve essere pulciosa deve finire…” dice, e lì ci sarebbe da ricostruire tutta un’iconografia del sentire comune soprattutto della sinistra italiana, con ampia licenza di metafora.
Nella conclusione del mio cammino oggi ho affrontato una salita tremenda – quasi sette chilometri di scalata, più che salita – e da qualche migliaio di chilometri lei ha confermato a proposito dei suoi dislivelli: “Ho visto più bestemmiatori su queste salite che allo stadio” ha scritto dal Portogallo. Conoscendola, so che dio non smentirebbe e, magari, convocherebbe il suo CDA in sessione estiva.
Di questo cammino mi resta, a parte la felicità di tutti queste centinaia di chilometri (manco li ho contati), la consapevolezza che col sapone di Marsiglia ho lavato tutto e di tutto, tranne che i denti. Che siamo abituati a detestare le zanzare solo perché non conosciamo il potere demoniaco delle formiche e soprattutto delle mosche. Che con certe temperature nell’estate padana (ed era il caso di fargliela fare a Bossi e Salvini ‘sta Padania a patto che col caldo restassero tutti confinati nella loro bella repubblica indipendente/rovente), ti stupisci di scegliere se l’ultimo goccio della borraccia deve andare sulla testa rovente o nella gola arsa. Che, se provi a usare Google Maps cedendo alla pigrizia tecnologica anziché fidarti delle mappe su carta, nella maggior parte delle volte finirai in un sentiero cieco, meritatamente sperduto.
Insomma ridiamo, scherziamo, rubiamo tramonti a posti che abbiamo visto di striscio, citiamo autori che mai abbiamo letto, ci impadroniamo di musiche che non conosciamo, usiamo “Easy” dei Commodores per le storie di amore senza sapere che la canzone parla di un amore di cui l’autore si è finalmente liberato, e via condividendo. Alla maggior parte di noi di queste cose non gliene frega niente.
Ecco perché alla fine di questa cronaca – che è sì telematica ma soprattutto umana, ergo analogica – mi piace pensare che siamo zaino e portatori di esso. Perché il giorno in cui ci sarà il liberi tutti, senza zaino non si salverà nessuno.
10-fine
Le precedenti puntate le trovate qui.
A questo argomento è dedicato il podcast in due puntate “Cammino, un pretesto di felicità” che trovate qui.