Mi sto occupando per lavoro di una storia di cronaca di molti anni fa nella quale, come spesso (mi) accade, ho a che fare con il concetto di verità applicato al concetto di Stato. Che sono due cose strane da accoppiare.
Da un lato uno Stato dovrebbe garantire una verità accessibile e riscontrabile qualsiasi essa sia, dall’altro parlare di verità di Stato significa esattamente l’opposto in termini di accessibilità e riscontrabilità.
Del resto siamo il Paese in cui è caduto un aereo senza che nessuno nelle stanze dei bottoni (stanze dei bottoni è orribile, ma neanche il contesto è gradevole) battesse ciglio per decenni, in cui le bombe nelle piazze hanno avuto colpevoli spesso presunti e capri espiatori certificati, in cui abbiamo avuto tre tipi di terrorismo, quello di sinistra che era contro lo Stato, quello di destra che era dentro lo Stato e quello mafioso che era contro e dentro lo Stato.
Quando mi imbatto in cronache datate per trarre spunti di narrazione o più semplicemente per colmare una delle mie tante lacune, ho una specie di sindrome da rientro. Sapete, come quando tornate da una lunga vacanza e vi chiedete “ma al lavoro mi vorranno ancora?” e cose simili. Ecco, quando mi tuffo in quel passato ho la sensazione che oggi non gliene freghi niente a nessuno di quei nodi mai sciolti, di quelle righe mozze, di quelle vite senza storia. Insomma mi pare di ritrovarmi in mondo che quando mi vede sbuffa.
Probabilmente qualcuno di voi sbuffa già qui, a metà di un post scritto nel presente, che parla di passato e che ancora non ha un futuro.
Nel campo dell’arte e della cultura – per quello che conosco e che frequento – il passato è spesso ricostruzione, artificio, effetto e ogni tanto spunto per una riflessione. Ma è difficile che qualcuno lo spieghi, provi a decrittarlo: perché c’è questa specie di indolenza per la quale illustrare annoia. Quindi o si ammanta il tutto con la teatralità di artifici, effetti eccetera, o si pensa che lo spettatore sbadiglierà già davanti alla locandina.
I teatri e la tv, ma anche il mondo dei podcast (nei libri c’è però la bella eccezione di Antonio Scurati) sono più propensi a confortare con prodotti che raccontano ma solo un po’, in cui la contaminazione con l’umorismo o la leggerezza o il glam di un attore diluiscono il tutto.
Non voglio fare esempi concreti – ne ho almeno una decina, per rimanere solo al 2024 – perché non mi interessa la polemica (alcuni degli autori in questione sono miei amici o professionisti che stimo). Mi interessa che passi un concetto che riguarda tutti, autori e lettori, artisti e pubblico, ministri e cittadini: un Paese che non ha paura del futuro deve imparare a raccontare innanzitutto il suo passato meno noto, a illuminare gli angoli più bui, a non sottovalutare la cronaca che da domani sarà storia.





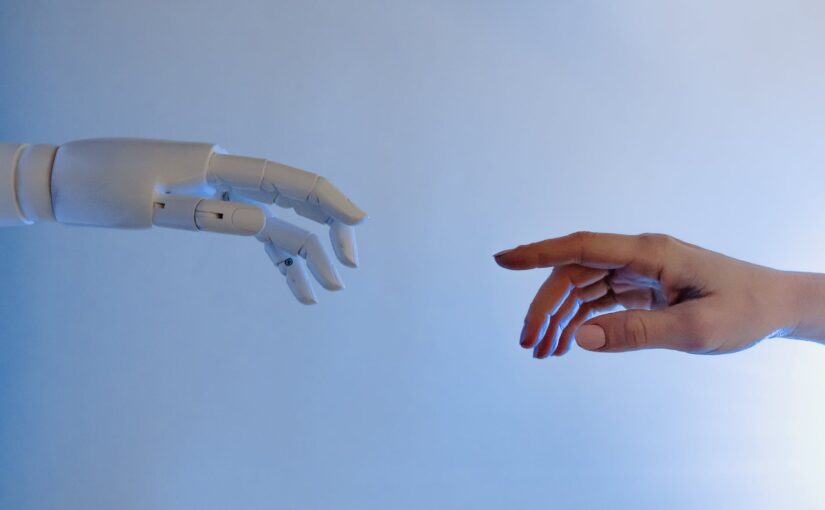


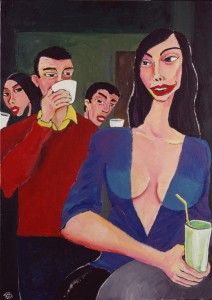
 La mia amica
La mia amica