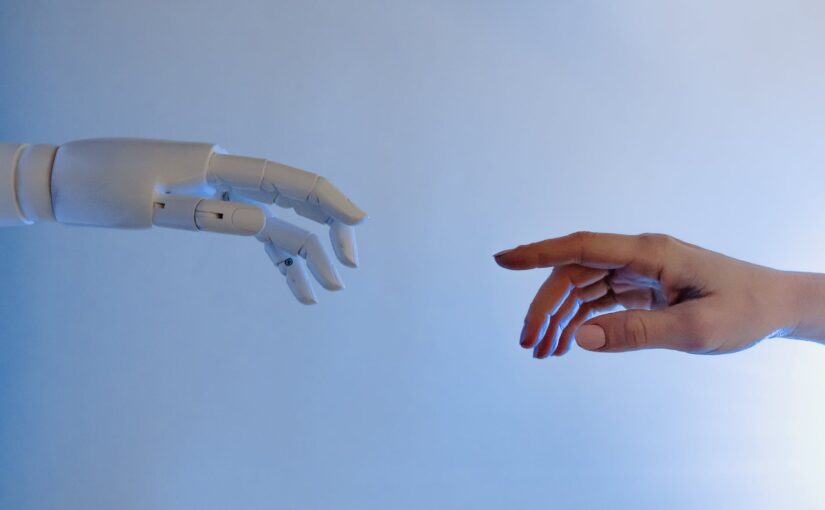Molti anni fa quando lavoravo al Giornale di Sicilia capitava spesso che il condirettore Giovanni Pepi usasse l’interfono in modo abbastanza invasivo. Dal nulla quell’infernale apparecchio (che, lo confesso, sfasciai il giorno dopo che lo avevano installato) faceva “Diiin!” e trasmetteva la voce imperiosa del de cuius che a tradimento dava un ordine o, peggio ancora, chiedeva qualcosa a saltare. La cosa davvero fastidiosa era l’invasività del mezzo, per non dire della persona che lo usava a sproposito: quella voce irrompeva spesso quando nelle nostre stanze c’erano ospiti e la figuraccia era purtroppo assicurata.
Una sera, come ogni sera, io e Francesco Foresta eravamo riuniti (quasi accampati data la mole di lavoro) nella stanza dell’allora caporedattore Armando Vaccarella. Era il periodo in cui il giornale si batteva per la riapertura del Teatro Massimo e pubblicava periodicamente editoriali sul tema, preceduti da un numero che scandiva i giorni dall’inizio della campagna. Quella sera dal nulla scattò il tremendo “Diiin!” seguito dalla voce tuonante di Pepi.
“Armandooo! A che numero siamo col Teatro Massimo?”.
Armando non ci penso due volte e sparò: “Duecentotrentasei!”
“Bene, pubblichiamo un editoriale su domani!”.
Chiusa la comunicazione ci guardammo smarriti e io non chiesi ad Armando cosa avrebbe scritto in un fondo commissionato a tradimento, così come se fosse un coppo di calia e simenza, ma: “Ma come facevi a sapere a memoria a che numero eravamo arrivati”.
E lui: “Che minchia ne so? Ho sparato a muzzo (a casaccio, ndr)”.
Quindi tutti di corsa, con un sottofondo di risata isterica tipo quella che ti scappava in classe quando la maestra ti guardava e tu non potevi dire nulla, nella stanza del caporedattore centrale Giovanni Rizzuto.
“Giovà, fai quello che vuoi ma domani in prima pagina ci deve essere questo numero: duecentotrentasei”. Altre risate, nella cui eco – essendo l’unico sopravvissuto di quel dream team – mi cullo ancora oggi con serena nostalgia.
Armando non aveva sbagliato di poco: solo di un centinaio di giorni (in più o in meno, non ricordo e non importa). Nessuno se ne accorse mai.
Questa storia mi è venuta in mente stamattina mentre, durante il solito dispendio di calorie quotidiano che alcuni chiamano supplizio e altri chiamano sport, pensavo al mio futuro lavorativo: è un rituale che mi concedo ogni fine anno, un po’ scaramantico e un po’ candidamente razionale.
Il lavoro di tutti noi, ma proprio tutti, è fatto prevalentemente di cose che conosciamo solo noi ed è quasi sconosciuto a chi ci sta sopra. È una questione ontologica, i livelli di comando sono compartimenti stagni in cui le interferenze che vengono dal basso vanno disinnescate e in cui ciò che è davvero importante sono i feedback che vengono dall’alto.
C’è un però gigantesco.
La competenza.
Credo che un buon manager debba conoscere la materia prima dei suoi prodotti e non solo i numeri che scaturiscono dalle vendite. La nostra politica si è sostanziata sempre più di dilettanti orgogliosi di esserlo, di inutili cittadini di potere, di gente qualunque investita inopinatamente di poteri straordinari. Il risultato è stato – è sotto gli occhi di tutti – disastroso.
Il direttore che sbraita nell’interfono per chiedere qualcosa di cui non ha idea, che non controlla, è la fotografia di un sistema produttivo che punta all’abisso: e i risultati della cronaca lo confermano.
Serve competenza condivisa. Servono capi che cazziano con cognizione di causa i dipendenti ignoranti. Serve chi sa, chi conosce, chi può insegnare. Serve un’idea di valorizzazione che sia complementare a un sistema di esclusione: ciò che funziona deve stare dentro, costi quel che costi, ciò che non vale un cazzo si butta, pazienza.
Serve il coraggio di ribellarsi, di mollare tutto se necessario, di inventare.
“Armandooo! A che numero siamo?”
“Duecentotrentasei” (e non rompere il cazzo, è il sottotesto).
Che il 2024 sia un anno di trionfo oltraggioso della competenza. Auguri.