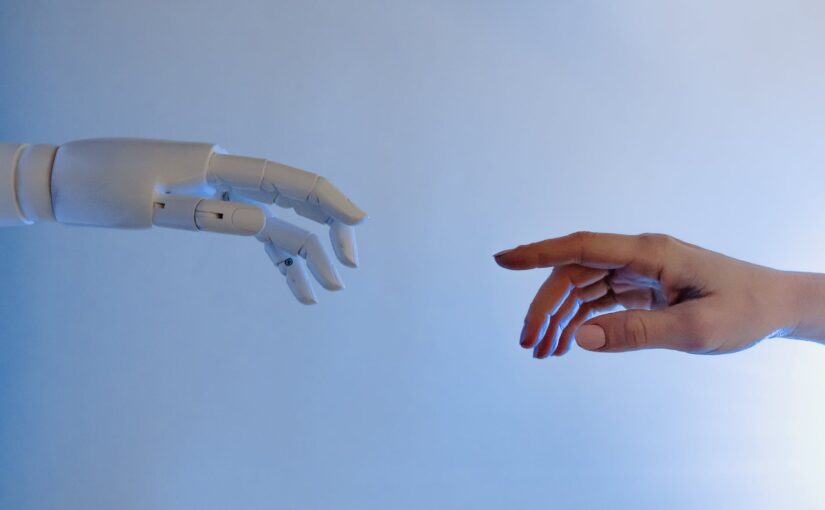Il nuovo non avanza, si insegue, si stana, C’è questa insana idea che l’innovazione ci debba raggiungere comunque, ineluttabilmente come le tasse, la morte e il silenzio di Badalamenti (cit.). Invece no, e che a ricordarlo qui debba essere un tizio come il sottoscritto che ha più strada alle spalle che futuro davanti è divertente (almeno per me).
L’idea del futuro è qualcosa che ti prende alle spalle, senza un motivo apparente.
E per spiegare bene vi racconto due brevi episodi della mia vita.
Metà anni ’90, Giornale di Sicilia. Ero vice caporedattore, capo delle Cronache Siciliane, e nel quasi totale disinteresse di una redazione analogica guardavo oltre. Mi interessava questa strana macchina virtuale che metteva in comunicazione le persone del mondo con un paio di clic, ci si scambiavano esperienze, musica, deliri notturni. Perché era di notte che vivevamo a quei tempi, noi smanettoni. Tutti gli altri ci guardavano storto, poiché il web percepito era allora legato alla clandestinità delle sensazioni: e poco importava se era scambio di files o di numeri di telefono. Noi eravamo marchiati. Al giornale eravamo in due: io e Daniele Billitteri. Parlavamo la stessa lingua, anche perché lavoravamo insieme già da oltre un decennio. E solo dopo una manciata di anni sarei riuscito a convincere l’editore che non bastava un modem semiclandestino a mettere in moto il cambiamento.
Il resto è storia. Il sito del Gds venne varato con grande successo di pubblico e poi inspiegabilmente chiuso per cinque anni. Anni in cui da spento come testimoniai su queste pagine da spento il gds.it faceva oltre tremila utenti unici al giorno. Insomma, ogni giorno tremila persone si collegavano per guardare un monoscopio. E l’editore non ne sapeva nulla, nel migliore dei casi.
Oggi il Gds sta affondando e la gestione dell’online è uno dei capitoli cruciali del “come non si fa”: roba da studiare all’università.
Agosto 2014, Teatro Massimo di Palermo. Il sovrintendente Francesco Giambrone mi chiede di riposizionare il Teatro sul web e non solo. Accetto al buio per due motivi: conosco e stimo Francesco da molti anni e soffro per come il teatro è nudo e disarmato di fronte a qualsiasi tipo di innovazione. Mi invento una web tv, accendo i riflettori dei social, metto su un sito degno di questo nome, e si va. Soprattutto mi prende alle spalle l’idea, quella idea che altrimenti avrei temuto… sì, quella lì: mandiamo GRATIS online tutte le prime delle nostre opere, con sei telecamere, in full hd.
Ma come? E se le diamo gratis, chi se lo compra il biglietto? Se lo chiedono molti dinosauri della burocrazia, ma non Giambrone. Che, senza battere ciglio, si fida e mi dà carta bianca. Non ne ho mai parlato prima d’ora, ma credo che la sua lungimiranza sia stato il catalizzatore ideale per la mia follia.
Oggi il Teatro Massimo ha una partnership consolidata con Google (ultimamente anche con YouTube), è finito sulla prima pagina del New York Times anche per la sua attività sul web, e ha una web tv che non sfigura in campo mondiale.
Perché vi ho raccontato queste storie?
Perché nel mio minuscolo servono a testimoniare che, anche e soprattutto nei momenti complicati, l’innovazione è un’idea che deve volare libera dai lacciuoli dell’ordinarietà. Sennò è buona amministrazione, o lucida burocrazia, altra cosa comunque.
Le migliori idee vengono sempre quando si è senza guinzaglio (o quando anche per poco al guinzaglio si è sfuggiti). E non è detto che siano buone, la percentuale di rischio dà il valore umano, professionale e intellettuale di chi le avalla. Perché farsele venire è una cosa, approvarle è un’altra.
Siamo in un’epoca difficile e per questo dobbiamo pensare a nuovi grimaldelli, nuove chiavi di lettura, nuovi parametri per catalogare gli items che ci circondano.
E se lo faccio io che, proprio in questo momento, sento per la prima volta sul groppone tutto il peso dei 57 anni accumulati spesso barando nelle mie sei-sette vite, non vorrete non farlo voi, giovani e forti?
Quindi pensate, pesate, agite. Il mondo, oggi più che mai, è dei creativi o comunque di quelli che non hanno paura di mettersi a nudo per raccontare una storia che gli altri aspettano (anche se non lo sanno).
Sin quando ci sarà un “c’era una volta” ci sarà una volta. E una luce da spegnere su un bambino che prenderà sonno e che progetterà un mondo nuovo, con un futuro da stanare, inseguire.
Mi piace:
Mi piace Caricamento...