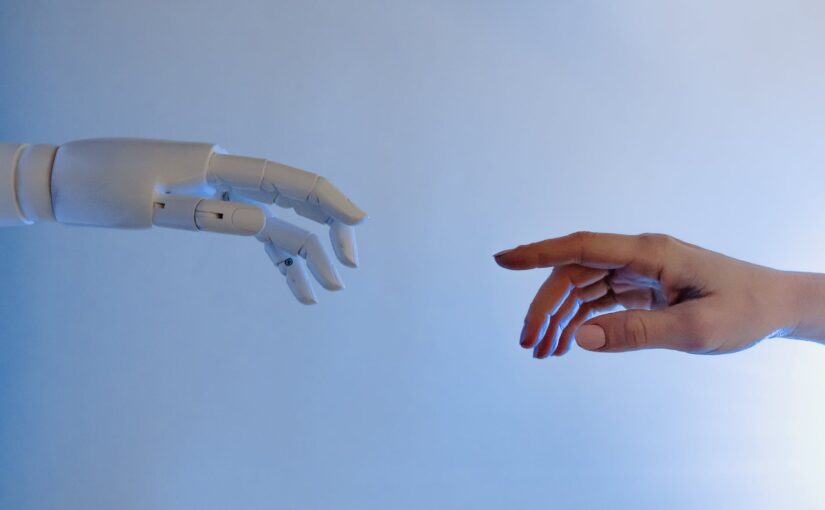Quanti di voi si preoccupano di avere sempre un piano B? Io raramente. E questa risposta potrebbe cozzare con un’idea di cui abbiamo già discusso, quella dell’uscita di sicurezza. Ma diciamolo subito, c’è una differenza abissale: mentre la sola vista dell’uscita di sicurezza è consolatoria quando meno ce n’è bisogno, il piano B serve ad affrontare un’emergenza quando si ventila che essa si possa manifestare. Insomma la prima ci rassicura che tutto è possibile anche quando non ci serve altro di possibile, il secondo serve ad arginare l’impossibile.
Difficilmente ho avuto piani B, in vita mia.
Mi sono schiantato una mezza dozzina di volte in curve strette e senza guardrail e non so ancora se mi sono salvato per fortuna, per miracolo o per merito. Di certo stilare piani B mi annoia a morte. Ipotizzare scialuppe di salvataggio col mare ancora forza 4, mettere i sacchetti di sabbia alle finestre alla prima pioggia, muoversi per colloqui di lavoro quando ancora manco ti hanno licenziato, cercare fidanzata quando la moglie sta solo pensando di mollarti per il primo che passa, sono tutte attività poco eccitanti. Perché non c’è gusto a mettersi il vestito buono preparandosi allo schianto fatale: il piano B non è il casco prima dell’incidente, quella è prudenza; è piuttosto prevedere la strada che farà l’ambulanza per raggiungerti il prima possibile.
Il piano B, anzi la sua inutilità, mi ricorda un mio indimenticabile maestro, Salvo Licata, che a noi giovani aspiranti giornalisti (in gergo “biondini”) dei primi anni Ottanta spiegava perché non prendeva mai appunti su cosa dire a una conferenza: “Perché ogni volta finisco per ignorare il foglio o per perderlo e mi ritrovo a raccontare l’esatto opposto di quello che avevo segnato”.
Per molti di noi, il piano B è solo un alibi per mettersi a posto con la coscienza facendo finta di ignorare il gran vantaggio di usare l’incoscienza.
Ecco, non è lo “stay foolish” di Steve Jobs, ma qualcosa di simile. Aspettando il piano B sottovalutiamo il piano A, oppure ci impigriamo in scelte di comodo (un piano B che si rispetti non è mai comodo), oppure ci perdiamo la fondamentale paura di perderci per ritrovarci più a valle, sudati, sporchi, affaticati ma ricchi di un’esperienza in più.
Ci piace stare comodi, ma è con la scomodità che ci alleniamo. Ci piace intorpidirci, ma è con l’adrenalina che ci eccitiamo. Ci piace il minimo garantito, ma è col massimo dell’incognito che davvero possiamo sentirci vivi. Non è per tutti e da tutti vivere senza piano B, lo capisco. Gran parte di chi riesce a rinunciarci è gente che conosco bene, senza famiglia, senza padrone, senza timori.
Una volta, in uno dei miei cammini, mi persi in un bosco in mezzo a un temporale. Stavo in un terreno scosceso senza sentiero e con un fango che cominciava a diventare torrente. In quell’atmosfera quasi da disastrer (B) movie il cellulare (ovviamente) non aveva campo e la mappa su carta rischiava di diventare una poltiglia. Dal nulla, dopo un’ora di scivoloni e bestemmie, mi apparve un cartello sbiadito appeso a un albero.
C’era scritto: “Di qua”. Senza una freccia, senza un “qua” plausibile.
Non so perché ma lo ritenni il canto del cigno di un qualsiasi piano B.
Buon Natale a tutti.