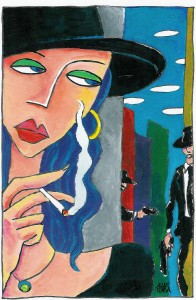Questa è la storia di una vita, ma non basta una vita a raccontarla. Perché è la storia in cui una vita si incrocia inevitabilmente con un’altra, con un’altra ancora e così via: figlia mille rivoli di situazioni, mille deviazioni da esplorare, mille bivi da affrontare, mille e mille squarci di umanità che nasce, cresce e muore senza mai saziarsi di un sentimento, che sia odio o amore, invidia o altruismo.
È una storia che provo a scrivere dal 2007 e che è ferma, pressoché completa, in una cartella del mio computer che si chiama “Katia”.
“Katia” non è il nome di una donna, né di un uragano, né di un virus cibernetico.
È il nome di un bar. Un bar della Palermo degli anni ’70 che stava dietro casa mia, nel quartiere Resuttana San Lorenzo (di cui ho narrato proprio quest’anno qui).
Vi ho più volte parlato del mio cassettismo, cioè di quella mania di scrivere e conservare, ritagliare cose scritte da altri e conservare, imbastire idee e conservare, che mi inscrive contemporaneamente in due gironi di moderni dannati: quello dei parsimoniosi delle emozioni e quello degli inconcludenti tout court.
Mi è tornata in mente oggi, questa storia (anche se mai se ne era andata per i fatti suoi), quando ho appreso della morte del più caro dei miei ex amici. Sono andato a cercare nel ripostiglio tra le foto, impolverandomi le gambe con i vecchi album, distendendo tra le mani carte spiegazzate dal tempo. E poi, ripresomi da questa operazione sentimentalmente analogica, ho riaperto il file della famosa cartella “Katia”.
In quel preciso momento ho capito che almeno per una volta dovevo vincere il mio cassettismo e tirare fuori lo scheletro di questa storia. Solo lo scheletro perché se non basta una vita per raccontarla, figuriamoci un blog. Ora scrivo questo post avvertendovi che è più lungo del solito e che non mi offendo se lo abbandonate adesso ma se sbadigliate durante, sì.
La Palermo degli anni ’70 non era soltanto la Palermo del “sacco” edilizio della mafia, dei delitti impuniti e delle censure ai manifesti dei jeans, era anche la Palermo delle comitive oceaniche.
Noi stavamo al Katia, appunto. Ed eravamo migrati lì, davanti a quel bar anonimo e diciamolo anche un po’ scarso, perché c’era un grande marciapiede e perché la strada non era centrale, quindi garantiva il giusto riparo alle attività lecite (più o meno) dei ragazzini.
Il nostro era un gruppo stratosfericamente assortito. C’erano il figlio del professionista e quello del mafioso, c’erano il fighetto benestante e il poveraccio dignitoso, c’erano i fighi e gli sfigati, c’erano drogati e virtuosi, c’erano musicisti e gli sciatori (sì, sciatori come vi ho raccontato qui). Tutti insieme senza sussulti.
Perché il succo nobile della storia è proprio questo. In questo melting pot di anime più o meno inquiete non c’era spazio per i pensieri inutili, per i rovelli che non fossero benzina emozionale per il gruppo. Se uno sapeva fare una cosa, tipo andare sullo skateboard, stappare la Coca Cola coi denti, fare lo slalom speciale sullo “Sparviero” di Piano Battaglia, impennare con la Vespa, raccontare barzellette, la faceva e nessuno – ripeto nessuno – lo sminuiva. Perché era parte del servizio di consolidamento della comunità. Lì, davanti a quel bar assolutamente inutile dove nessuno di noi comprava niente.
Anzi, chi aveva una specializzazione veniva iscritto in una specie di sottogruppo: io ad esempio facevo parte di tre “commissioni”, sci, skate, impennate e stavo fuori in modo tassativo da barzellette e, tipo, calcio. Ma mi andava bene così. Perché c’era un criterio di valorizzazione democratica perfetto.
Il succo meno nobile della storia è nella narrazione trasversale che una narrazione vera impone. Così come i bambini sono crudeli, gli adolescenti sono traditori.
È nella loro natura, nell’imposizione biologica del loro stesso divenire. Dell’infanzia per fortuna poco ricordiamo, per l’adolescenza invece il discorso è diverso. Soprattutto per un cassettista che ha una storia dentro che spinge come un calcolo renale, con relativo dolore.
Noi ci tradivamo con gioiosa leggerezza. Non solo con le ragazze (e le ragazze coi ragazzi… allora non ci rompevamo i coglioni con queste parità di genere stentoree), questa è la parte più banale tipo “Tempo delle mele”, bensì con l’incoscienza di voler un panorama sempre più ampio, con la voglia di uscire da quel budello di quartiere, con la speranza di liberarci dal gioco di eterni comprimari (la comitiva era la culla potenziale del pari merito immeritato) e diventare finalmente protagonisti. In fondo eravamo inconsapevolmente figli della filosofia aberrante dei “6 politico”. E a noi di una sufficienza non ce ne fotteva niente.
Così ci fu quello che sposò il lavoro a tempo pieno, quello che deragliò nella droga, quello che si mise a caccia di latitanti, quello che lo aiutò dall’interno, quello che bluffò e ce la fece, quello che partì e finse di ritornare ricco, quello che impegnò beni non suoi, quello che rise anziché piangere e quello che spergiurò vendendosi gli affetti più cari. Tutti i colori del tradimento in un patto non scritto di eterna fedeltà stilato all’ombra di quell’insegna brutta come un bar di periferia.
Quando nel 2007 iniziai a scrivere questa storia, la maggior parte dei protagonisti erano in vita o comunque galleggianti. Mettendo insieme realtà e fantasia mi resi conto che la somma di tutti questi deragliamenti era la cifra di una generazione.
Col tempo, negli ultimi quindici anni, molte di queste sensazioni ve le ho trascritte in queste pagine: del resto non a caso questo è il blog di uno che “ha vissuto sei-sette vite sempre sbagliando da solo”. Oggi scommetto più sulle ultime tre parole che sulle precedenti poiché non sono un gatto e i conti da pagare si affastellano sul tavolo della mia esistenza anagrafica.
Però sono certo che c’è una forma di eroismo persino nelle anime qualunque, sopravvissute agli abusi della cronaca di quartiere e alla violenza sociale degli anni ’70. Sta tutta nella capacità di guardare alle differenze con occhio anacronisticamente umano. Noi eravamo tutti diversi in quella adunata di anime capellute e strascicate, e mai questa diversità fu un ostacolo.
Ancora oggi gli amici sopravvissuti a quella epopea sociale sono ben stratificati nel tessuto connettivo di questa città, alcuni stanno altrove, altri non hanno mai abbandonato le loro difficoltà e altri ancora ne hanno incontrate di nuove, drammatiche e impellenti. Alcuni ce l’hanno fatta, altri si sono arresi, umanamente e senza obbligo di vituperio. Io sono un fortunato e ogni volta che incontro un amico di quei tempi lo abbraccio con la forza di una disperazione che avverto solo io: come dire, grazie di avercela fatta, non era scontato in un’epoca di citofoni scassati e telefoni a disco.
Col tempo che passa siamo più deboli, ma la nostra forza sta nel capire – e non è facile – che nella spiaggia della nostra memoria un ricordo non deve essere un granello di sabbia nell’occhio, anche se la lacrima scende lo stesso.
Per questo, anche per questo, la storia del file “Katia”, che non vi racconto, finisce qui.