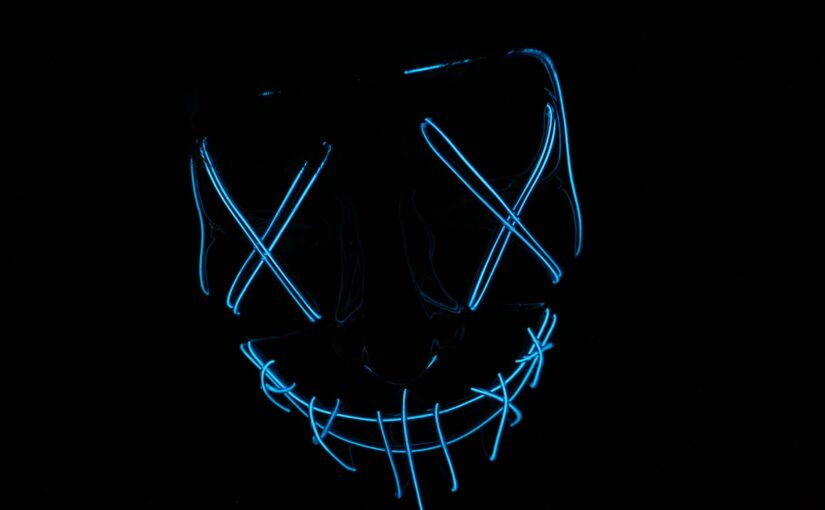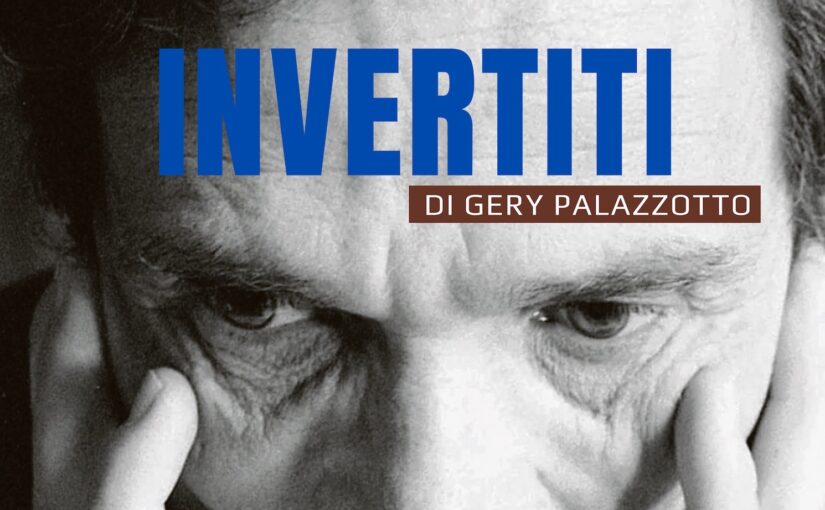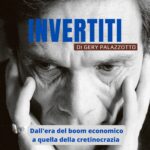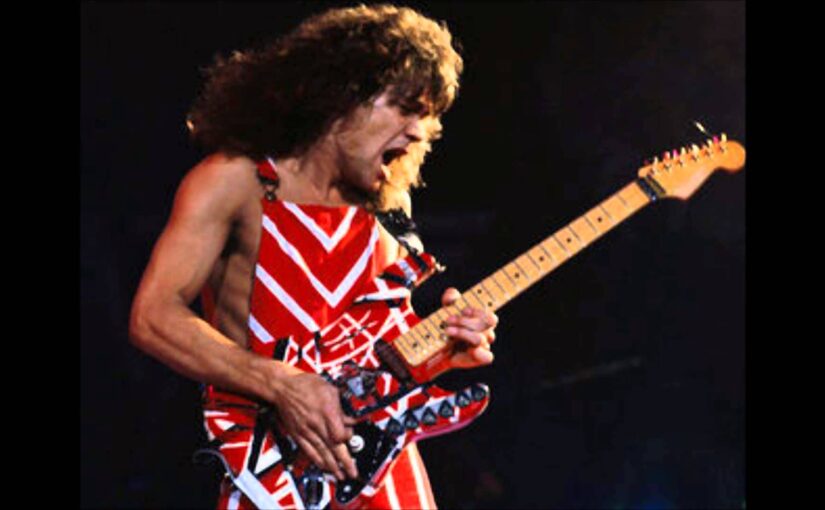Ho lavorato per oltre vent’anni al Giornale di Sicilia e me ne sono andato nel 2007, quando ho capito che non avevo più nulla da dire/fare in quel quotidiano. Ho lasciato in quella redazione, oltre a mille ricordi, molti amici e colleghi, compagni di avventure dentro e fuori i locali dell’azienda. Col tempo, alcune di quelle persone hanno maturato nei miei confronti un astio e un risentimento che ritengo ingiustificati. È vero, posso risultare colpevolmente poco simpatico per motivi che vanno dalle opinioni politiche alla scelta del vino (tipo: odio il Grillo). E poi sono insofferente a quei luoghi comuni che avvelenano la nostra socialità reale, quella analogica, e per di più sono da sempre mezzo vegetariano in un momento in cui i vegetariani si mangiano una bella fetta di carne… ops!. Tornando al Gds è anche vero che mi è capitato di criticare le scelte di una direzione ultratrentennale, di mettere in luce passi editoriali sbagliati, ma anche di solidarizzare con la redazione in momenti difficili e di salutare con gioia il nuovo corso. Qui trovate un bel po’ di materiale.
Nel tempo questi colleghi non hanno perso occasione di trattarmi con sufficienza (è un loro diritto, ma io ci sono rimasto male…), hanno detto schifezze di me (mai di persona, manco a dirlo), e soprattutto hanno boicottato alcune mie iniziative professionali sulle pagine della cronaca (iniziative che invece avevano paginate sui giornali nazionali, quindi qualcosa probabilmente valevano), come se tacere di un evento che può interessare ai lettori fosse uno sgarbo a me e non a chi quel giornale ancora coraggiosamente lo compra.
Non vi nascondo che la cosa mi ha addolorato perché credo di aver sempre anteposto il rispetto per il mestiere e per il diritto al lavoro alle normali critiche che si possono rivolgere a una testata giornalistica come a chiunque altro, che sia cronista o salumiere, magistrato o meccanico.
In Sicko di Michael Moore, documentario tosto sul sistema sanitario statunitense, il regista alla fine racconta la storia del suo principale detrattore, finito in difficoltà proprio per problemi di salute, che si vede recapitare una somma in denaro da un anonimo.
Nell’ottobre del 2020 qualcuno organizzò una colletta per supportare il comitato di redazione del Giornale di Sicilia in una difficilissima vertenza contro la nuova proprietà. Anche lì ci fu una donazione fatta da un tale, da uno che pareva non entrarci nulla, proprio per aiutare i suoi detrattori. Che ovviamente non ringraziarono mai. Ma questo, al netto della buona creanza, non conta.
Conta invece il motivo per cui oggi scrivo queste righe.
Perché ho ritrovato una lettera del dicembre 2003 scritta dal tenutario di questo blog all’allora condirettore del Giornale di Sicilia che aveva contestato l’eccessivo spazio (manco 60 righe) dato a un’iniziativa pubblica di Rifondazione Comunista contro una Commissione regionale antimafia sonnecchiante. Si parlava – udite udite – di Totò Cuffaro, allora presidente della Regione indagato per fatti di mafia e di Antonio Borzacchelli, uno che aveva un vissuto abbastanza complesso.
Insomma mi ero preso una cazziata dalla direzione per qualcosa che aveva a che fare con l’aria che si respirava e che ci avrebbe intossicato negli anni a venire (ma allora nessuno lo sapeva, c’erano solo una coscienza e un’etica professionale a guidarci, e sono cose che non vengono distribuite come i buoni pasto). Mentre io, in modo semplice e senza fare rivoluzioni, volevo respirare normalmente: insomma non volevo vivere intubato. Altro che eroismo, era roba di alveoli… Ognuno sceglie l’aria che si merita, in fondo.
Di lì a poco svuotai i cassetti e me ne andai per sempre: abbandonando un posto fisso e tuffandomi nel mare aperto dell’incertezza (non sono ricco di famiglia né avevo gli assi nella manica di molti miei colleghi, molto più lungimiranti di me, che venivano foraggiati da fior fiore di imprenditori molti dei quali, quelli più generosi, in odor di mafia). In più me ne sono sempre fregato di strumentalizzare accadimenti e convergenze astrali che sono stati la fortuna di chi era al posto giusto nel momento giusto a prescindere dal merito e dalla capacità professionale (su questo potrei scrivere un’enciclopedia e non è escluso che lo faccia quando troverò il tempo). Fregandomene li ho visti sfilare sulla passerella, onorati, riveriti, premiati, incensati. Parlo dei giornalisti, mica degli imprenditori. I giornalisti quando si mettono di impegno non sono secondi a nessuno per grottesco arrivismo, credetemi. Ma io, ormai, per incoscienza (e per culo) avevo preso nuove vie, avevo imparato a sbagliare da solo e mi inebriavo di una nuova vita da addentare con incosciente passione.
Comunque il preambolo è durato troppo.
Volevo dirvi che di questa lettera mi ero dimenticato per 19 anni, sino a oggi quando nel mettere ordine tra i miei files è venuta fuori.
Eccola.
Gli eventi degli ultimi tempi mi hanno indotto ad alcune riflessioni che ritengo importanti sul mio ruolo al Giornale di Sicilia.
Sabato 13 dicembre mi hai contestato verbalmente l’eccessivo spazio che, a tuo parere, abbiamo concesso alle polemiche sulla commissione antimafia regionale. Ne ho preso atto, nel rispetto dei ruoli, ma è mio diritto dissentire profondamente.
Ritenevo che la questione non fosse una roba che interessa “quattro o cinque persone”, alla luce dello spinoso caso Borzacchelli e dell’ancor più difficile caso Cuffaro. Ora, in una Regione in cui il presidente è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e in cui gli inestricabili circuiti del potere (politico, amministrativo, giudiziario) sono comunque chiamati dentro, non è per me facile muovermi senza regole chiare ed inequivoche.
Il ruolo e i passi della politica in quest’ambito (antimafia e dintorni) sono cruciali, si può registrarli o ignorarli. Farne trenta o cinquanta righe è un falso problema. L’iniziativa di Rifondazione comunista era, a mio parere, meritoria di attenzione: ho dato lo spazio che serviva per offrire al lettore cifre, dati, accuse, repliche, argomentazioni su un organismo al centro di forti polemiche in questi ultimi giorni (vedi Borzacchelli-Cuffaro). Si poteva registrarla o ignorarla.
Al di là di questo caso, la gestione delle notizie è, per quanto mi riguarda, ormai solo un mero esercizio di contabilità. Basterebbe una segretaria, perché sprecare denaro con un vice-caporedattore?
Il mio spazio di manovra è stato ridotto sempre più.
Ogni giorno il Giornale di Sicilia pubblica stralci, ampi e assolutamente sovradimensionati, di interviste ad assessori e politici (di schiacciante maggioranza polista) a Rgs. Ebbene, la maggior parte di questi titoli sono al futuro: “Faremo questo…”, “Ci impegneremo…”, “Risolveremo…”.
Questo, a mio parere, è il bla-bla politico. E sancisce, sempre più, un distacco, volontario e asservito, da ciò che non è allineato col governo regionale\provinciale\comunale.
Se così non fosse, vorrei capire come mai sabato scorso mi hai rimproverato di non esser stato informato preventivamente sulle 58 righe che riguardavano l’iniziativa di Rifondazione comunista (ampia replica compresa). Ogni giorno infatti l’intero giornale è intasato di “aperture” dove Cuffaro, i suoi assessori, Cammarata e compagnia bella dichiarano e promettono a più non posso. Eppure non credo che i colleghi dirigenti ti chiamino per informarti step by step sullo stato delle cose. Almeno io non lo faccio. La maggioranza di centrodestra dichiara, noi stampiamo. In automatico. E nulla mi è stato contestato, perché evidentemente piace così.
Mi è chiaro che la linea politica di un giornale la traccia il direttore, ma a questo punto ho bisogno di certezze.
Il fatto che la commissione regionale antimafia abbia fatto soltanto 13 sedute utili in due anni in una terra che non è Disneyland è una stupidaggine?
C’è stata una conferenza stampa, c’erano decine e decine di agenzie. Dovevamo ignorare l’avvenimento?
E potevamo farlo alla luce della nostra verifica sulla produttività dell’Ars?
C’è un caso giudiziario, l’ultima inchiesta su mafia e politica imbastita dalla Procura di Palermo, che rischia di esplodere con una potenza mica male. Lo dico molto chiaramente: il pericolo è che se scoppia una caldaia in quei palazzi, qualche mattonella viene giù anche da noi.
Il nostro cronista (…) vive in un clima di forte sovraesposizione. (…) è depositario di molti retroscena dell’inchiesta, ha letto verbali, ha proposto articoli e se li è visti bocciati o pesantemente emendati. Non entro nel merito della legittimità degli interventi voluti dal caporedattore centrale in persona di cui ho rispetto professionale.(…)
Update. Per un mio errore avevo sbagliato a digitare l’anno della lettera. La data corretta è dicembre 2003.
Mi piace:
Mi piace Caricamento...