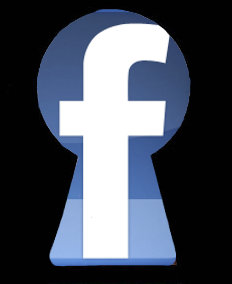Non potremmo concludere la nostra riflessione sulla rivoluzione obbligata del futuro senza parlare dell’informazione e della politica. Due argomenti che, in piena epoca di qualunquismo destrutturato e di superficialità al potere, destano sbadigli se non accoppiati a improperi, maledizioni e slogan manettari. Ma proviamoci.
Il grande errore dell’informazione negli ultimi due decenni è stato quello di cercare di domare la realtà. Che detta così sembra una cosa che ha a che fare con il sacrosanto dovere di stare alle calcagna della cronaca. Invece è diverso. Le aziende editoriali italiane non si sono dimostrate capaci di offrire una proposta flessibile, non sono state in grado di declinare il prodotto nelle infinite versioni a disposizione. Prendete il rapporto tra carta e online. Ci sono giornali che per salvare il cartaceo hanno sacrificato il loro contributo sul web: una follia peraltro perpetrata da anni in redazioni in cui i siti sono stati affidati a service o a collaboratori di scarsa qualità, quasi come se si trattasse di materiale di risulta. È un tema sul quale in queste pagine si dibatte da troppo tempo, quindi la faccio breve.
Il futuro del giornalismo è tutto nel saper guardare oltre la cronaca: e questo va bene come slogan.
Nel cogliere la rarefazione degli attimi in un fatto e nell’analizzarla come si fa con un video al rallentatore: e siamo più dentro la questione, no?
Ma affondiamo la lama.
Il futuro del giornalismo è tutto nel sottrarre una quota di tempo alla cronaca, quindi nel non dimenticare ciò che è stato ieri e nel non sforzarsi in vaticini fatti a pelle magari sulla scia dell’ennesimo sondaggio (e i sondaggi sono quanto di più distante ci possa essere dal futuro). Nel togliersi dalla testa ogni velleità di controllo delle masse (il “controllo delle masse” ricorda più un film di Woody Allen che un programma politico-editoriale) e nello sposare con orgoglio una forma di narrazione: soggettiva, parziale, non equidistante.
Il futuro se ne fotte del bilancino, le rivoluzioni si fanno con gli squilibri, cazzo. E di squilibri culturali, di scontri di idee, di collisioni di proposte c’è bisogno in quest’era di finti dibattiti, in cui la scelta è prevalentemente tra una constatazione di ciò che è reale e un anelito negazionista, tra un’ovvietà (però reale) e una palese cazzata.
Infine siamo alla politica.
La politica è il terreno di coltura di tutto questo. È il punto di partenza e quello di arrivo, è il battesimo e giorno del giudizio. Anche qui il fattore tempo conta. In politica la nostalgia è sconsigliata dato che il passato ha sempre una brutta sorpresa per chi vuole scavare. Ma manco il futuro scherza. Le recenti cronache ci insegnano che nemmeno il trito “largo ai giovani” funziona più: in Italia abbiamo deputati e ministri imberbi che sono riusciti a fare più casini dei vecchi democristiani incatramati di convergenze parallele e di polvere massonica.
Perché? Perché conta la visione, anzi la visuale, anzi la vista a corto raggio. Perché la rivoluzione obbligata del futuro dà al futuro mandato pieno per giudicare: e per arrivare al futuro è vincolante dichiarare che il presente è un investimento che può avere costi altissimi.
È come costruire una metropolitana in una città dalla mentalità medioevale (ce ne sono, uh!): anni di scavi, sacrifici per i cittadini, disagi tremendi, polvere, clacson, soloni urbanisti, cialtroni urbanisti, cialtroni e soloni senza specializzazione. Si paga oggi per ciò che servirà domani. E la verità è che il politico che si impegna a prendersi i fischi e gli improperi per quei lavori si sta curando del futuro di quegli stessi cittadini che lo maledicono. Ma è complicato da spiegare se non esiste una mentalità che inquadra le cose nel loro divenire e le fotografa e basta.
È la politica che ci dice chi siamo, non viceversa. Il movimento più avveniristico che la sorte ci abbia elargito, proprio in questi giorni, si è arreso dinanzi alla più antica delle cause di separazione, i soldi. Ecco il Movimento 5 Stelle è l’esempio di come non si fa, quando si parla di futuro. Perché è un fenomeno costruito sulle peggiori (e pericolose) illusioni: che una cosa nuova sia ontologicamente migliore; che la tecnologia al servizio della democrazia sia una garanzia di qualità; che il sapere sia una palla al piede per volare verso il domani.
La rivoluzione obbligata del futuro parte dove finiscono le certezze, anche fondate, dietro le quali ci siamo messi al riparo sino a oggi.
Non è una scommessa, è una scelta consapevole. Soprattutto non si fa a piccoli passi, ma con falcate decise. Non serve coraggio, ma conoscenza. E consapevolezza che i soliti noti faranno le solite cose. Gli altri – inclusi quelli che sbaglieranno – faranno cose interessanti.
Il futuro è un delizioso mostro che si nutre di cose interessanti.
3 – fine





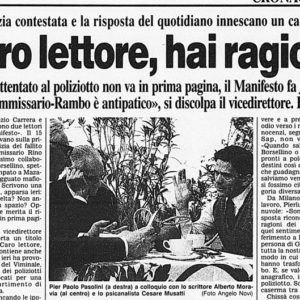
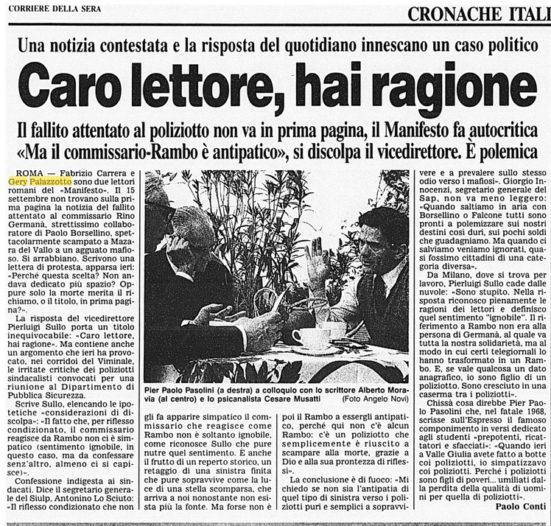
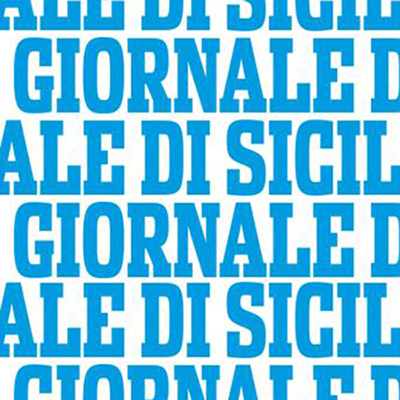 Due, tre cose sul Giornale di Sicilia e sullo sciopero che da giorni sta tenendo lontano il quotidiano di Palermo dalle edicole.
Due, tre cose sul Giornale di Sicilia e sullo sciopero che da giorni sta tenendo lontano il quotidiano di Palermo dalle edicole. Se ti accorgi che stai scrivendo più di morti che di vivi ci sono due cose da fare. Congratularti con te stesso perché ancora sei di questa terra e brindare alla salute di quelli di cui ancora non hai scritto. Ecco, questa è una tipica frase che avrebbe scritto
Se ti accorgi che stai scrivendo più di morti che di vivi ci sono due cose da fare. Congratularti con te stesso perché ancora sei di questa terra e brindare alla salute di quelli di cui ancora non hai scritto. Ecco, questa è una tipica frase che avrebbe scritto