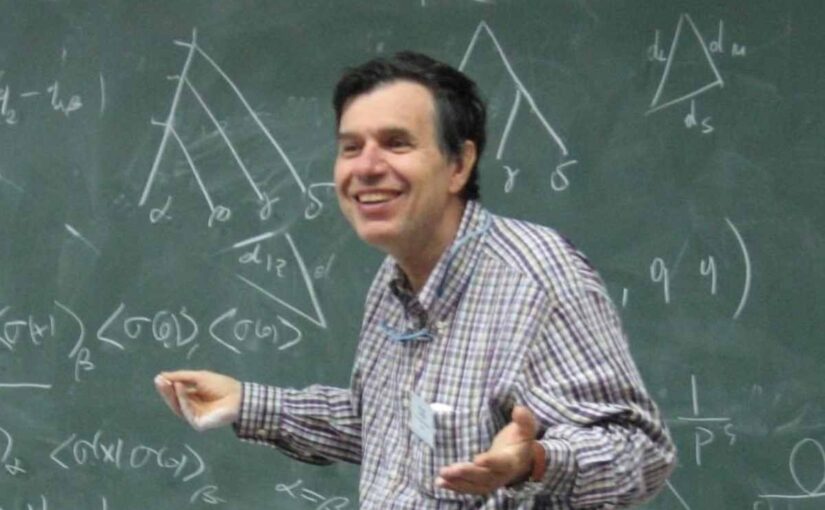Mi sono più volte schierato per il diritto di non perdono, per quello di essere faziosi, contro ogni forma di buonismo d’acchito, persino per il diritto di odiare.
Ma quest’odio social, odio liquido quindi praticamente fine a se stesso (i sentimenti manifestati hanno una loro ragione di essere se avviluppati in un ragionamento, altrimenti sono peti dell’intestino psichico) è insopportabile. Perché si accanisce, nello specifico di Filippo Turetta, su un bersaglio immobile, che si è già arreso, sul quale non c’è possibilità di argomentazione oltre l’onanismo del “buttate la chiave” salviniano.
Non c’è bisogno di martoriare le carni di un morto vivente, per di più giovane. E non c’è vergogna a provare umana (e cristiana, per chi ci crede) pietà.
Siamo sempre pronti a mostrare i nostri opposti su queste timeline, felicità o dolore, odio o amore, fiducia o diffidenza. E ci dimentichiamo la più grande lezione della vita, per chi ne ha una fuori da qui: il contrario dell’amore non è l’odio, ma il dubbio (cit).
Tag: odio
La frase più pericolosa
A un certo punto arriva il momento cruciale. Quello in cui ti scontri con la fatidica frase: “Abbiamo sempre fatto così”.
È, come annotò Grace Murray Hopper, la frase più pericolosa in assoluto.
Di momenti cruciali è fatta la mia vita e, non stento a crederlo, anche la vostra. Ma ogni volta che sento quella frase, suona dentro di me un campanello.
Dove ho sbagliato?
E mi viene voglia di scappare su un altro pianeta e aspettare che mi passi confidando che non mi passi perché le nostre scelte più ardite sono sempre un passo sulla corda tesa che si muove lentamente nel vuoto, e il vuoto attrae e respinge, attrae e respinge fino a quando non c’è più: perché lo hai superato o lo hai raggiunto.
“Abbiamo sempre fatto così”.
È peggio di “non si può fare”, poiché non trancia con presunzione, ma giustifica col peggio che si possa usare quando c’è di mezzo il nuovo: la consuetudine, cioè il veleno delle idee.
Quando Italo Calvino scrisse le sue “Lezioni americane” non c’era internet, non esistevano i personal computer e neanche i software per scrivere testi, come quello che sto usando in questo momento.
Apro una parentesi. Le “Lezioni americane” è il libro che mi ha cambiato la vita. Lo lessi molti anni fa durante una spedizione in alta montagna e ricordo ancora l’effetto shock che ebbe sulla mia mente che pure era felicemente impegnata tra salite in ghiacciaio e discese in fuori pista. Chiusa la parentesi.
In questo prezioso saggio Calvino consiglia di ripulire la scrittura dalla pesantezza, dall’inerzia e dall’opacità del mondo, spezza una lancia a favore delle forme brevi, esalta a usare la scienza e le belle arti come paradigmi di simmetria e precisione del linguaggio, butta ponti tra l’immaginario e le immagini per conferire all’aspetto visivo uno status letterario. Fa anche un sacco di altre cose, ma magari ve lo leggete e se non avete di meglio da fare ne parliamo.
Insomma Calvino anticipa l’importanza dei blog, delle sceneggiature delle serie tv, persino dei post sui social network, come se li avesse previsti. Perché era profondamente convinto che il nuovo millennio sarebbe stato tecnologico.
Chi sarebbe stato il suo peggiore nemico?
Uno che avrebbe detto: “Abbiamo sempre fatto così”.
Oggi in piena era di restaurazione – l’ignoranza colpevole al pari dell’ignavia è una pena grave dinanzi al tribunale dell’innovazione – il ritorno agli antichi riti nella politica, nella cultura, nella finta egemonia sociale del mainstreaming è cosa fatta.
Si rimpiange il passato, soprattutto quello mefitico, per nascondere la paura per il futuro.
Si alza la polvere per confondere, senza tener conto che alla prima pioggia quella polvere diventerà fango.
Si usa la modernità per sfornare medaglie da appendere a petti anziani che nulla sanno di quei metalli e delle fatiche per forgiarli.
Spegnere scintille di novità è il compito dei poliziotti al servizio della grettezza. L’arte, ricordiamocelo, è perenne ostaggio dei tiranni di ieri e di oggi, che abbiano artigli o server, armi atomiche o “bestie” da social media. La politica, con quel che ne consegue, va difesa da violenti e algoritmi con una mossa semplice: rinnegare chiunque pronunci quella frase.
Prima del sonno della ragione c’è lo sbadiglio. E ci sono troppe facce sformate intorno a noi.
Più ingiustizia per tutti
Da decenni viviamo in una quarta dimensione in cui vige, indecente, l’illusione che tutto sia possibile se solo lo vogliamo. Cittadini al governo come liberazione dalla disonestà della politica, scienziati del web che deridono scienziati delle università, promulgatori della violenza come atto di nonviolenza, elargizioni a pioggia a chi non ha intenzione di lavorare e se lavora lo fa in nero (in modo da avere un doppio stipendio), dilettanti sul ponte di comando e professionisti umiliati a vogare, premialità senza merito, ultima parola al più prepotente, applausometri dell’odio, killer della speranza travestiti da monaci della Nuova Verità Rivelata.
Siamo circondati da parole finte, drogate, ingannevoli.
Si tenta in ogni modo di farci credere che la verità sia anfibia, quando anche un bambino sa che così non può essere: la verità anfibia è un inganno sopra e sotto il livello del mare. È la violenza strisciante del “sì però”: di fronte a un evento incontestabile e indiscutibile nel quale c’è da ammettere solo una sconfitta, si erge il totem del “sì però” a rimestare nelle certezze per alzare polvere o impastare fango.
Non è vero che è sempre stato così. Così come non è vero che si stava meglio quando si stava peggio. Però è vero che il livello di mistificazione politica e sociale negli ultimi trent’anni è cresciuto esponenzialmente.
Per questo un Nobel come quello al professor Giorgio Parisi (tra parentesi un uomo bellissimo nel suo candore fisico e intellettuale) oggi è una pietra nello stagno ghiacciato.
Perché provoca e rompe, consola e squassa.
Perché ci accarezza i pensieri con un’antica certezza: il merito conta ancora, il merito vince, il merito non è demerito. E andando controcorrente rispetto alla politica maggioritaria di questo paese, ci dice che un fisico che si è fatto un mazzo così per tutta la vita può ancora valere di più dell’improvvisatore social che decide di farsi un nome sposando idee balzane, salendo su palchi balzani, contando su intervistatori balzani e conquistando l’intestino retto dell’Italia.
Servono unità di misura e metri attendibili.
Serve una dittatura del merito in cui sta avanti chi sa. Gli altri dietro (possibilmente in silenzio).
Se dare la parola a tutti significa che tutti possono ciarlare impuniti, serve un po’ di ingiustizia: meno libertà, anzi “libertà”, per tutti.
Questo significa per me il Nobel a un grande fisico italiano nell’anno di grazia 2021.
Odio, fenomenologia del contagio
L’articolo pubblicato sul Foglio.
Attenzione alle parole: “Non dormo più la notte da quando mi sono resa conto di cosa ho fatto, non dovevo insultare in quel modo su Facebook il capo dello Stato”. E ancora: “Era un periodo molto caldo, in cui gli animi erano surriscaldati da alcuni parlamentari dei Cinque Stelle di cui ero simpatizzante. Mi sono lasciata contagiare stupidamente da questi fatti. Io che sono madre, nonna, amante della pittura e degli animali”.
Sono alcune frasi pronunciate davanti ai magistrati di Palermo da Eliodora Elvira Zanrosso, 68 anni, una degli scriteriati che scrissero oscenità sui social network sul presidente Mattarella dopo che questi, nel maggio 2018, aveva respinto la nomina di Paolo Savona come ministro dell’Economia. La signora in questione è un prototipo perfetto dell’hater moderno giacché fornisce con la sua testimonianza tutti gli elementi che servono a identificare una fenomenologia dell’odio e del suo contagio.
In mezzo agli infiniti interrogativi su come sia possibile che una tranquilla persona “madre, nonna, amante della pittura e degli animali” si trasformi in una guerrigliera della volgarità, che al confronto “Napalm51” di Crozza è un monaco benedettino, scrivendo a Mattarella “Ti hanno ammazzato il fratello, cazzo… non ti basta?”, sorgono due certezze. La prima è che nulla di tutto ciò nasce in rete. La fonte dell’odio è sempre esterna al web ed è legata a un vento di irrazionalità e di incoscienza che soffia sul mondo delle cose reali, analogiche, sulle promesse della politica, sulle disparità di economie dissennate. Qualcosa di molto simile a una moda che si diffonde orizzontalmente calpestando culture, religioni, identità nazionali. Prendiamo il piercing, una pratica antichissima, addirittura preistorica, che serviva per marcare le differenze, i ruoli, tra i componenti di una tribù e che oggi, al contrario, è simbolo di omologazione: averlo significa essere nella tribù, aderire alla convenzione, vivere appieno il tempo in ci si è catapultati. Il piercing è una moda che è contagio fine a se stesso, senza ragione, senza storia. Esattamente come accade con l’odio.
La seconda certezza è che l’anonimato non più ha alcuna influenza sulla fabbrica della violenza verbale. Sembrano passati millenni dalle vecchie lettere minatorie, da quei messaggi costruiti con i ritagli dei giornali, simbolo di un artigianato della minaccia che ormai appare grottescamente desueto. Oggi tutto è in chiaro, esplicitamente vomitato. Pudore e paura – pudore nell’esporsi in una nudità di cattiveria, paura per le conseguenze che l’atto offensivo può innescare – sono seppelliti dall’impeto del clic: il mouse come una bomba molotov, la tastiera come la P38. I nuovi odiatori si mostrano col loro volto, sorridenti nel tinello, col gatto sulle ginocchia e il nipotino che dorme accanto. La pulsione li coglie alle spalle, senza quasi che se ne rendano conto.
Nel 1977 Don Siegel girò un film intitolato “Telefon”, il cui soggetto era tratto da un romanzo di due anni prima di Walter Wager. Si raccontava di un nutrito gruppo di spie sovietiche infiltrate negli stati Uniti, durante l’epoca della Guerra Fredda. Queste persone però non sapevano realmente di essere agenti segreti poiché erano state condizionate mediante lavaggio del cervello. Agivano e pensavano come perfetti cittadini statunitensi pur essendo inconsapevolmente pronte a svolgere il ruolo per cui erano state manipolate. L’impulso che attivava la loro volontà criminale arrivava per telefono ed erano alcuni versi di una poesia di Robert Frost, “Stopping by Woods on a Snowy Evening”: “I boschi sono belli, oscuri e profondi, ma ho promesse da mantenere e molte miglia da percorrere prima di dormire… molte miglia da percorrere prima di dormire”. In tal modo cittadini apparentemente innocui si trasformavano in sabotatori suicidi, che nulla ricordavano sin quando era troppo tardi.
Ora rileggiamo le dichiarazioni della signora Zanrosso: “Non dormo più la notte da quando mi sono resa conto di cosa ho fatto”: la sabotatrice che si risveglia.
“Era un periodo molto caldo, in cui gli animi erano surriscaldati da alcuni parlamentari dei Cinque Stelle di cui ero simpatizzante”: il meccanismo di attivazione.
“C’era Grillo che gridava da una parte, Di Battista dall’altra. Dicevano: prepariamoci a scendere in piazza. Buttiamo giù tutto il governo”: la paradossale chiamata in correità.
Tutto nel rispetto delle regole irregolari del contagio dell’odio. Ma il vero colpo di teatro non è il risveglio tardivo dell’”agente Zanrosso”, bensì il suo uno e due, il suo essere se stessa e un’altra.
Se fosse un film sarebbe trama poco plausibile, ma è la realtà e ci si butta senza rete. “Ti hanno ammazzato il fratello, cazzo… non ti basta?”, ringhia la nonna sui social. Ma dopo l’interrogatorio in Procura si materializza il suo alter ego: “Io li ho vissuti gli anni Ottanta, so chi era Piersanti Mattarella, il fratello del capo dello Stato. Voglio andare dal Presidente, voglio chiedere scusa”.
Dobbiamo ancora imparare a riconoscere i danni provocati da questo virus contagioso, però abbiamo piena contezza del sintomo principale: lo sdoppiamento di personalità.
La domanda cruciale è: da dove origina tutto ciò?
Per cercare di capire dobbiamo andare indietro nel tempo, almeno sino al 1922 quando Walter Lippmann, premio Pulitzer, pubblica un saggio dal titolo “Public Opinion” in cui spiega come le idee dell’opinione pubblica possano essere distorte con relativa facilità. La sua tesi è che l’opinione il più delle volte non rispecchia la realtà, troppo complicata per essere capita. Inoltre questa dipende dallo pseudo-ambiente esterno che ogni individuo si costruisce in base a pregiudizi e in maniera più emotiva che razionale. Il concetto cardine di Lippman è lo stereotipo sociale, cioè una visione distorta e semplificata della realtà, una galleria di immagini mentali che ci costruiamo per semplificare il mondo e per renderlo a noi comprensibile. Che sfoci nel ciclone Black Friday o nel dichiarazionismo forzato della Giornata contro la violenza sulle donne, il contagio della mobilitazione a mezzo social può contare su un abbassamento delle difese immunitarie del nostro libero arbitrio. Facciamo cose senza crederci: condivido ergo sum.
Col tempo affiorano nuove tecniche, sempre più raffinate, per plasmare come creta l’opinione pubblica. Si arriva così al grande inganno della sondocrazia, cioè quel falso modello di democrazia in cui la politica finge di governare per cambiare la società basandosi su “quello che la gente vuole”. È il modello demagogico attualmente in voga su Facebook e similari, che insegue persino le pulsioni più insane dell’opinione pubblica, stimolandole, per poi svolgere il vero ruolo, quello diabolico, di persuasore occulto.
Bobby Duffy, professor of Public Policy, direttore del Policy Institute presso il King’s College di Londra e soprattutto ex direttore generale della società di ricerche Ipsos, ha lavorato a lungo per studiare i rischi della distanza tra percezione e realtà (ci ha scritto anche un libro, “The perils of perception”) e lo scorso anno ha scoperto che gli italiani sono quelli che stanno peggio al mondo. “Hanno ipotizzato che il 49 per cento dei connazionali in età lavorativa fosse disoccupato, mentre in realtà si trattava del 12 per cento. Hanno valutato che gli immigrati fossero il 30 per cento della popolazione, quando la cifra reale era del 5 per cento. Hanno ipotizzato che il 35 per cento delle persone in Italia avesse il diabete, quando in realtà è solo il 5 per cento”, ha scritto. Ma non finisce qui. In Italia tendiamo a sovrastimare anche il tasso di criminalità, i livelli di obesità, perfino la percentuale degli ultrasessantacinquenni tra noi.
Con un’opinione pubblica così, tutto è più complicato. O più semplice. Dipende dai punti di vista. Complicato per chi cerca di rimanere aggrappato ai fatti, semplice per chi li gestisce tramite la sondocrazia magari per sfruttare percezioni più utili per i suoi scopi.
Il quadro eziologico del nostro contagio adesso è più chiaro.
C’è un virus dell’odio che giova a una certa classe dirigente.
C’è un vettore social dell’infezione, tipo zanzara con la malaria.
Ci sono gli untori, cioè gli spargitori (o spammatori?) del male.
E poi c’è il precario stato di salute del corpo nel quale si diffonde l’infezione, un Paese gravemente fiaccato dall’analfabetismo funzionale: i dati della più importante indagine di settore, lo studio Piaac, collocano l’Italia al quarto posto di questa triste classifica mondiale con il 28% della popolazione adulta “incapace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità”.
Schematizzando. Siamo un Paese in cui molte persone hanno pochi strumenti, o se li hanno non li sanno usare, per barcamenarsi in una realtà oggettivamente complessa, e che quindi cercano una scorciatoia per sentirsi adeguate: vanno a caccia di short-version magari condite con un’abbondante dose di emotività, che le aiutino a sentire quel che non sono in grado di capire. Ciò al netto del famoso effetto Dunning-Kruger, un bug cognitivo secondo il quale meno le persone sanno più presumono di sapere, causa di danni irreparabili soprattutto in sovrapposizione col dilagare di un’incompetenza talmente profonda e radicata da non arrivare neppure alla soglia della consapevolezza.
C’è infine la questione controversa della filter bubble cioè della bolla di filtraggio: gli algoritmi dei social media ci porgono prevalentemente contenuti che potrebbero piacerci, e che quindi confermano le nostre opinioni. Ma su questo fenomeno esiste una fronda di osservatori del web che tende a minimizzare gli effetti del filtro rinviando ai comportamenti della vita reale: in fondo anche quando la sera usciamo a cena scegliamo di andare con persone scelte sempre nella stessa cerchia di amici e conoscenti.
Quando Manlio Cassarà, un altro degli odiatori di Mattarella sotto inchiesta a Palermo, ebbe il suo “risveglio” dalla trance di violenza verbale che gli aveva ispirato un “hanno ucciso il fratello sbagliato”, la prima cosa che disse fu: “Ho scritto senza riflettere”. Confermando un concetto di libertà applicato ai social secondo il quale un’opinione è tale solo se esce dall’orifizio giusto.
Anche la nonna emula di Napalm51 nel suo “risveglio” ha usato un simile argomento a sua discolpa: “Ho quasi 70 anni, faccio parte di quella generazione che non è certo composta da geni della tastiera, ho la terza media, sono istintiva. È stata la mia inesperienza, eravamo tutti su di giri in quel momento”.
L’idea di far passare per frasi buttate così, pseudo-argomentazioni violente e offensive è purtroppo un effetto secondario, ma non meno pernicioso del virus. Perché non esistono scuse che possano far rimarginare la ferita quando è il contagio che determina il destino di una teoria, anche la più balzana, non la sua validità.
La via giudiziaria contro gli odiatori del web
 L’articolo pubblicato oggi su la Repubblica.
L’articolo pubblicato oggi su la Repubblica.
L’inchiesta giudiziaria della Procura di Palermo contro i farabutti che, il mese scorso, presero di mira con insulti e minacce sui social il presidente Mattarella nel caos della formazione di un nuovo governo, è un raggio di sole nel buio della nullocrazia. La crisi di valori che questo Paese sta vivendo è strettamente legata a un potere che si alimenta di odio compulsivo e uso fraudolento dell’incultura. Trascinare davanti a un giudice e condannare chi offende e infanga sul web come se l’impalpabilità dei byte concedesse una sorta di impunità, significa ricordare a tutti, cittadini reali e patetici avatar, che l’ignoranza se è colpevole deve essere punita in modo esemplare. Sinora, con eclatanti esempi internazionali, la maggior parte dei tentativi di riallineamento della realtà dei social network con quella, vera, dei diritti e dei doveri è fallita. La via giudiziaria è l’ultima spiaggia per scardinare le echo-chambers degli odiatori. Per ripartire da una regola semplice delle vite non qualunque: la volgarità è una scorciatoia, la dignità è una fatica.
Nuova malvagità democratica
L’articolo pubblicato sul Foglio.
Ha viaggiato dal Regno Unito alla Norvegia, dagli Usa alla Russia e al Libano. Ha incontrato, tra gli altri, un uomo che minaccia di uccidere gli immigrati, una ragazza che ce l’ha a morte con Lady Gaga, un sostenitore di Trump che vorrebbe Hillary Clinton in cella e una russa secondo la quale c’è un piano dei gay per conquistare il mondo. Kyrre Lien, giornalista che vive a Oslo, ha indagato per tre anni sull’odio in rete. Coi risultati della sua inchiesta ci ha fatto un documentario intitolato “The internet warriors” cercando di discutere con “persone che passavano ore e ore a scrivere commenti online” una delle quali, una sorta di recordman, ne aveva postati più di mezzo milione. Da questa esperienza Lien ha tratto due profili di haters: “Quelli che odiano perché sono disoccupati e hanno tanto tempo a disposizione o perché hanno un livello culturale molto basso, e quelli che in qualche modo si sentono trascurati”.
Sin qui tutto straordinariamente normale, come normale è la trazione cardanica delle frustrazioni nell’anno di grazia 2018 e straordinario è il boost di carburazione dei social network.
Obama, Renzi e la stele dell’ignoranza

Guardando la diretta Facebook della conferenza stampa congiunta di Barak Obama e Matteo Renzi mi ha colpito un dettaglio ormai non più secondario: i commenti degli utenti italiani. Tutto un miscuglio di schifezze, di offese a raffica, di qualunquismo becero. La frase più ricorrente, piena di una violenza subliminale, strisciante come quella dettata dalla non conoscenza, è: tornatene a casa che abbiamo problemi più gravi.
Non funziona così. Non funziona così da nessuna parte del mondo civilizzato. A parte quel briciolo di orgoglio nazionale che dovrebbe accompagnare il capo di un governo, un governo qualsiasi purché sia vagamente democratico, nelle sue missioni diplomatiche, c’è una ragione molto più valida per ritenere gli attacchi a raffica all’istituzione (badate, non parlo di Renzi come persona) un esempio di somma inciviltà: il criterio della rappresentatività.
Si può essere d’accordo o no con un governo, si può aver votato o no la parte politica che decide le nostre sorti, ma non si può dileggiare un’istituzione nel momento in cui fa l’istituzione. Persino con Berlusconi, che era un impresentabile guascone, l’asticella dell’odio gratuito era più alta. Con Renzi, nell’epoca in cui tutti sanno tutto perché non si occupano altro che del dire su tutto, questa vergogna italiana – perché lo sapete che è una tipicità italiana, vero? – ha raggiunto il suo apice. Sino a quando non saremo un popolo unito davanti ai suoi simboli, saremo solo l’eterna regione ai confini dell’impero. Sino a quando non impareremo che il dissenso non è offesa e dileggio, ma ragionamento e strategia, saremo solo un’accozzaglia di nickname sulla stele che più ci meritiamo. Quella dell’ignoranza.
Minimo elogio dell’ira
Adirarsi è facile, ne sono tutti capaci, ma non è assolutamente facile, e soprattutto non è da tutti adirarsi con la persona giusta, nella misura giusta, nel modo giusto, nel momento giusto, e per la giusta causa.
Aristotele
“Etica a Nicomaco”, in “Opere”
Ho frequentato l’ira per qualche tempo (buio) della mia vita. Tuttora combatto per liberarmene in modo definitivo, e non sempre vinco.
Tuttavia trovo che, specie coi tempi che corrono, si tenda a raffreddare gli animi più per intorpidirli che per ricondurli a migliore ragione.
E’ vero, l’ira, a differenza dell’aggressività e dell’odio, non siede al tavolo della razionalità, non si ciba della padronanza delle azioni.
Fare a meno dei sentimenti estremi e autolesionisti è certamente cosa sana e giusta.
Non so che ne pensate, però secondo me bisognerebbe rivalutare il concetto di giusta misura (o modica quantità) dell’ira tanto per salvaguardare un certo mondo di valori che non ha bisogno di sorrisi patinati, di finta calma, di acquiescenza forzata, di ipocrita democrazia, di civilissima noia.
E’ vero l’ira è cieca e acceca.
Come l’amore, però.
Signor sindaco, pensi a governare
Diego Cammarata, in un’intervista al Giornale di Sicilia, dice che a Palermo c’è una campagna di odio contro di lui o i suoi accoliti orchestrata da “certi blog”.
La sua dichiarazione stimola due riflessioni (ed è già un bel record se si tiene conto che solitamente il suo verbo è un antidoto prezioso contro l’insonnia).
Il ricorso alla scusa dell’odio, come più volte abbiamo scritto, è un escamotage per non darsi la pena di argomentare. Il sentimento che si fa ragione sociale è un totem alla scarsezza della politica: quando non si sa cosa dire, si dice che c’è il male, che il diavolo esiste e che se le cose non vanno bene la colpa è dei cattivi.
L’odio delle lotte di classe, l’odio che arma il simile contro il meno simile è un’altra cosa, appartiene a un’altra (brutta) epoca e ha un’orribile caratteristica: fa solo vittime collaterali. In ogni caso, quindi, se mai esistesse il sentimento sociale di cui blatera Cammarata, lui dovrebbe ritenersi salvo e i più preoccupati dovremmo essere noi.
Il secondo punto su cui vi invito a riflettere è questo: il sindaco di Palermo identifica in “certi blog” (chissà quali…) l’origine di tanto odio. Anche questo è un tema di cui abbiamo discusso nel corso degli anni. C’è nelle comunità internettiane una componente particolarmente aggressiva e anche un po’ vigliacca che usa termini violenti, che non conosce argomentazioni civili e che si crede forte solo in virtù di un presunto anonimato. Ma è un gruppo di minoranza che è quasi sempre bannato dai blog seri. Quindi ha un peso irrilevante nella genuinità delle opinioni che circolano online.
Perché allora Cammarata accusa i blog? Badate bene, credo che sia la prima volta che il sindaco di Palermo ci additi pubblicamente come i veri colpevoli di chissà cosa.
Cammarata sa che ormai non può più contare sull’appoggio della stampa ufficiale, da sempre addomesticata alle esigenze del Palazzo, ed è costretto a rispondere alle crescenti lamentele, alle contestazioni, alle proteste. Una bella fatica. Però, siccome le critiche più puntuali gli arrivano dal web, l’unica arma che gli è rimasta per difendersi è quella della delegittimazione della sola forza di opposizione seria che esiste in questa città: quella dei blog.
Signor sindaco, qui nessuno ha fatto e farà nulla di male. Il dissenso non c’entra col codice penale e ancora meno coi sentimenti. I blog sono una risorsa, non l’inferno.
Vada avanti e governi serenamente con la trasparenza che la caratterizza.
Trasparenza fisica, intendo.
L’uomo che non conosce vergogna
Se il neo ministro Brancher avesse voluto sottolineare la propria emancipazione da un vizio odioso come il sospetto di una nomina clientelare (una nomina a ministro, mica un incarico in una municipalizzata), tutto avrebbe dovuto fare tranne che pronunciare la consumata formula “contro di me solo odio”. Perché quello dell’odio fatto partito – come se un sentimento potesse essere ghettizzato a componente politica – è un grottesco ritornello del suo padrone e correo. Insomma un modo – il più banale – per compromettersi definitivamente
Nei romanzi gialli, il meccanismo più trito prevede che uno dei sospettati si tradisca pronunciando una frase o richiamando una circostanza che riporta al movente del delitto. E’ una sorta di ciambella di salvataggio che l’autore del libro lancia verso se stesso quando non sa come far quadrare una storia: ovviamente poi se ne vergogna.
Solo che Brancher non è uno scrittore, non è un personaggio di fantasia, e soprattutto non appare geneticamente in grado di provare vergogna.