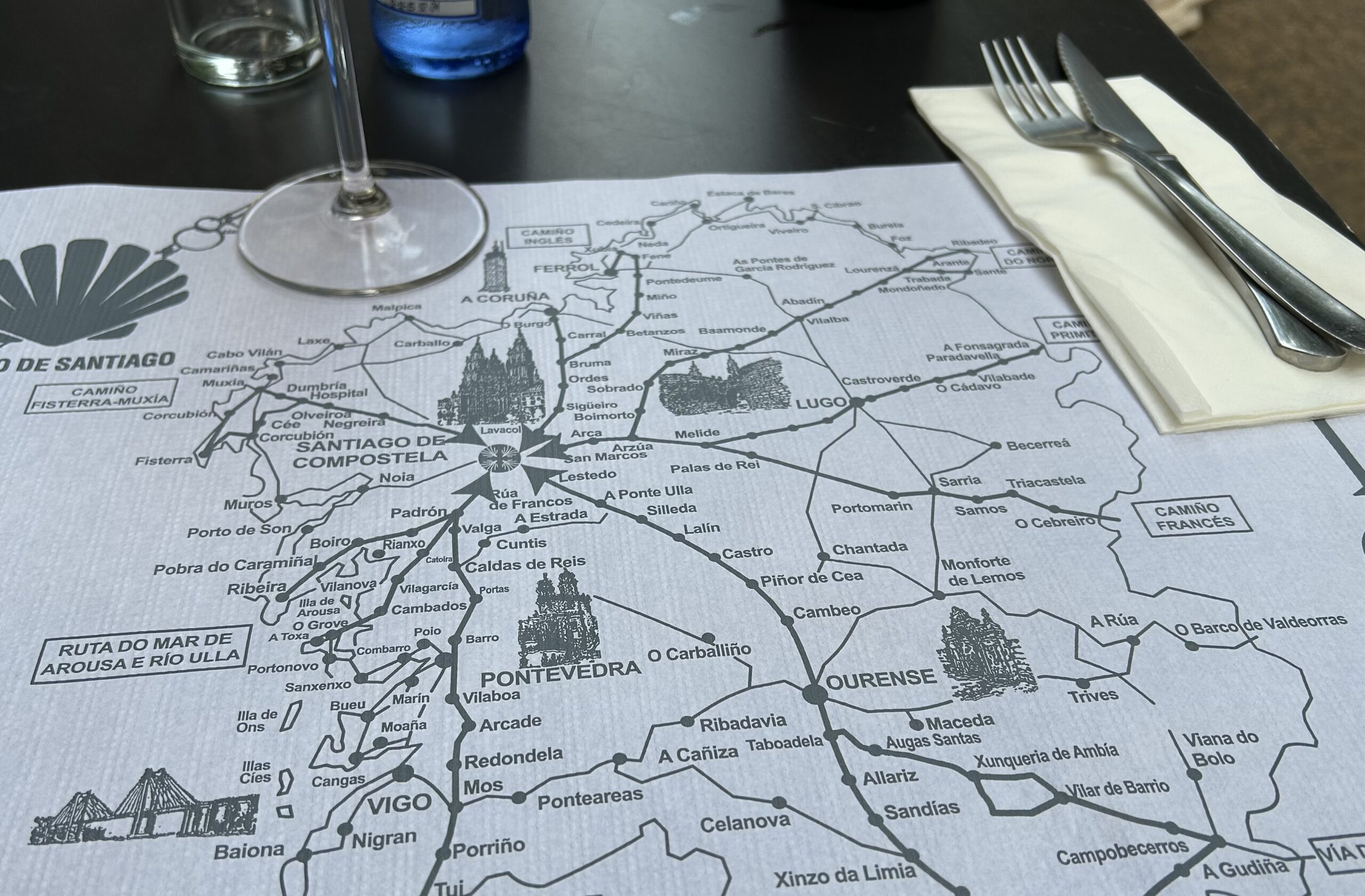Caldas de Reis – Padron
Padron – Santiago
Ogni volta che concludo un viaggio avventuroso, che per me significa faticoso, mi ritrovo sempre più ricco di una cosa che viene sottovalutata e che si chiama fatalismo. Mi dico, anche stavolta è andata, nonostante la mia pericolosa (al limite del patologico) tendenza ad alzare l’asticella quando, come età anagrafica impone, dovrei invece ipotizzare una strategia opposta. Poi mi chiedo: fin quando potrò dar sfogo alla mia curiosità in questo modo non troppo ordinario? E lì entra in campo il fatalismo, forte anzi rinvigorito: il migliore modo di rispondere a certe domande è non porsele.
Questo Cammino Portoghese, ancora più degli altri, non è stato solo un affare muscolare. Anche se senza allenamento 700 chilometri con 11 chili in spalla (acqua esclusa) ti portano a Santiago solo se fai il giro largo da Lourdes ed esce il tuo nome nella lotteria dei miracolati. Un coach parlerebbe di motivazione, io molto più semplicemente tiro in ballo l’atto più egoistico che dovremmo imparare a considerare senza timidezza, la determinazione. E non si tratta banalmente di voglia di vincere: qui non si vince un cazzo e anzi gli amici ti prendono affettuosamente per il culo dai loro ritiri vacanzieri umanamente normali, indecisi se trattarti da squilibrato o inserirti come pastorello ramingo in un quadretto naif.
La determinazione non è che funziona solo nei massimi sistemi cinematografici dove c’è quello\a che ce la fa nonostante tutto, e più il nonostante tutto è poderoso, più l’effetto sorpresa funziona. Nossignori, c’è una determinazione ordinaria che sta nelle piccole anzi minuscole cose e che si annida in preziosi angoli di resistenza.
Ad esempio sto scrivendo da un mese su una tastiera collegata al mio iPad mini che sovverte i canoni di una tastiera normale (nella posizione delle lettere, nell’uso di tasti funzione, nella dimensione e dinamica dei tasti). Per chi scrive per mestiere è come cambiare il martello a un fabbro, i fornelli a un cuoco, l’auto a un pilota. La pazienza non basta, serve determinazione. Ma questo è niente.
In queste ventotto tappe ho dormito (tranne che a Porto) ogni sera in un posto diverso. Mi sono trovato in alberghi affollati e in pensioni sperdute, ho dormito in antiche dimore nobiliari e in residenze per anziani dove ero il più giovane della compagnia, ho cenato in resort e in bettole, ho combattuto con gli scarafaggi in stanza e ho dormito in letti inutilmente grandi, ho bevuto grandi vini e per evitarne di pessimi mi sono strafatto di Coca Zero.
Ho succhiato 42 gelati “Solero” (quasi uno e mezzo al giorno) e non mi chiedete perché. Io che detesto i gelati ho trovato la mia convergenza perfetta tra caldo, stanchezza e cazzi miei in questa specie di ghiacciolo dal gusto esotico indefinito: quando il cammino si faceva pesante e mi trovavo a corto di energie, al primo bar o emporio a tiro mi facevo un “Solero” (1,60 euro di succoso colorante). Ho svuotato e riempito lo zaino ogni sera e ogni mattina, come se sgranassi un rosario, cercando di smarrire solo il superfluo: alla fine ho perso solo un pezzo di sapone di Marsiglia e non ci ho dormito una notte come se fosse un’esclusiva del supermercato sotto casa mia. Un’altra volta ho dimenticato il portafoglio nell’unico taxi che ho preso e l’ho ritrovato senza che il conducente se ne fosse accorto.
Nelle pieghe del mio corpo ho assorbito tanta di quella vaselina che per i prossimi mesi dovrò cenare con le cinture di sicurezza per non scivolare dalla sedia. Ho lavato magliette, calze, pantaloncini, mutande ogni santo giorno (per la precisione ogni santo pomeriggio) con la diffidenza di uno che, da single, a casa fa tutto-proprio-tutto ma che guarda la lavatrice come Salvini un senegalese: calze e mutande (tre e tre) pur essendo uguali ormai li riconosco e li chiamo per nome come una mamma coi suoi gemelli. Ho attuato un temerario e a volte complicatissimo piano di ricariche di aggeggi tecnologici (iPad, smartphone, iPods, orologio, tastiera, eccetera) in stanze che a stento avevano una lampadina e un interruttore.
Ho cercato di rispondere a tutti i messaggi arretrati (al netto delle rotture di coglioni). Ho aggiornato quasi quotidianamente questo blog che ha fatto il suo discreto numero di lettori (grazie grazie!). Ho raccolto idee creative per l’anno che verrà e che sarà cruciale professionalmente. Ho resistito al contagio – nei rari momenti di connessione con la mia realtà – dalle miserie umane e fastidiosi affini. Ho tenuto pochi contatti costanti, ma buoni. Ho rivalutato i rami secchi che hanno un’utilità quando muoiono definitivamente, bruciando.
Ma soprattutto ho imparato che c’è un’importante eccezione per noi dilettanti della determinazione che tendiamo a impegnarci in tutto, anche in ciò che ci fa male. Dobbiamo imparare a lasciar correre: è inutile far bene qualcosa che non ci piace. Lì non servono né pazienza né determinazione: serve fermarsi, scegliere una destinazione e andare.
Perché? Perché il miglior modo per rispondere a certe domande è non porsele. O al limite metterle in fondo a uno zaino e sperare di seminarle per strada, come un pezzo di sapone di Marsiglia.
P.S.
Per coincidenza arrivo (e torno) a Santiago nello stesso giorno in cui esattamente nel 2019 concludevo il Cammino del Nord. Quattro anni che sono un’era geologica con tutto quello che c’è stato nel mezzo. A chilometri esauriti mi piace pensare che le avversità siano un doping nella determinazione. Ma magari ne riparliamo più avanti quando acido lattico e vaselina saranno smaltiti…
25 – fine
Le precedenti puntate le trovate qui.
A questo argomento è dedicato il podcast in due puntate “Cammino, un pretesto di felicità” che trovate qui.
Mi piace:
Mi piace Caricamento...