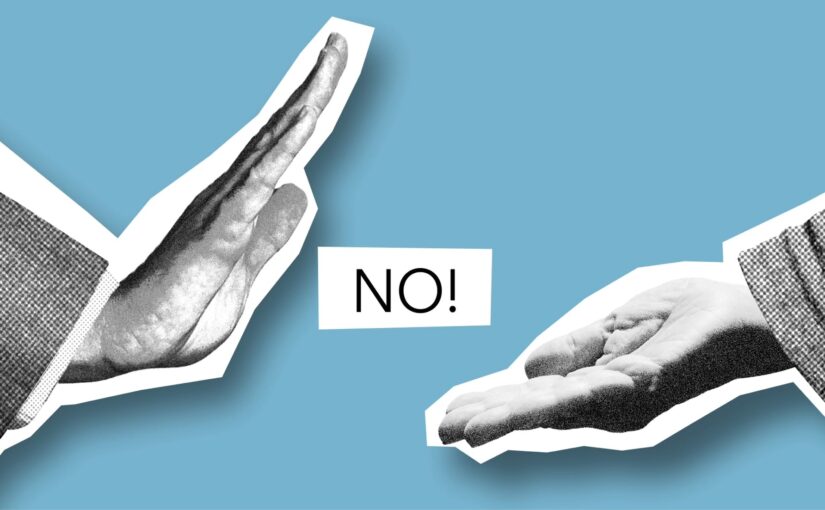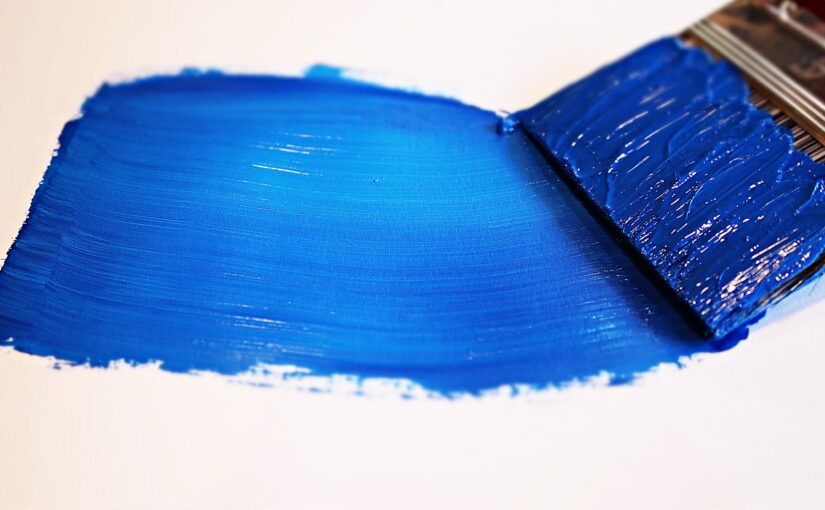Teatro Massimo di Palermo, 13 e 14 maggio 2022.
Qui le info.
Ma ne riparleremo.
Tag: mafia
C’è chi dice no
L’articolo pubblicato su Repubblica Palermo.
Nell’aprile del 1991, quattro mesi prima di essere ammazzato da Cosa Nostra, Libero Grassi spiegò meglio di tanti Soloni dell’Antimafia che la lotta alla criminalità partiva dalle competizioni elettorali. “Ciò che davvero conta è la qualità del consenso, la formazione del consenso”, disse. “A una cattiva raccolta di voti corrisponde una cattiva democrazia”. Ne avevo parlato già qui.
L’universalità di quel concetto, solida come la moralità di chi lo espresse, e non è mai stata messa in dubbio dallo scorrere del tempo, dal cambiamento degli scenari politici, sociali, criminali. L’ultimo allarme sulle estorsioni a Palermo e in Sicilia proprio in coincidenza con le elezioni prossime venture è un’occasione utile per riannodare il filo di un ragionamento che ormai sembra interessare solo i sopravvissuti della cosiddetta società civile e gli addetti ai lavori (ivi compresi i mafiosi). Il commerciante che si rivolge al boss non perché ha subito una minaccia, ma perché vuole farsi aiutare a sbrigare una “pratica” è il paradigma di un sistema storto. Un sistema in cui la mafia è sempre ceto dominante e in quanto tale dispone di soldi, di mezzi, di inserimenti nell’amministrazione. E di voti. La politica, che il consenso lo coltiva per poi nutrirsene, ha in ogni tornata elettorale la preziosa occasione di scardinare questo sistema. Non servono sindaci sceriffi, ne convegnisti compulsivi. Servono buoni esempi di ordinaria amministrazione, servono squadre blindate sui programmi, serve soprattutto una nuova cultura di muri. Proprio così, muri: contro il qualunquismo, contro il negazionismo, contro le scorciatoie sociali.
Un consenso di qualità è fatto anche di no.
Il pennello rubato
Sto scrivendo una cosa su Libero Grassi e, studiando tra carte giudiziarie e testimonianze giornalistiche, tra riflessioni dei figli dell’imprenditore e vecchi appunti che avevo sulla vicenda, mi sono imbattuto in una frase che dovrebbe essere scolpita nelle aule scolastiche e in quelle giudiziarie, nelle università e in tutti i luoghi del potere.
“Ciò che davvero conta è la qualità del consenso, la formazione del consenso. A una cattiva raccolta di voti corrisponde una cattiva democrazia”.
Libero Grassi
Libero Grassi questa frase la pronunciò in un’intervista a Michele Santoro il 14 aprile 1991, quattro mesi prima di essere ammazzato dalla mafia, non tanto per essersi rifiutato di pagare il pizzo (come sbrigativamente si usa ricordare oggi), ma perché il suo “no” rappresentava un esempio umiliante e pericoloso per Cosa Nostra.
La qualità del consenso ha oggi un peso sconfinatamente maggiore rispetto a trent’anni fa. Oggi il consenso che conta non è più solo quello elettorale, che anzi è l’aspetto meno importante data l’estinzione degli elettori. Il consenso è una forma liquida di giudizio sempre meno informato, sempre più volatile. Con una materia così difficile da recensire diventa impossibile vagliarne la qualità. Pensate ai rivoli tecnologici lungo i quali scorre oggi il consenso. Pensate al gioco della rifrazione social su un’opinione o peggio ancora su un fatto acclarato.
Abbiamo più volte ragionato sulla scomparsa dei fatti e su quanto la voragine provocata da questo boato nel vuoto della ragione rappresenti un pericolo: per tutti. Per gli illusi della democrazia e per i suoi nemici, per chi nega a prescindere e per chi difende gli assiomi, per chi lotta e per chi si arrende.
Per questo la qualità del consenso è ancor più importante adesso. Perché dobbiamo cominciare col ripristinarlo, questo benedetto consenso. Come? Innanzitutto sposando con orgoglio una forma di narrazione soggettiva, parziale, non equidistante. Quindi smettendola con le par condicio che mettono sullo stesso piano l’oro e la merda. Poi cominciando finalmente a coltivare il futuro (ne abbiamo parlato a lungo qui) e adottandolo come programma politico, scolastico, artistico. Infine valorizzando le diversità reali, che obbediscono a formazione, cultura, scienza, opinioni verificate. Mi piace immaginare il consenso come un grande quadro dove ognuno dà una pennellata. Colori e pennelli purtroppo ce li hanno sottratti gli algoritmi che sembrano regalarci un nuovo tempo e invece ce lo rubano minuto dopo minuto, byte dopo byte. Ma dovremo provvedere a recuperarne di nuovi.
L’estinzione della società civile
L’articolo pubblicato su Repubblica Palermo.
L’abbiamo invocata a gran voce quando mancava un appiglio politico, benedetta quando tutto intorno era buio e paura, citata alla cieca quando serviva un’entità positiva di riferimento. Non l’abbiamo rimpianta quando è scomparsa perché la sua fine è stata talmente lenta da rendere invisibile il suo stesso dissolversi.
La società civile in Sicilia non c’è più e non ce ne rendiamo ancora conto.
Se n’è andata coi suoi lenzuoli candidi, con le sue mobilitazioni spontanee che non hanno mai conosciuto la droga dei social, col suo essere ago preciso di bilance usate da mani distratte.
Nessuno l’ha uccisa, nessuno l’ha rapita. Si è estinta a causa di quel cataclisma sociale che ci ha portato a essere tutti (forzatamente) presenti pur non essendoci: partecipanti in contumacia, movimentisti da polpastrello. Anche l’humus sul quale era nata e cresciuta è cambiato. L’urgenza drammatica dell’aggressione mafiosa ha lasciato spazio ad altre urgenze: dai rifiuti dietro la porta, all’odio dietro lo schermo. Le emergenze fanno il loro lavoro che è quello di sommare problemi a problemi senza sommergerli, e in tal modo ci ingannano: in fondo non cambia nulla a eccezione del nostro modo di reagire.
In questa delocalizzazione dell’attenzione il corteo resta civile e la società resta a casa. Perché essa non è titillata dalla globalizzazione, anzi nasce nell’hyperlocal e si mobilita per la sua salvaguardia.
La mafia non è mai finita, ma non è più tra i trend topic. Anzi non lo è mai stata diciamo per mission aziendale.
Come in ogni estinzione che si rispetti la specie scomparsa farà sentire la sua assenza dopo molto tempo. Per capire com’è andata col dinosauro della società civile, bisognerà scavare. Ma prima bisognerà trovare il coraggio di farlo.
La sindrome della soddisfazione istantanea
L’articolo pubblicato su Repubblica Palermo.
Ci sono due storie, fresche fresche, per spiegare l’evoluzione del concetto di rapporto di socialità che noi spesso, sbagliando, intendiamo limitato al recinto dei social network. La comunicazione con l’altro, intesa come scambio di informazioni ed emozioni, risente giorno dopo giorno degli effetti aberranti di una sindrome che chiameremo della “soddisfazione istantanea”. Insomma è normale sentirsi apprezzati, non lo è aver necessità di esserlo ogni secondo, tramite lo scrolling di una timeline. La prima storia è quella dello spacciatore dello Zen 2 che esulta su TikTok per essere finito ai domiciliari anziché in galera e, preso dalla nota sindrome, si dimentica che anche le forze dell’ordine possono essere tra i suoi spettatori. Finisce che tra tanti like ci scappano le manette. Ecco l’aberrazione: lo scollamento del rapporto causa-effetto è più forte dell’istinto di autoconservazione. Lui sa di fare una cosa che lo danneggerà, non osa per coraggio (su TikTok abbonda tutt’al più l’incoscienza) ma per un godimento rarefatto, un cuoricino di byte, una macchiolina di pixel. L’altra storia è quella del cantante neo-melodico, categoria usata nelle nostre lande spesso (non sempre) per dare un ruolo pseudo-artistico a personaggi borderline, che presta la sua arte a invettive contro i pentiti di mafia e a elogi alla malavita. Qui però l’istinto di autoconservazione resiste, seppur in penombra. Intervistato da Repubblica, il cantore delle gesta di tale “spara spara” (rapinatore) nega di conoscere la mafia perché nato nel 1995: tutti sanno infatti che la mafia era estinta proprio in quegli anni, tipo dinosauri. E soprattutto assicura che potrebbe scrivere una canzone per Falcone e Borsellino, gli manca solo l’ispirazione.
L’arte ha i suoi tempi. Bui.
Se la mafia querela per diffamazione
Lui non lo sa, ma con quella filippica grugnita in un palermitano strascicato in cui ammonisce una sua amica dal mandare la figlioletta alla manifestazione per Falcone e Borsellino, sta facendo un pessimo servizio alla sua consorteria criminale. Il mafioso Maurizio Di Fede ribatte a una madre che si giustifica “ma in fondo è solo una cosa scolastica”: “Noi non ci immischiamo coi carabinieri, non ci immischiamo con Falcone e Borsellino”. Persino la donna appare incredula alla grossolana intransigenza del mafioso e ci ride su. Non ci ridono sui quegli stessi carabinieri coi quale Di Fede non si vuole immischiare: che infatti lo arrestano senza batter ciglio e consegnano l’audio delle sue esternazioni al pubblico giudizio. Soprattutto quello dei mafiosi, che sanno bene purtroppo come la sommersione, il basso profilo possa essere utile alla lunga. Quante volte l’antimafia è stata usata dalla mafia per travestirsi, per infiltrarsi? Molte, troppe.
Fabrizio Miccoli a parte, le offese a Falcone fanno parte di un copione trito che tende a rendere macchiette, a inscrivere una strategia criminale in un momento storico senza tempo, come se dalla strage di Ciaculli alla mafia cibernetica fosse un attimo. Ecco perché il sedicente capo che sfoggia il suo potere su una donna che manda ordinariamente la figlia alle attività della scuola è un errore blu nell’ortografia sbilenca di Cosa Nostra. Perché abbassa la soglia del ridicolo, attira la risata nascosta di chi gli sta vicino, rende visibile il disagio mentale di uno che crede ancora che vietare un corteo a una ragazzina sia un buon modo di seminare sani principi criminali. Senza nasconderci – e diciamolo – che molti bambini non sanno un tubo di Falcone e Borsellino: illuminante un’intervista di ieri al Tg3 Regione in cui alla domanda “sai chi era Falcone”, un bambino ha risposto: “Uno famoso…”.
Insomma alla fine forse ci dobbiamo arrendere che, a parte i crimini di cui è accusato, questo Di Fede è pure un diffamatore di Cosa Nostra.
Fossi Messina Denaro lo querelerei.
Una buona antimafia
L’articolo pubblicato su Repubblica Palermo.
Abituati come siamo a guardare la politica con diffidenza, rischiamo di perderci qualche passaggio quando invece il Palazzo lavora di buona lena e con attenzione. Allora è bene fermarsi e dare atto che c’è una politica che non è solo, per dirla con Berlinguer, una macchina di potere e clientela. La Commissione regionale antimafia guidata da Claudio Fava è un esempio di come si può vigilare sulle cose nostre senza lasciarsi trascinare dalla corrente del momento, di come si può indagare su temi di cronaca scottante senza farsi tentare da sterili effettismi. Così è stato per l’esame del caso Montante e sulle sue diramazioni complicate, per gli interrogativi sull’attentato Antoci e su certe incongruenze non da poco, per la recente disamina del doppio (o triplo) tentativo di depistaggio delle indagini sulla strage Borsellino. La Commissione ha, ad esempio, trattato un noto giornalista anti-boss come un normale testimone e non ha esitato a evidenziare alcune contraddizioni nel suo operato, rischiando la scomunica dell’antimafia adorante. Ha lavorato, insomma. Magari avrà sbagliato in molte o alcune conclusioni, ma si è data una direzione. È bene ribadirlo: qui non si giudicano i risultati che possono essere oggetto di valutazioni discordanti, si giudica un metodo. In particolare una discreta indipendenza dal mainstream, perché prima di affondare un coltello nella crosta delle cose bisogna assicurarsi che non sia stato usato per altro, insomma che sia pulito. Questa Commissione ha tentato di tenere a distanza il pregiudizio, di non conoscere intoccabili, di saper coniugare rigor di legge e curiosità. Ci ha rivelato che il compito della politica non è solo dare risposte, ma saper fare domande.
La mafia al tempo dei social
L’articolo pubblicato su Repubblica Palermo.
A Catania il clan degli spacciatori puniva i pusher che sgarravano pestandoli e umiliandoli e poi postava i video su TikTok. A Palermo la sete di vendetta per l’omicidio di Emanuele Burgio, figlio del boss della Vucciria, cresce su Facebook. Sono solo gli ultimi due episodi di una catena infinita di esternazioni e dimostrazioni di forza talmente tracotanti da apparire grotteschi nella loro ingenuità: la violenza esibita urbi et orbi ha un inconveniente non di poco conto, è visibile anche alle forze dell’ordine. Ma non importa. Ciò che conta è mostrarsi, riscuotere la gratificazione istantanea. Esserci nel non-luogo del social network può comportare un allentamento dei freni inibitori e l’abbandono della tradizionale prudenza persino da parte di un sodalizio criminale che proprio sulla prudenza ha costruito un complesso sistema di sicurezza. È vero, la mafia ha sempre cavalcato il clamore di certe sue azioni per intimidire, eliminare il dissenso. Colpirne uno per educarne cento, da Mao alle BR sino a Totò Riina, è stato un metodo che si sostanziava di azioni pubbliche, di ostentazioni violente. Ma lì almeno c’erano una logica ferrea e un filtro verticistico: oggi chiunque abbia un telefonino e un’idea malsana colpisce e “educa” a modo suo. Perché è cambiata una regola fondamentale che riguarda tutti, criminali e persone perbene: il destino di una teoria, qualunque essa sia, anche la più storta, non è più determinato dalla sua validità, bensì dal contagio che essa riesce a generare. La violenza ostentata in barba alla più elementare forma di prudenza è figlia di quella libertà, anzi “libertà”, vigente nei social che calpesta la norma numero uno della buona creanza: un’opinione è tale solo se esce dall’orifizio giusto.
Falcone e le illusioni da evitare
L’articolo pubblicato su Repubblica Palermo.
In questo 23 maggio che sa di primavera sociale, di luce che allontana il buio, di vita da riabbracciare dopo i patemi del Covid, Palermo si sveglia immersa in una mostra che vuole ricordare altri inverni, altri tempi bui. I murales e le installazioni del progetto di memoria “Spazi Capaci” è un moltiplicatore di simboli: opere simbolo in luoghi simbolo in un giorno simbolo. Nel ricordo delle vittime delle stragi di Capaci e via d’Amelio i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino veglieranno sulle strade che portano all’aula bunker. L’opera, “La porta dei Giganti” di Andrea Buglisi, prevede due enormi ritratti su parete, uno che è già piazzato sulla facciata di un palazzo in via Duca Della Verdura, l’altro che sarà realizzato in estate su un edificio in via Sampolo. A Brancaccio, in quella che è stata per anni una periferia urbana e di legalità, c’è il polittico urbano “Roveto Ardente” di Igor Scalisi Palminteri che ritrae don Pino Puglisi e un enorme fiammifero spento che “ha appiccato il fuoco eterno della vampa del coraggio”. In via Notarbartolo, davanti all’Albero Falcone, la statua di Peter Demetz intitolata “L’attesa” rappresenta una giovane donna che aspetta: il ritorno a casa di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, il compimento di una qualche giustizia terrena, il riscatto di una terra che pure disprezzò i suoi simboli, quando ancora la distrazione civile era un modo di vivere al passo coi tempi.
E poi i cani dell’aula bunker dell’Ucciardone. Un’imponente installazione di Velasco Vitali dal titolo “Branco”, con 54 cani a grandezza naturale, in ferro, cemento e persino uno in oro ci ricorda che i simboli non si giudicano, al limite quando si fanno arte si recensiscono. E non è questo il momento di interrogarsi sull’efficacia del mood dell’artista, ma di trovarci un’allegoria, un link, uno spunto di riflessione. O almeno di provarci.
In una terra dominata per anni oltre che dalla mafia, da un’antimafia pubblicitaria che ragiona per spot e slogan e che ripropone sempre le stesse messe cantate di una resistenza immaginaria, un coinvolgimento così totale dell’arte è una buona notizia. Tornano i lenzuoli – c’è l’immagine stilizzata dei due magistrati uccisi realizzata dai laboratori di Brancaccio del Teatro Massimo che è stata esposta in venti luoghi di cultura italiani – ed è un appiglio per la memoria. Ventinove anni fa il movimento dei drappi bianchi nacque da un volantino, altro che social, è funzionò. Forse perché c’era un contesto drammaticamente forte, forse perché i circuiti analogici della coscienza civile non risentivano di certe vacuità della partecipazione digitale: allora per esserci bisognava esserci e basta, niente clic e like. Oggi la rarefazione dell’emergenza mafiosa, che c’è ma non si vede, che trasuda ma non allaga, alimenta le illusioni. Che tutto sia passato. Che i simboli servano solo a ricordare. E che l’esercizio della memoria ci assolva dalla nostra disattenzione quotidiana.
Ecco, l’arte serve a questo: a ricordarci non chi siamo, ma chi diventeremo.
L’antimafia senza cipria
L’articolo pubblicato su Repubblica Palermo.
La mafia vista da vicino. Da vicinissimo. Dalla finestra di casa, dal posto di lavoro, dal finestrino dell’auto, dal tavolino del bar. Vista da giovani cronisti, immuni alle cialtronerie del circo mediatico che talvolta ammanta queste vicende. La mafia raccontata senza fronzoli, senza i protagonismi che tendono a dare al narratore l’inconfessabile gloria riflessa del narrato. “L’isola di Matteo” è un podcast di Matteo Caccia e Luca Micheli – disponibile sulla piattaforma Audible – che dovrebbe raccontare i misteri e i paradossi che circondano il superlatitante Matteo Messina Denaro. Invece è molto di più: è il nodo di mille fili, è la chiave di molti cassetti, è uno squarcio di luce nel buio di troppe cose non dette. E Matteo Messina Denaro è un pretesto per parlarne.
Il primo motore immobile (immobile manco troppo) di questa narrazione è Giacomo Di Girolamo, direttore del portale Tp24, scrittore marsalese e lucido esploratore della giungla mafiosa. Il podcast è la fotografia sonora della sua storia, del suo metodo giornalistico. Un metodo antico eppure, specie di questi tempi, rivoluzionario. Niente veline giudiziarie, né manine che allungano dritte interessate, solo lavoro di fino e tacchi consumati. Accade così che Di Girolamo arrivi prima degli inquirenti sulle storie calde o che, peggio, ci arrivi soltanto lui. Come? Spulciando tra bandi pubblici, piani di finanziamento, visure camerali, atti che pochi si degnano di leggere: pratiche scritte proprio per non essere lette, o per celare fraintendimenti cruciali. Di Girolamo cerca, consulta, verifica, pubblica: è una minaccia vivente per il sistema politico e affaristico che campa sul binomio distrazione-connivenza.
Qualche anno fa l’ex sindaca di Marsala Giulia Adamo lo citò in giudizio perché riteneva che le sue inchieste danneggiassero l’immagine della città: gli chiese 50 mila euro perché aveva la certezza che i suoi articoli che parlavano di mafia, omicidi, corruzione in qualche modo impedivano il riscatto di Marsala. Le querele sono per Di Girolamo una sorta di medaglia, ma come le medaglie possono pungere quando te le appuntano al petto. E nel podcast fa capolino anche il suo avvocato, Valerio Vartolo, che si mostra per quello che è: una via di mezzo tra un esperto del diritto e un fraterno angelo custode. La squadra di Tp24 è tutta un divertente ibrido di giornalismo e impegno civile: c’è Ciccio Appari, classe 1987, che fiuta le inchieste, c’è Carlo Rallo, che rappresenta la memoria storica, c’è Rossana Titone che segue con leggiadra intransigenza la complicata politica locale, e c’è Egidio Morici che vive e scrive a Castelvetrano, città natale di Messina Denaro, e che è un riferimento fondamentale per una redazione che ha sempre all’ordine del giorno le notizie e i sussurri sulla latitanza del boss.
“L’isola di Matteo” è narrativamente parlando un esperimento ardito che consiste nel raccontare una caccia disarmata a una preda pericolosissima, nello scardinare il linguaggio ad effetto dei soloni dell’antimafia, nel raccontare la straordinaria ordinarietà di una provincia siciliana. Si ride in tutte le tonalità: dal black humor di Di Girolamo, che è uno che darebbe un rene per trovare la battuta perfetta, al giallo di una storia che parte da alcuni cani rubati e arriva a un inusitato colpo di scena, dalla latitanza del superboss spiegata coi i Tupperware al pranzo a casa della mamma del protagonista testimoniato quasi in presa diretta, “milincianata” inclusa.
Più volte si invoca una analogia con Peppino Impastato, perché anche qui c’è una radio di mezzo (RMC 101) sulla quale ogni giorno gira il radar del “Volatore”, per definizione “l’aeroplanino dell’informazione” sul Trapanese, ma molto più prosaicamente il programma dal quale Di Girolamo manifesta l’esistenza in vita di un giornalismo d’inchiesta che non è d’inchiesta, ma giornalismo e basta. E Impastato c’entra poco, per esplicita ammissione dei protagonisti, giacché lui viveva in un contesto e in un’epoca infinitamente più complicati: e certe similitudini dicono più dell’oziosità dei nostri ragionamenti che della cronaca che vorremmo fissare in poche battute.
La storia della caccia a Matteo Messina Denaro resta sullo sfondo, per due motivi. Primo, perché i latitanti li cercano le forze dell’ordine e non i cronisti di provincia a meno che non ci siamo persi qualche passaggio in quest’Italia distratta e smemorata. Secondo, perché se c’è davvero qualcuno da celebrare in un podcast, che è strumento moderno e di gran moda adesso, è piacevole pensare che sia un gruppo di lavoro senza riflettori, con mezzi al limite dell’artigianale, con un’arte antica del raccontare che pochi, soprattutto tra i giovani, conoscono.
Fatevi un giro da quelle parti dove il portinaio diventa un vostro nemico solo perché, essendovi stata recapitata l’ennesima busta con minacce e polvere da sparo, la polizia lo ha convocato per interrogarlo. Dove gli appalti, anche i più insignificanti, possono decidere le sorti della più grande organizzazione criminale del mondo che ha il bilancio di un piccolo stato. Dove nel corso dei decenni il brand dell’antimafia è stato gestito da un trust di cervelli che coinvolge amministratori, magistrati, giornalisti e professionisti di ogni strato sociale.
Ecco, fatevi un giro e non chiedetevi nulla sul coraggio di scrivere in quelle lande. Sarebbe riduttivo. Per Di Girolamo e compagni il vero coraggio non è solo raccontare cose di cui nessuno scrive in quei luoghi, ma sorriderne. E scriverne con spietata ironia.