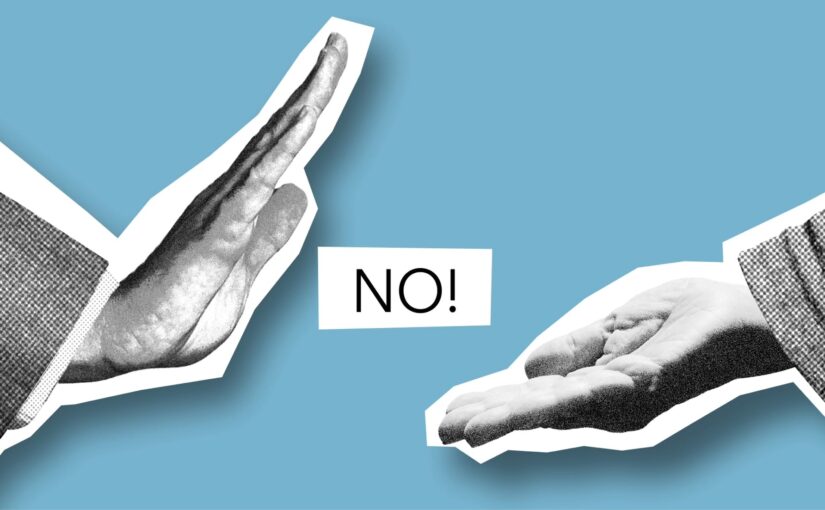L’articolo pubblicato su Repubblica Palermo.
Nell’aprile del 1991, quattro mesi prima di essere ammazzato da Cosa Nostra, Libero Grassi spiegò meglio di tanti Soloni dell’Antimafia che la lotta alla criminalità partiva dalle competizioni elettorali. “Ciò che davvero conta è la qualità del consenso, la formazione del consenso”, disse. “A una cattiva raccolta di voti corrisponde una cattiva democrazia”. Ne avevo parlato già qui.
L’universalità di quel concetto, solida come la moralità di chi lo espresse, e non è mai stata messa in dubbio dallo scorrere del tempo, dal cambiamento degli scenari politici, sociali, criminali. L’ultimo allarme sulle estorsioni a Palermo e in Sicilia proprio in coincidenza con le elezioni prossime venture è un’occasione utile per riannodare il filo di un ragionamento che ormai sembra interessare solo i sopravvissuti della cosiddetta società civile e gli addetti ai lavori (ivi compresi i mafiosi). Il commerciante che si rivolge al boss non perché ha subito una minaccia, ma perché vuole farsi aiutare a sbrigare una “pratica” è il paradigma di un sistema storto. Un sistema in cui la mafia è sempre ceto dominante e in quanto tale dispone di soldi, di mezzi, di inserimenti nell’amministrazione. E di voti. La politica, che il consenso lo coltiva per poi nutrirsene, ha in ogni tornata elettorale la preziosa occasione di scardinare questo sistema. Non servono sindaci sceriffi, ne convegnisti compulsivi. Servono buoni esempi di ordinaria amministrazione, servono squadre blindate sui programmi, serve soprattutto una nuova cultura di muri. Proprio così, muri: contro il qualunquismo, contro il negazionismo, contro le scorciatoie sociali.
Un consenso di qualità è fatto anche di no.