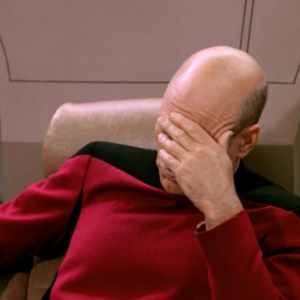L’articolo pubblicato sul Foglio.
Attenzione alle parole: “Non dormo più la notte da quando mi sono resa conto di cosa ho fatto, non dovevo insultare in quel modo su Facebook il capo dello Stato”. E ancora: “Era un periodo molto caldo, in cui gli animi erano surriscaldati da alcuni parlamentari dei Cinque Stelle di cui ero simpatizzante. Mi sono lasciata contagiare stupidamente da questi fatti. Io che sono madre, nonna, amante della pittura e degli animali”.
Sono alcune frasi pronunciate davanti ai magistrati di
Palermo da Eliodora Elvira Zanrosso, 68 anni, una degli
scriteriati che scrissero oscenità sui social network sul presidente Mattarella
dopo che questi, nel maggio 2018, aveva respinto la nomina di Paolo Savona come
ministro dell’Economia. La signora in questione è un prototipo perfetto
dell’hater moderno giacché fornisce con la sua testimonianza tutti gli elementi
che servono a identificare una fenomenologia dell’odio e del suo contagio.
In mezzo agli infiniti interrogativi su come sia possibile
che una tranquilla persona “madre, nonna, amante della pittura e degli animali”
si trasformi in una guerrigliera della volgarità, che al confronto “Napalm51”
di Crozza è un monaco benedettino, scrivendo a Mattarella “Ti hanno ammazzato
il fratello, cazzo… non ti basta?”, sorgono due certezze. La prima è che
nulla di tutto ciò nasce in rete. La fonte dell’odio è sempre esterna al web ed
è legata a un vento di irrazionalità e di incoscienza che soffia sul mondo delle
cose reali, analogiche, sulle promesse della politica, sulle disparità di
economie dissennate. Qualcosa di molto simile a una moda che si diffonde
orizzontalmente calpestando culture, religioni, identità nazionali. Prendiamo
il piercing, una pratica antichissima, addirittura preistorica, che serviva per
marcare le differenze, i ruoli, tra i componenti di una tribù e che oggi, al
contrario, è simbolo di omologazione: averlo significa essere nella
tribù, aderire alla convenzione, vivere appieno il tempo in ci si è
catapultati. Il piercing è una moda che è contagio fine a se stesso, senza
ragione, senza storia. Esattamente come accade con l’odio.
La seconda certezza è che l’anonimato non più ha alcuna
influenza sulla fabbrica della violenza verbale. Sembrano passati millenni
dalle vecchie lettere minatorie, da quei messaggi costruiti con i ritagli dei
giornali, simbolo di un artigianato della minaccia che ormai appare
grottescamente desueto. Oggi tutto è in chiaro, esplicitamente vomitato. Pudore
e paura – pudore nell’esporsi in una nudità di cattiveria, paura per le
conseguenze che l’atto offensivo può innescare – sono seppelliti dall’impeto
del clic: il mouse come una bomba molotov, la tastiera come la P38. I nuovi
odiatori si mostrano col loro volto, sorridenti nel tinello, col gatto sulle
ginocchia e il nipotino che dorme accanto. La pulsione li coglie alle spalle,
senza quasi che se ne rendano conto.
Nel 1977 Don Siegel girò un film intitolato “Telefon”, il
cui soggetto era tratto da un romanzo di due anni prima di Walter Wager. Si
raccontava di un nutrito gruppo di spie sovietiche infiltrate negli stati
Uniti, durante l’epoca della Guerra Fredda. Queste persone però non sapevano
realmente di essere agenti segreti poiché erano state condizionate mediante
lavaggio del cervello. Agivano e pensavano come perfetti cittadini statunitensi
pur essendo inconsapevolmente pronte a svolgere il ruolo per cui erano state
manipolate. L’impulso che attivava la loro volontà criminale arrivava per
telefono ed erano alcuni versi di una poesia di Robert Frost, “Stopping by Woods
on a Snowy Evening”: “I boschi sono belli, oscuri e profondi, ma ho promesse da
mantenere e molte miglia da percorrere prima di dormire… molte miglia da
percorrere prima di dormire”. In tal modo cittadini apparentemente innocui si
trasformavano in sabotatori suicidi, che nulla ricordavano sin quando era
troppo tardi.
Ora rileggiamo le dichiarazioni della signora Zanrosso: “Non
dormo più la notte da quando mi sono resa conto di cosa ho fatto”: la
sabotatrice che si risveglia.
“Era un periodo molto caldo, in cui gli animi erano
surriscaldati da alcuni parlamentari dei Cinque Stelle di cui ero simpatizzante”:
il meccanismo di attivazione.
“C’era Grillo che gridava da una parte, Di Battista dall’altra.
Dicevano: prepariamoci a scendere in piazza. Buttiamo giù tutto il governo”: la
paradossale chiamata in correità.
Tutto nel rispetto delle regole irregolari del contagio
dell’odio. Ma il vero colpo di teatro non è il risveglio tardivo dell’”agente
Zanrosso”, bensì il suo uno e due, il suo essere se stessa e un’altra.
Se fosse un film sarebbe trama poco plausibile, ma è la
realtà e ci si butta senza rete. “Ti hanno ammazzato il fratello, cazzo… non
ti basta?”, ringhia la nonna sui social. Ma dopo l’interrogatorio in Procura si
materializza il suo alter ego: “Io li ho vissuti gli anni Ottanta, so chi era
Piersanti Mattarella, il fratello del capo dello Stato. Voglio andare dal
Presidente, voglio chiedere scusa”.
Dobbiamo ancora imparare a riconoscere i danni provocati da
questo virus contagioso, però abbiamo piena contezza del sintomo principale: lo
sdoppiamento di personalità.
La domanda cruciale è: da dove origina tutto ciò?
Per cercare di capire dobbiamo andare indietro nel tempo,
almeno sino al 1922 quando Walter Lippmann, premio Pulitzer, pubblica un saggio
dal titolo “Public Opinion” in cui spiega come le idee dell’opinione
pubblica possano essere distorte con relativa facilità. La sua tesi è che
l’opinione il più delle volte non rispecchia la realtà, troppo complicata per
essere capita. Inoltre questa dipende dallo pseudo-ambiente esterno che ogni
individuo si costruisce in base a pregiudizi e in maniera più emotiva che
razionale. Il concetto cardine di Lippman è lo stereotipo sociale, cioè una
visione distorta e semplificata della realtà, una galleria di immagini mentali
che ci costruiamo per semplificare il mondo e per renderlo a noi comprensibile.
Che sfoci nel ciclone Black Friday o nel
dichiarazionismo forzato della Giornata contro la violenza sulle donne,
il contagio della mobilitazione a mezzo social può contare su un abbassamento
delle difese immunitarie del nostro libero arbitrio. Facciamo cose senza
crederci: condivido ergo sum.
Col tempo affiorano nuove tecniche, sempre più raffinate,
per plasmare come creta l’opinione pubblica. Si arriva così al grande inganno
della sondocrazia, cioè quel falso modello di democrazia in cui la
politica finge di governare per cambiare la società basandosi su “quello che la
gente vuole”. È il modello demagogico attualmente in voga su Facebook e
similari, che insegue persino le pulsioni più insane dell’opinione pubblica,
stimolandole, per poi svolgere il vero ruolo, quello diabolico, di persuasore
occulto.
Bobby Duffy, professor of Public Policy, direttore del
Policy Institute presso il King’s College di Londra e soprattutto ex direttore
generale della società di ricerche Ipsos, ha lavorato a lungo per studiare i
rischi della distanza tra percezione e realtà (ci ha scritto anche un libro, “The
perils of perception”) e lo scorso anno ha scoperto che gli italiani sono
quelli che stanno peggio al mondo. “Hanno ipotizzato che il 49 per cento dei
connazionali in età lavorativa fosse disoccupato, mentre in realtà si trattava
del 12 per cento. Hanno valutato che gli immigrati fossero il 30 per cento
della popolazione, quando la cifra reale era del 5 per cento. Hanno ipotizzato
che il 35 per cento delle persone in Italia avesse il diabete, quando in realtà
è solo il 5 per cento”, ha scritto. Ma non finisce qui. In Italia tendiamo a
sovrastimare anche il tasso di criminalità, i livelli di obesità, perfino la
percentuale degli ultrasessantacinquenni tra noi.
Con un’opinione pubblica così, tutto è più complicato. O più
semplice. Dipende dai punti di vista. Complicato per chi cerca di rimanere
aggrappato ai fatti, semplice per chi li gestisce tramite la sondocrazia magari
per sfruttare percezioni più utili per i suoi scopi.
Il quadro eziologico del nostro contagio adesso è più chiaro.
C’è un virus dell’odio che giova a una certa classe
dirigente.
C’è un vettore social dell’infezione, tipo zanzara con la
malaria.
Ci sono gli untori, cioè gli spargitori (o spammatori?) del
male.
E poi c’è il precario stato di salute del corpo nel quale si
diffonde l’infezione, un Paese gravemente fiaccato dall’analfabetismo
funzionale: i dati della più importante indagine di settore, lo studio Piaac,
collocano l’Italia al quarto posto di questa triste classifica mondiale con il
28% della popolazione adulta “incapace di comprendere, valutare, usare e farsi
coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società, per
raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e
potenzialità”.
Schematizzando. Siamo un Paese in cui molte persone hanno
pochi strumenti, o se li hanno non li sanno usare, per barcamenarsi in una
realtà oggettivamente complessa, e che quindi cercano una scorciatoia per
sentirsi adeguate: vanno a caccia di short-version magari condite con
un’abbondante dose di emotività, che le aiutino a sentire quel che non sono in
grado di capire. Ciò al netto del famoso effetto Dunning-Kruger, un bug
cognitivo secondo il quale meno le persone sanno più presumono di sapere, causa
di danni irreparabili soprattutto in sovrapposizione col dilagare di un’incompetenza
talmente profonda e radicata da non arrivare neppure alla soglia della
consapevolezza.
C’è infine la questione controversa della filter
bubble cioè della bolla di filtraggio: gli algoritmi dei social media ci
porgono prevalentemente contenuti che potrebbero piacerci, e che quindi
confermano le nostre opinioni. Ma su questo fenomeno esiste una fronda di
osservatori del web che tende a minimizzare gli effetti del filtro rinviando ai
comportamenti della vita reale: in fondo anche quando la sera usciamo a cena
scegliamo di andare con persone scelte sempre nella stessa cerchia di amici e
conoscenti.
Quando Manlio Cassarà, un altro degli odiatori di Mattarella
sotto inchiesta a Palermo, ebbe il suo “risveglio” dalla trance di violenza
verbale che gli aveva ispirato un “hanno ucciso il fratello sbagliato”, la
prima cosa che disse fu: “Ho scritto senza riflettere”. Confermando un concetto
di libertà applicato ai social secondo il quale un’opinione è tale solo se esce
dall’orifizio giusto.
Anche la nonna emula di Napalm51 nel suo “risveglio” ha
usato un simile argomento a sua discolpa: “Ho quasi 70 anni, faccio parte di
quella generazione che non è certo composta da geni della tastiera, ho la terza
media, sono istintiva. È stata la mia inesperienza, eravamo tutti su di giri in
quel momento”.
L’idea di far passare per frasi buttate così,
pseudo-argomentazioni violente e offensive è purtroppo un effetto secondario,
ma non meno pernicioso del virus. Perché non esistono scuse che possano far
rimarginare la ferita quando è il contagio che determina il destino di una
teoria, anche la più balzana, non la sua validità.
Mi piace:
Mi piace Caricamento...