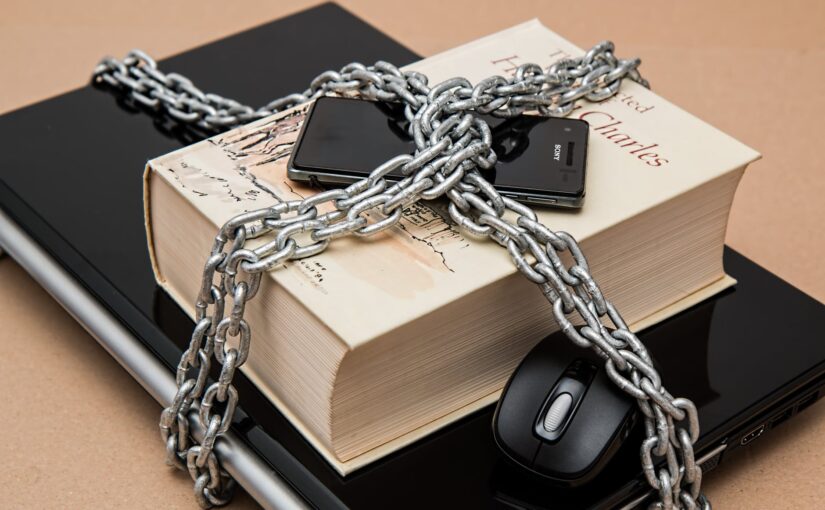L’articolo pubblicato su Repubblica Palermo.
In un’incredibile moltiplicazione di verità pacchiane in cui ognuno dice la sua infischiandosene delle leggi, della scienza e della mai troppo rimpianta realtà dei fatti, a fine mese si svolgerà a Palazzo dei Normanni un convegno di liberi pensatori il più moderato dei quali paragona il green pass ai tatuaggi dei lager. Quindi, ripetiamo, ci sarà un convegno nella sede dell’Ars di gente che identifica il periodo più drammatico della nostra storia recente – con morti, durissimi lockdown, crisi economiche e incertezze ancora all’orizzonte – con una deriva della dittatura (sanitaria, politica, economica e via cannoneggiando). Già basterebbe questo per indicare la grossolana indecenza di una discussione pubblica, in uno spazio che dovrebbe essere simbolicamente inaccostabile a simili iniziative, su un argomento così pericoloso sul fronte sociale e sanitario. Il green pass è uno strumento imperfetto e persino odioso, ma esiste perché esistono cittadini che confondono la libertà con l’egoismo, l’intelligenza con la violenza, il senso civico col senso del ridicolo. Coi vaccini bisogna andare avanti senza cedimenti. Un convegno che alimenti le indecisioni non è un convegno, è una follia. Quando uno degli organizzatori dichiara che l’obiettivo è stigmatizzare “il pensiero unico su questi temi” involontariamente, come capita a molte arche di scienza, dice una verità inconfutabile: sulle conquiste della medicina che ci tirano fuori dalla melma e che salvano vite c’è un pensiero unico. Ci deve essere, proprio per difendere la realtà dagli abbordaggi di negazionisti e convegnisti no-tutto.
Resta da capire che tipo di saluto istituzionale andrà a porgere l’assessore Lagalla a un consesso che delle istituzioni e delle loro regole se ne frega.