 L’articolo di oggi su la Repubblica.
L’articolo di oggi su la Repubblica.
Nella sua prima vita Rossella Tramontano è una traduttrice con la passione della vela. Una passione nata nel 2006 quando, messo il primo piede in barca, scattò l’amore per quel mondo di vento e schiuma, sale e sudore. Come tutte le prime vite, anche quella di Rossella finì sul più bello. Nel 2010, mentre erano in vista le prime regate importanti, arrivò la diagnosi che cambiò tutto: carcinoma mammario.
La seconda vita di Rossella inizia nel modo più tristemente ordinario per chi spera in un altro giro di dadi: chemioterapia, radioterapia, terapia endocrina. Invocazioni e imprecazioni: da un lato la speranza, dall’altro la rabbia.
Rossella è una donna sportiva e la sua forza cede al timore, che non è quello di morire ma quello di restare sola, di essere esclusa. “Chi mi avrebbe mai preso in barca sapendo che avevo un tumore? Portavo una parrucca e, anche se non avessi detto nulla a nessuno, al primo colpo di vento sarebbe successo l’irreparabile, che vergogna! Decisi di abbandonare”.
Furono mesi difficili e Rossella si sentì vacillare. Sino a un caldo giorno di giugno del 2011 quando, ferma con l’auto al semaforo, decise di fare la sua personale rivoluzione: “Ero sudata e avvilita. Fu un attimo: mi tolsi la parrucca e la lanciai via. Un signore che era fermo con la sua macchina accanto a me rimase sbalordito”. La seconda vita di Rossella Tramontano segna l’epoca della ribellione: contro la malattia e contro quella forma malsana di pudore che ci suggerisce di essere come non vorremmo mai essere.
Le terapie fanno effetto. L’anno seguente ricomincia a gareggiare e partecipa ai Campionati nazionali d’altura. È “drizzista”, cioè addetta alle drizze (le cime che servono a issare le vele), un ruolo dove serve velocità d’esecuzione. Lavora con le braccia che ha rimesso in sesto con mesi e mesi di palestra dopo l’intervento. Arriva su Alvarosky, un GS 40 R pluripremiato con cui nel 2016 vince il Campionato italiano Offshore.
Ma è a questo punto che per Rossella Tramontano inizia la terza vita. Un altro tumore, un altro intervento e la scoperta di diciotto metastasi. Stavolta non c’è tempo per sentirsi fuori gioco. Un anno di denti stretti e pensieri positivi nonostante si debba lavorare più di speranza che di certezze. I risultati arrivano. Grazie alla terapia si assiste a una riduzione delle lesioni: i medici danno il via libera per tornare a regatare. Il prossimo 21 agosto, Rossella parteciperà alla Palermo Montecarlo, 550 miglia da percorrere in quattro giorni e quattro notti a bordo di DonnaRosa 2.0, il Beneteau Oceanis 55 dell’armatore e timoniere Fabrizio Mineo. La sua impresa è stata promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione Palermo Centro, e patrocinata dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Palermo e ci insegna che il vento non lo puoi cambiare, puoi solo orientare meglio le vele.
In barca e nella vita.
Mi piace:
Mi piace Caricamento...



 L’articolo di oggi su la Repubblica.
L’articolo di oggi su la Repubblica.

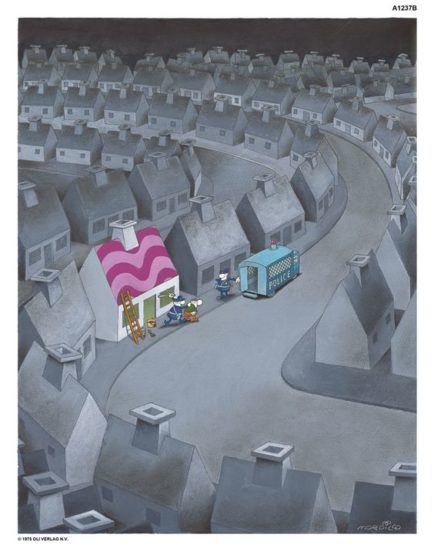 Era l’8 settembre 1988, me lo ricordo come se fosse ieri. Il giornale per cui lavoravo mi inviò a Torino per seguire la tappa italiana di
Era l’8 settembre 1988, me lo ricordo come se fosse ieri. Il giornale per cui lavoravo mi inviò a Torino per seguire la tappa italiana di 
 Nel suo ultimo giro di concerti, Phil Collins tiene fede al titolo della sua
Nel suo ultimo giro di concerti, Phil Collins tiene fede al titolo della sua 
