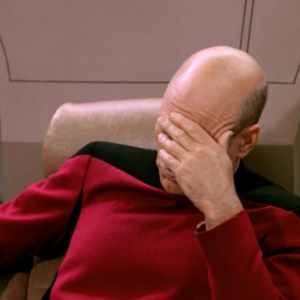L’articolo pubblicato su la Repubblica Palermo.
Volevamo esplorare il mondo, siamo finiti a sbirciarlo dal chiuso delle nostre case. Noi e tutto il resto, separati da una finestra che non è metafora di nulla – manco a sforzarsi, da Alfred Hitchcock a Tano Festa da Henri Matisse a Joseph Conrad – ma solo netto, non ingiusto confine.
La mia finestra è ampia e racconta una storia stretta e lunga, come il budello che si faceva stradina tra le case popolari di un quartiere figlio del Sacco di Palermo e che oggi ha l’ardire di dirsi zona residenziale. Resuttana – San Lorenzo fu una distesa di agrumeti e di cemento abusivo fino a quando, col salvacondotto dei Mondiali del ’90, gli agrumeti diventarono abusivi e il cemento diventò distesa. Oggi la mia finestra è inutilmente luminosa, quasi che il sole rimbalzi e si amplifichi sui palazzoni che stanno attorno, quasi che la meteorologia burlona ci possa riscattare dalla nostra ansia motoria, giri e giri per casa, giorni feriali in salotto e weekend in cucina (o viceversa, dipende dalle pulsioni e dalle ispirazioni a cui decidiamo di cedere) in un “cricetismo” che è una beffarda metafora di ciò che abbiamo (de)costruito: siamo ciò che percorriamo.
Quel che vedo fuori stride con quel che vedo dentro. Io ci
sono cresciuto in questo quartiere, ma adesso è come se mi ci avessero
paracadutato da un cielo che non è spazio, ma tempo. È come se mi mancasse un
pezzo di realtà, di racconto.
Per cercare di risolvere questo arcano di sensazioni monche mi sono lasciato trasportare da una bellissima serie televisiva, “The Man in the High Castle”, tratta da un romanzo ad alta gradazione distopica di Philip K. Dick, che racconta di un mondo alla rovescia: un mondo dove però c’è una pellicola cinematografica clandestina che raddrizza la storia e la porge al lettore/spettatore come dovrebbe essere, coi crismi di una realtà non farneticante.
Anche io ho un film clandestino. Una bobina che sulla
celluloide di un super 8 vetusto incolonna i pezzi mancanti. Da ragazzini io e
il mio amico Gianni, che viveva nell’appartamento sullo stesso mio
pianerottolo, avevamo il vizio di sognare insieme a mezzo cinepresa. Con una vecchia
Kodak abbiamo girato ore e ore di materiale pressoché inutile, ergo
fondamentale per noi: appassionati di film horror mettevamo su, set improbabili
coinvolgendo fratelli, sorelle e altri amici del palazzo, che finivano
puntualmente ammazzati con gran dispendio di salsa di pomodoro e di rossetti
trafugati alle nostre mamme. E poi c’era la nostra finestra. Da lì giocavamo a
spiare l’umanità, immaginando di poter essere testimoni di chissà quale crimine,
di filmare tutto e diventare famosi. L’umanità ci fece attendere un po’ e
qualche anno dopo, sotto casa nostra, spararono a un meccanico. Ma per fortuna
noi eravamo cresciuti e avevamo abbandonato la cinepresa per dedicarci ad
attività più socializzanti, come andare al cinema con le ragazzine o impennare
col Vespino. Un giorno ancora più avanti nel tempo, dalla stessa finestra, con
la serranda socchiusa, sentii un rumore sconosciuto, come di dieci saracinesche
che cadevano giù violentemente. Avrei avuto tempo di imparare rapidamente che
quel rumore orribile proveniva dai kalashnikov che avevano massacrato il commissario
Ninni Cassarà e l’agente di scorta Roberto Antiochia.
Riavvolgendo la pellicola mi accorgo che il panorama di oggi è cambiato non tanto per il cemento e per il fatto che Monte Pellegrino non si vede quasi più (un tempo, quando ero un freeclimber, mia madre mi osservava col binocolo mentre ero in parete per sapere se ero vivo e per capire quando sarei sceso, in modo da poter calare la pasta in tempo). Manca un tassello fondamentale della socialità di noi ragazzi dell’epoca: il calcio per strada. Quello che oggi è un marciapiede mediamente sconnesso, nella mia memoria in formato super 8 era uno slargo in cui auto e ragazzini si contendevano senza spargimenti di sangue una fetta di spazio. Si giocava al pallone dove era possibile, bastavano un Super Santos e quattro maglioni da ammonticchiare per fare le porte. Mai nessuno di noi è stato investito, mai nessun pallone è sopravvissuto: la partita terminava quasi sempre perché il Super Santos si bucava, o veniva tagliato, o finiva nel balcone di qualcuno. Ma questa è la parte della storia che si diluisce nella leggenda.
Oggi dalla mia finestra vedo spazi inusitati per un
quartiere come Resuttana – San Lorenzo, ma è un deserto artificiale circondato
da una popolazione che, come uccelli appollaiati sui cavi della luce, aspetta
dall’alto dei balconi. Aspetta un fischio di inizio o di fine, a seconda dei
punti di vista. O un pallone che nessuno calcerà più.
Mi piace:
Mi piace Caricamento...