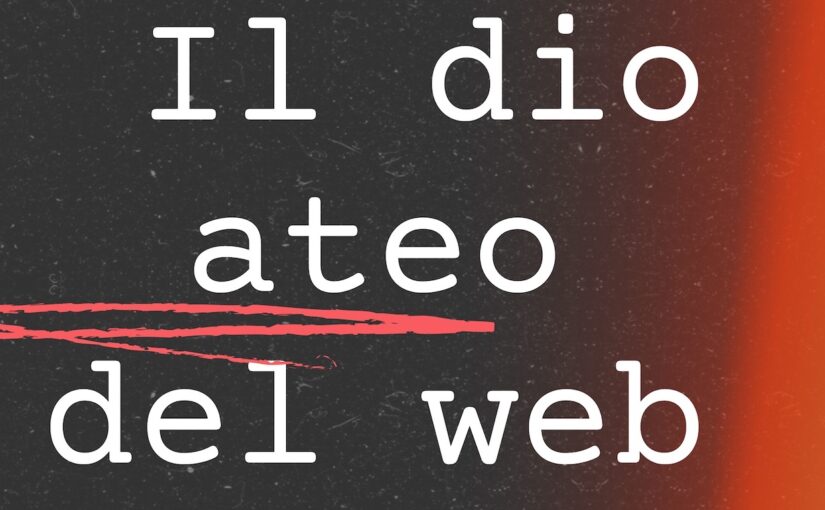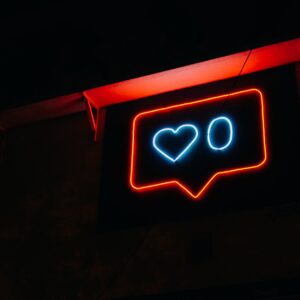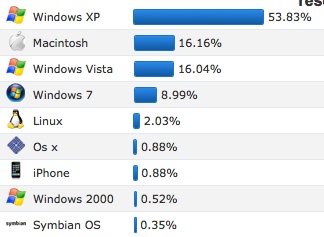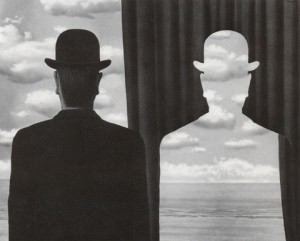Ci sarà un dio del web e sarà pure un pazzo. Sarà burlone e ingiusto, ma è un dio che ci sa fare con gli affari. Fiuta la preda, la insegue e la fa sua: senza finirla, anzi iper-alimentandola e spingendola verso la bulimia. Più lei consuma, più il dio è soddisfatto. Più lei consuma, più lei stessa è sfiancata. Funziona così nel regno del web, nel cielo dei cieli telematici dove vive e regna nei secoli dei secoli il dio algoritmo.
Da Netflix a Angela da Mondello, dal feed di Facebook agli spari a J.R (il cattivo di Dallas), dal Giornale di Sicilia al Teatro Massimo, dal sesso di Apple alla lumaca di Pirandello: ferite e cicatrici in nome dell’innovazione. Questo podcast prova a raccontarle con chiarezza, insomma senza toccarsela con la pinzetta.
P.S.
L’esigenza di essere chiaro non mi mette al riparo dagli errori. Mi scuso per la pronuncia di binge watching che andava con la g dolce, come mi è stato fatto notare… Pardon.