 L’attimino fuggente
L’attimino fuggente
di Giacomo Cacciatore
Credo che esistano ancora due tipi di Natale italiano. Uno antropomorfo, l’altro legato al meraviglioso mondo della flora. Nel primo caso si torna bambini: si gioca e si pasticcia col minuscolo, si ricreano universi in scala, mondi che vorremmo, profumo di mangiatoie, calore di fiamme nella notte di gelo. Nel secondo, si agisce sotto l’impulso di qualche antico culto totemico, forse ereditato da fantasmi con gli elmi cornuti e i piedi freddi, forse dagli indiani dei film di John Wayne. Insomma, sto parlando di chi, a Natale, perde la testa con il presepe e di chi invece si impelaga in studi di fisica ed estetica per arrangiare l’albero. Posso sbagliarmi ma, senza avventurarmi nelle solite classificazioni da sociologi d’accatto (il pandoro è di sinistra, il panettone di destra) ho sempre avuto la sensazione che il presepio fosse cosa di vicolo, di case popolari, e l’albero appannaggio dei quartieri alti. Tralascio le novità del tipo “babbo natale che si arrampica sul balcone”: ho idea che li abbiano inventati per chi passa le feste agli arresti domiciliari.
Io un tempo ero “presepista”. Nel senso che appartenevo a quella categoria di bipedi che il giorno dopo l’otto di dicembre, ancora caldi di letto, in pigiama, con occhi bambini e gesti da vecchi, scivolano verso l’angolo del salotto o il ripiano del soggiorno per controllare il pasticcio di pastorelli, sugheri, laghetti di specchio circondati da muschio che hanno combinato la sera prima. Una mesta categoria di ossessivi e idealisti, nobilitata dal genio di Eduardo De Filippo. Il presepio, in quanto via di mezzo tra il bricolage e il rito apotropaico, a mio modo di vedere rispecchia – molto più dell’albero – non solo la classe sociale e la condizione economica di chi lo ha azzizzato, (per numero di pastori, qualità delle lampadine e imponenza delle montagne di sughero) ma anche il suo stato d’animo, il livello di serenità propria e di chi lo circonda, il grado di stabilità familiare.
Il mio presepio è sempre stato precario, sproporzionato, incurante della verosimiglianza prospettica: più simile a un’allucinazione espressionista che all’armonia oleografica della prima puntata del
Gesù di Zeffirelli. Pastori zoppi, un bue formato brontosauro, un San Giuseppe minuscolo rispetto a una Madonna-matrona. Nei volti di plastica o di creta della mia natività si leggeva un velo di inquietudine. Sapevano di essere destinati, prima o poi, al tracollo. Quando i miei genitori litigavano – e spesso succedeva proprio a Natale – il primo a subirne le conseguenze era il presepe. Una gomitata, uno sbattere di porta, un urlo più forte degli altri, e il paesaggio di Betlemme diventava uno scenario da dopobomba. Morti e feriti. Con pazienza, mi improvvisavo responsabile della protezione civile di magi, ciabattini e pecorai con l’agnello a tracolla finiti a gambe all’aria.
Ero presepista, sì, ed ero più triste di oggi. Ho sposato una donna che appartiene, per tradizione e condizione, alla categoria degli alberisti. E’ lei che mi ha introdotto nel magico, ordinato mondo dell’abete (ecologico). Mi ha salvato la vita, credo. Ma la tentazione di mettere su un presepe che regga agli urti, mi resta.
Mi piace:
Mi piace Caricamento...


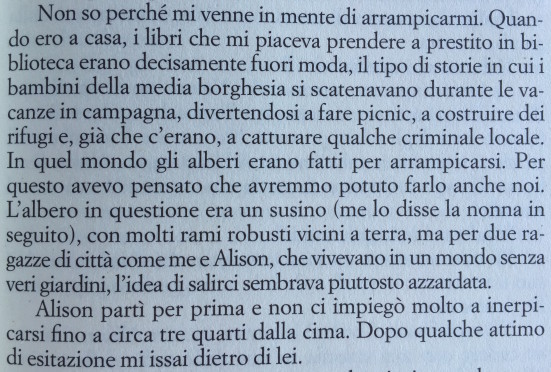 In Numero undici di Jonathan Coe c’è un bellissimo riferimento a uno dei miei sport preferiti, quand’ero piccolo. L’arrampicata sugli alberi. In ogni capitolo della mia infanzia, e poi dell’adolescenza, c’è sempre stato un albero su cui zompare, dal quale sognare, su cui inventarsi una casa (la casa sull’albero è un sogno poi diventato realtà molto dopo,
In Numero undici di Jonathan Coe c’è un bellissimo riferimento a uno dei miei sport preferiti, quand’ero piccolo. L’arrampicata sugli alberi. In ogni capitolo della mia infanzia, e poi dell’adolescenza, c’è sempre stato un albero su cui zompare, dal quale sognare, su cui inventarsi una casa (la casa sull’albero è un sogno poi diventato realtà molto dopo, 

