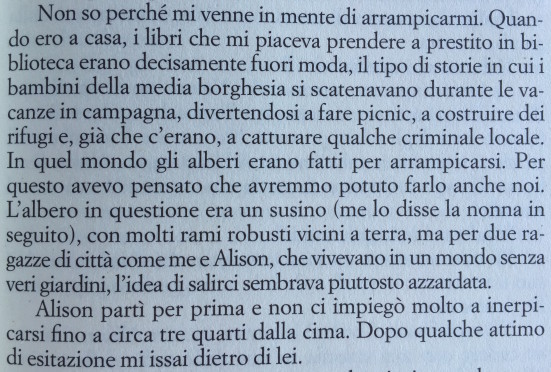 In Numero undici di Jonathan Coe c’è un bellissimo riferimento a uno dei miei sport preferiti, quand’ero piccolo. L’arrampicata sugli alberi. In ogni capitolo della mia infanzia, e poi dell’adolescenza, c’è sempre stato un albero su cui zompare, dal quale sognare, su cui inventarsi una casa (la casa sull’albero è un sogno poi diventato realtà molto dopo, esattamente sei anni fa), dal quale tirare pigne agli amici di sotto, sul quale nascondersi o fuggire.
In Numero undici di Jonathan Coe c’è un bellissimo riferimento a uno dei miei sport preferiti, quand’ero piccolo. L’arrampicata sugli alberi. In ogni capitolo della mia infanzia, e poi dell’adolescenza, c’è sempre stato un albero su cui zompare, dal quale sognare, su cui inventarsi una casa (la casa sull’albero è un sogno poi diventato realtà molto dopo, esattamente sei anni fa), dal quale tirare pigne agli amici di sotto, sul quale nascondersi o fuggire.
Nel primo giardino dei miei ricordi c’era un pino molto facile da scalare. Il tronco si divideva quasi subito in una V ed era semplice mettersi a cavalcioni. Poi salendo il gioco si faceva duro. Il traguardo era quello di arrivare a mettere la testa fuori dalla chioma, obiettivo quasi impossibile da raggiungere dato che i rami, man mano che si andava su, diventavano sempre più sottili e fragili. Ma nella testa di un bambino non c’è la fisica, né la coscienza del pericolo. C’è solo la voglia di salire, di vincere: quasi una metafora della vita che ci (a)spetta. Io da lassù ho immaginato le mie passioni, su quei rami ho mangiato tonnellate di biscotti e letto libri (i Gialli per ragazzi, Jules Verne, Emilio Salgari, I ragazzi della via Pàl). Ho aspettato gli amici che non arrivavano perché preferivano giocare con altri e altrove, e me ne sono fatto una ragione. Perché avevo il mio albero. E il mio albero non mi tradiva mai, neanche quando mi macchiava di resina o mi graffiava le mani.
Una delle cose seccanti dell’età che avanza è che non si trovano più alberi da scalare. Su cui essere libero di fantasticare chi vorrai diventare in questa o in un’altra vita rischiando gioiosamente di romperti l’osso del collo.
