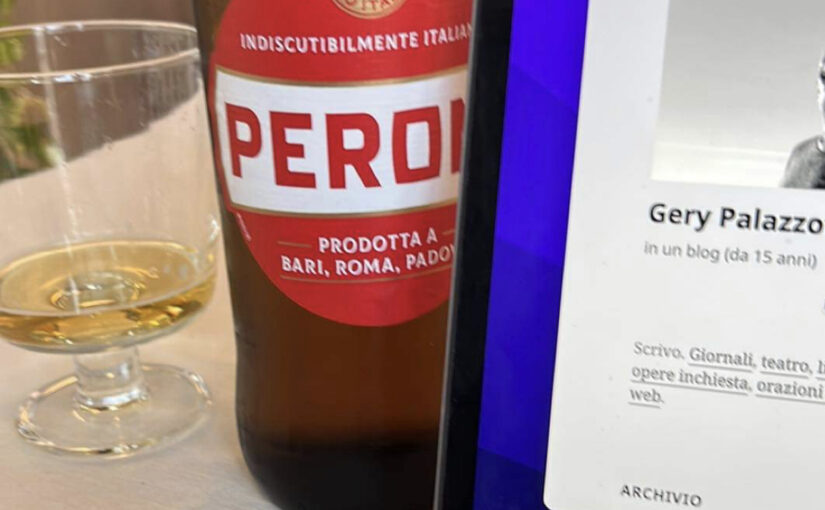Ho scritto un messaggio a un caro amico e collega, uno che lavora attivamente nei giornali, mica come me che approfitto dello spazio che mi concedono: “Bisognerebbe farsi l’Italia a piedi, fuori dai grandi circuiti (turistici, economici, politici) e raccontarne le storie. Molto istruttivo…”.
Perché da questa Francigena personalizzata ciò che sto traendo ha a che fare con le vicende umane, più che altrove, in altri viaggi in giro per il mondo.
Il merito è innanzitutto del mezzo sul quale viaggio: le mie gambe. Muoversi a piedi, più che farlo in bicicletta (per citare il parente stretto della camminata), ha un effetto di moltiplicazione delle sensazioni. Una specie di catalizzatore di emozioni. Ti muovi lentamente, con il tuo zaino sulle spalle, aspetti e pregusti, soffri e godi, sudi e ringrazi. Non esiste, a mio parere, esperienza così totalizzante come un lungo viaggio a piedi, senza sherpa e passaggi abusivi, senza scorciatoie fisiche e soprattutto mentali (un concetto sul quale torneremo prossimamente).
In questi giorni le uniche persone che ho incontrato sulla Francigena erano fuori dalla Francigena: il percorso dei camminatori è praticamente deserto, perché di questa parte del cammino non gliene frega niente a nessuno, col caldo, le zanzare e la maggior parte dei centri vitali chiusi per ferie.
Anima di giornalista impone: laddove non va nessuno, tu ci devi essere.
Questa è la teoria.
La pratica è che mi piaceva riprendere da dove mi ero fermato lo scorso anno (con un piccolo sconto di sacrificio nelle lande impossibili del Vercellese).
E il mio passo continuato diventa esperienza umana col contadino di Gambolò (andatevelo a cercare questo posto) che ha un piccolo B&B e che si offre di farti parcheggiare la macchina per il tempo necessario al tuo cammino, nel mio caso 15 giorni, senza chiederti nulla in cambio: “Ho spazio lì, se non le secca”. Ed è magia constatare che il riposo di una Toyota Hybrid sarà accanto a un trattore alto due metri e passa: la pacificazione del progresso con la tradizione, di ciò che arriva con ciò che consente che arrivi. Senza trattori non saremmo nulla, ricordiamocelo noi stolti cittadini freschi di manicure.
A Gropello Cairoli mi trovo in un posto splendido, Villa Cantoni, gestito da una coppia di curiosi, la migliore categoria di persone che esista. Quando capiscono chi sono e cosa ci faccio (lì e altrove) improvvisano un aperitivo per liberare la loro voglia di raccontare. Il posto in cui siamo trasuda storia. Casa natale del filosofo Carlo Cantoni e crocevia di antiche passioni risorgimentali, l’edificio, circondato da un giardino maestoso, meriterebbe un museo. Se ci fosse stata mia madre, avrebbe prenotato per i prossimi sei mesi. Ma si tratta di una cattedrale nel deserto, infatti Gropello Cairoli pur essendo inserito nel circuito della Via Francigena, non ha altro da offrire in questo periodo. Manco un ristorante, a parte un postaccio di affabili volenterosi dove puoi scegliere se mangiarti un panino sulla strada a favore di scappamento, all’interno con 35 gradi, o in una specie di cortile disastrato tra contenitori dell’immondizia e zanzare col bidoncino.
Chiusa la parentesi del misfatto di Pavia dove, come vi ho raccontato, un tale pretende di spacciare una stamberga per un appartamento in cui (soprav)vivere ad agosto, c’è la storia più emblematica di quelle raccolte finora.
Sono a Castel San Giovanni, Hotel Rizzi. Il percorso per arrivare qui è quasi tutto su asfalto, per fortuna la tappa è breve: appena 13 chilometri. L’hotel è distante dal centro abitato, in una landa semideserta: del resto se volevo trovare una accoglienza unz unz, andavo a Riccione.
Arrivo in tarda mattinata, come spesso accade, provato. L’hotel è deserto. Alla reception un ragazzo dissimula la pietà. Prendo possesso della stanza e sommessamente chiedo come fare a mangiare qualcosa. Il centro abitato è a due chilometri abbondanti: il che significa quattro chilometri a pranzo e quattro chilometri a cena. Otto chilometri in più per uno che viaggia a piedi (a 59 anni) sono un pessimo investimento sulle gambe che devono reggere sino alla fine.
Il ragazzo mi guarda e mi dice, con un fare che non so come reputo meravigliosamente meridionale: “Non c’è problema”.
Il tempo di farmi una doccia e c’è pronta un’insalata ricca come raramente ho visto. Fatta con le sue sante manine, che il dio dei receptionist lo abbia in gloria.
Più tardi incontro il proprietario dell’hotel, un tipo affabile e pacato, che mi spiega: “Solitamente in questo periodo chiudiamo il ristorante, ma siccome quest’anno ho alcuni dipendenti di una ditta che continua a lavorare nelle vicinanze, non mi è sembrato giusto piantarli in asso”.
Cucina on demand.
Nella grande sala ristorante (nella foto), che comunque mantiene tutti i tavoli apparecchiati (“sennò sembra triste”), siamo in otto a cenare stasera, cinque – i dipendenti di cui sopra – sono immigrati.
In cucina c’è il cuoco. In sala ci sono il titolare e la sua figlioletta che servono ai tavoli con una cura commovente.
La cena è ottima. E, capite bene, non solo per il cibo.
4- continua
Le altre puntate qui.
A questo argomento è dedicato il podcast in due puntate “Cammino, un pretesto di felicità” che trovate qui.