 La storia dell’umanità ha sempre avuto bisogno di eroi. E ogni epoca ha avuto gli eroi che meritava o si aspettava. L’eroe è una figura che vive di ciò che ha fatto e ancor più di ciò che avrebbe potuto fare se il destino non le avesse strappato le carte dalle mani mentre giocava la partita più importante. Gli eroi comunque finiscono male, altrimenti sarebbero semplici fenomeni (che, anche loro, appaiono e scompaiono ma non con l’obbligo della tragedia finale).
La storia dell’umanità ha sempre avuto bisogno di eroi. E ogni epoca ha avuto gli eroi che meritava o si aspettava. L’eroe è una figura che vive di ciò che ha fatto e ancor più di ciò che avrebbe potuto fare se il destino non le avesse strappato le carte dalle mani mentre giocava la partita più importante. Gli eroi comunque finiscono male, altrimenti sarebbero semplici fenomeni (che, anche loro, appaiono e scompaiono ma non con l’obbligo della tragedia finale).
Maradona è uno di quelli che abbiamo imparato a chiamare, con un ossimoro ben digerito, eroi tragici. Il povero che si fa largo grazie al suo talento, il simbolo che viene consacrato al ruolo di trascinatore di folle, il profeta di una parola che non conosce ma che sa ben tenere tra i piedi, il Robin Hood che ha un bottino di emozioni da regalare a chi le può soltanto spiare. Non c’è paragone che tenga per dipingere una parabola così ben congegnata da un destino sempre aggiornato, al passo coi tempi. Per lui il Grande Impresario ha scelto il palco più grande che ci sia nell’epoca in cui viviamo: uno stadio, un campo di calcio, un pallone. Fosse stato un musicista o uno scrittore Maradona non avrebbe avuto il privilegio di poter godere di un’idolatria che si destina ai trapassati. Sarebbe stato celebrato per i suoi dribbling del solfeggio o del periodare probabilmente solo post mortem. E’ così che funziona nei campi dell’arte classica. Invece Diego Armando si ritrova a essere inseguito da una fama che lo onora e lo distrugge al tempo stesso. Chissà se mai, da ragazzo, gli sarà passato per la testa quel pensiero che coglie noi, normalissimi signor nessuno, quando sogniamo di aver fortuna: capiti quel che capiti non mi farò distruggere dal denaro. Ha scelto un’arte in cui la resistenza alle cattive tentazioni è l’handicap nascosto. Il suo ultimo numero è cercare di far finta di superarlo.
Autore: Gery Palazzotto
Facciamo che…
Facciamo che questi siti siano un fallimento comunicativo o quantomeno che le decine (centinaia?) di contatti siano di galoppini, sostenitori, questuanti, ruffiani, qualche guastatore e un paio di curiosi: insomma per chi ha pratica di queste cose sono contatti di valore zero.
Facciamo che Cammarando e Orlata non abbiano capito che la comunità online è la più ostile ai ragionamenti pelosi, perché vuole vedere subito, perché controlla tendenziosamente, perché ha un sistema di passaparola che ti promuove o ti boccia nel giro di un minuto e mezzo su scala planetaria. Facciamo che Cammarando e Orlata non sanno niente delle città virtuali che vivono sopra e sotto quelle reali. Facciamo che si ritirino dal web e tornino ai palchetti della politica.
Liberi da Libero
Non so se oggi queste parole finiranno in un messaggio dentro una bottiglia. Sono in un momento difficile: la mia Adsl mi ha lasciato a piedi. Accade sempre più spesso. Libero Infostrada o come caspita si chiama ha promesso di darmi una connessione a 4 mega e più, in realtà l’unica velocità che riesce a mantenere è quella con la quale succhia i soldi dal mio conto in banca.
Se poi cerchi di parlare con qualcuno dell’azienda ti ritrovi in un dedalo di voci registrate che ti ricordano quanti numeri ha la tastiera del telefono (12 e più!) e quante sono le possibilità di incappare in un essere umano che possa interagire con te (0, leggi: zero).
La banda larga – e le vicende Telecom di questi giorni ce lo ricordano – è uno scandalo nazionale che dovrebbe far ballare i tavoli di un governo che si definisce “di progresso”. Il reticolo di competenze e responsabilità, con il conseguente scaricabarile tra varie compagnie telefoniche, andrebbe troncato con un sistema di azione-reazione tipicamente americano: tu mi dai un servizio che non mi soddisfa, io ti denuncio; tu non sei in grado di mantenere quel che hai promesso dietro compenso, io ti rovino.
Invidio mio padre che a settant’anni sta scoprendo il web: per lui è ancora un miracolo comunicare via internet; tra un po’ capirà che il vero miracolo è connettersi a internet.
La lettera di Claudia
 Il mio amico, collega e blogger Giovanni Villino mi porta a conoscenza di questa lettera. Credo che sia giusto darle il massimo della visibilità. Per stabilire come incazzarci al meglio rimando agli eventuali commenti.
Il mio amico, collega e blogger Giovanni Villino mi porta a conoscenza di questa lettera. Credo che sia giusto darle il massimo della visibilità. Per stabilire come incazzarci al meglio rimando agli eventuali commenti.
Palermo,16/04/2007
Mi chiamo Claudia P. e da anni presto la mia opera lavorativa nel settore del commercio.
Il mio curriculum vanta di un’esperienza decennale alle dipendenze delle più grandi aziende palermitane del settore commercio; nel Dicembre 2005 mi viene prospettata la possibilità di fare un colloquio per una grossa azienda nazionale che si è apprestata ad aprire i battenti a Palermo; superando brillantemente il colloquio, vengo assunta con un contratto a termine di sette mesi: contemporaneamente, però, la malattia di mio padre si aggrava e ci viene comunicato dai medici che urge un trapianto di fegato
In famiglia ci troviamo tutti inesorabilmente in un vortice affinché un organo possa salvare la vita di mio padre, che da anni combatte con lo spettro della malattia epatica.
La nostra ricerca non trova grandi risultati ma i tempi si stringono: bisogna fare qualcosa, i medici pensano ad una compatibilità familiare. Ci sottoponiamo tutti alle analisi preliminari; il mio fegato pare l’unico compatibile; nonostante i rischi e le obiezioni della mia famiglia, decido di fare quello che secondo me qualsiasi figlia avrebbe fatto per un padre: donare una parte del mio fegato.
Da allora in poi mi sono ritrovata ad affrontare un calvario fatto di day-ospital, prelievi, visite di controllo d’ogni genere. La cosa più grave e sconcertante è che quanto mi è accaduto, mi ha paradossalmente penalizzato nello svolgimento del mio lavoro, infatti, mi è comunicato improvvisamente che secondo l’azienda il mio profilo non è conforme a quanto richiesto dall’azienda stessa e ciò solo perché ho deciso di salvare la vita a mio padre.
Una settimana prima dell’intervento chirurgico, mi ritrovo fuori dal mio posto di lavoro, malgrado ciò l’intervento viene effettuato con successo sia per me sia per mio padre, ma rimane un grosso problema: provvedere al sostentamento della famiglia.
Finita la mia convalescenza, mi metto alla ricerca di un altro lavoro; la ricerca è vana e pesante, molte porte mi vengono chiuse in faccia anche dalle istituzioni, che promettono e non mantengono.
Finalmente si apre uno spiraglio e vengo contattata da un’altra grossa e conosciuta azienda a livello nazionale che ha molti punti vendita in città; mi viene offerta l’opportunità di un periodo di prova di 15 giorni con un conseguente contratto di 3 mesi.
Tuttavia, nonostante il mio impegno incondizionato e avendo messo a disposizione della medesima azienda il mio bagaglio d’esperienza decennale nel settore, mi viene bruscamente comunicato (senza alcuna motivazione specifica), che il mio profilo non è corrispondente alle esigenze dell’azienda, eludendo qualsiasi altra motivazione, ma lasciando intendere che l’intervento a cui mi sono sottoposta poteva essere l’unico motivo di esclusione (non essendocene altri!) per le eventuali conseguenze fisiche, nonostante la documentazione medica dell’ISMETT attestante il mio perfetto stato di salute.
Mi ritrovo ancora oggi senza lavoro e, nella desolazione della mia stanza mi ritrovo a scrivere uno sfogo personale che invio alle testate giornalistiche, perché è giusto che l’opinione pubblica sappia come sia crudele il destino per una ragazza che come me ha avuto il coraggio, senza nessun ripensamento alcuno, di aver salvato la vita al padre, non considerando che, oltre a fare a meno ad una parte del proprio fegato, avrebbe avuto precluso ogni possibilità di lavoro.
Ancora sui cinesi
 Ho visto ieri su Ballarò una presunta responsabile del commercio cinese in Italia, o comunque una rappresentante della comunità, affermare che quando i suoi connazionali arrivano nel nostro Paese per aprire un’attività commerciale hanno bisogno di tempo per capire le nostre regole (vedi leggi). Non ho nulla contro i cinesi e contro gli immigrati in genere. Anzi, nel nome di una società multietnica, ritengo che la ricchezza di una società stia nel suo assortimento razziale. Mi sono domandato però cosa mi potrebbe accadere se decidessi di aprire un’impresa in Cina chiedendo nel contempo un periodo di riflessione per capire quali sono le norme da rispettare. Risposta: sarei in galera. E le galere di un Paese che commina ancora pene capitali e che addebita ai parenti del morto il costo del proiettile non devono essere troppo confortevoli. Abbiamo ancora molto da imparare sulle regole del mercato che sono crudeli e fondamentali come il bilancio di una nazione e come il nostro bilancio familiare. Abbiamo ancora molto da imparare per distinguere un’immigrazione che arricchisce (per cultura, economia, religione, spirito di sacrificio) da un’altra che porta solo marchi contraffatti e rifiuto di ogni principio di integrazione.
Ho visto ieri su Ballarò una presunta responsabile del commercio cinese in Italia, o comunque una rappresentante della comunità, affermare che quando i suoi connazionali arrivano nel nostro Paese per aprire un’attività commerciale hanno bisogno di tempo per capire le nostre regole (vedi leggi). Non ho nulla contro i cinesi e contro gli immigrati in genere. Anzi, nel nome di una società multietnica, ritengo che la ricchezza di una società stia nel suo assortimento razziale. Mi sono domandato però cosa mi potrebbe accadere se decidessi di aprire un’impresa in Cina chiedendo nel contempo un periodo di riflessione per capire quali sono le norme da rispettare. Risposta: sarei in galera. E le galere di un Paese che commina ancora pene capitali e che addebita ai parenti del morto il costo del proiettile non devono essere troppo confortevoli. Abbiamo ancora molto da imparare sulle regole del mercato che sono crudeli e fondamentali come il bilancio di una nazione e come il nostro bilancio familiare. Abbiamo ancora molto da imparare per distinguere un’immigrazione che arricchisce (per cultura, economia, religione, spirito di sacrificio) da un’altra che porta solo marchi contraffatti e rifiuto di ogni principio di integrazione.
Non voglio sembrare un becero fascista, ma resto aggrappato a principi di uguaglianza e di legalità che non hanno colore né razza. Se la legge è uguale per tutti non è giusto dire cose uguali per tutti?
La nostra strage
 Ancora una strage in un campus americano, ancora giovani tra le vittime, ancora armi protagoniste, ancora sgomento, ancora una volta tutti noi a scrivere ancora una volta.
Ancora una strage in un campus americano, ancora giovani tra le vittime, ancora armi protagoniste, ancora sgomento, ancora una volta tutti noi a scrivere ancora una volta.
C’è un bel documentario del celebrato Michael Moore che prende spunto dalla strage alla Columbine School di qualche anno fa: allora i morti furono dodici, ieri sono stati trentatre (dato provvisorio per l’alto numero di feriti).
Abbiamo sempre bisogno di aggrapparci a qualche paragone quando ci troviamo davanti a scenari così apocalittici. Cadaveri in cifre, film al botteghino, politici e politiche permissive o no, gioventù bruciacchiate, i valori di un tempo.
E’ puro egoismo. Questa smania di dover avvolgere un fatto con carta vecchia o di altri per vedere se il pacco ci sta dentro oppure no è un modo di pensare ad altro che non sia nessun altro, è un espediente per pensare solo a noi.
L’evidenza che la follia umana è di tutti e che la testa fuorviata di quel giovanissimo killer potrebbe essere la nostra o quella di nostro figlio ci terrorizza a tal punto da dover arraffare uno, dieci, mille simboli da incollare sul petto dell’assassino: la lobby delle armi, la politica di Bush, la questione asiatica, l’incomunicabilità, i modelli sullo schermo (della tv, del cinema, del computer).
No.
La mattanza di Blacksburg è un orrore dei nostri tempi. Finiamola di aggrapparci alla geografia, gli Stati Uniti sono vicini quando ci conviene e lontani quando non ci conviene. Finiamola di perseguitare i miti, i nostri trend culturali ed estetici sono condizionati da ciò che si respira negli Stati Uniti salvo erigerci a culla della civiltà quando uno, oltreoceano, fa una cazzata. Finiamola di considerare migliori le idee più balzane, come molte ne vengono fuori negli Stati Uniti, e di non mettere nel conto gli effetti collaterali. Siamo un mondo che vive sotto lo stesso tetto, ormai. Se un grassone spara un peto in una mensa aziendale di Manhattan, la puzza arriva nel nostro tinello.
Gli scrittori e la realtà
 I servizi segreti inglesi studiano Sherlock Holmes per evitare il ripetersi di figuracce come quella delle fantomatiche armi di distruzioni di massa nascoste in Iraq. Il personaggio di Arthur Conan Doyle dovrebbe quindi venire in aiuto agli agenti dell’MI5 e MI6 principalmente con una frase che racchiude l’essenza di una saggia investigazione: “Non bisogna distorcere i fatti per adattarsi alle teorie, ma adattare le teorie ai fatti”.
I servizi segreti inglesi studiano Sherlock Holmes per evitare il ripetersi di figuracce come quella delle fantomatiche armi di distruzioni di massa nascoste in Iraq. Il personaggio di Arthur Conan Doyle dovrebbe quindi venire in aiuto agli agenti dell’MI5 e MI6 principalmente con una frase che racchiude l’essenza di una saggia investigazione: “Non bisogna distorcere i fatti per adattarsi alle teorie, ma adattare le teorie ai fatti”.
Sono sempre stato molto scettico sul ruolo sociale dei romanzi gialli, persino quando un magistrato ha candidamente confessato di aver riaperto un vecchio caso di omicidio dopo aver letto il libro di un importante scrittore italiano. Sono un tipo squadrato in tal senso: ognuno al suo posto, ognuno col suo mestiere, ognuno col suo fardello. Se un giudice ha bisogno di un narratore per sbrogliare una matassa si vede che lui e i suoi colleghi non hanno fatto bene il proprio lavoro. Al contrario, nel caso dei servizi segreti della Gran Bretagna mi convinco che sia giusto percorrere questa nuova strada: solo nella genialità e nella fantasia di grande scrittore si possono trovare rimedi ai pasticci delle vere spie.
Cinesi
 Italia – Cina, diciamo le cose con chiarezza. Gli italiani non potranno mai imbastire una reale integrazione con i cinesi per diversità che vanno esposte senza troppi giri di parole.
Italia – Cina, diciamo le cose con chiarezza. Gli italiani non potranno mai imbastire una reale integrazione con i cinesi per diversità che vanno esposte senza troppi giri di parole.
I cinesi sono persone laboriose, adottano la struttura sociale a nido d’ape e bastano a se stessi anche quando non hanno cosa farsi bastare. Sono prudenti e raramente fanno passi avventati. Se aprono un’attività commerciale in terra straniera hanno già fatto bene i calcoli e sono certi che il loro programma non può essere intralciato: prima o poi si compreranno l’intero quartiere. Non portano ricchezza alla nazione che li ospita poiché acquistano beni e servizi solo da altri cinesi e spediscono i risparmi in madrepatria.
Gli italiani sono persone chiacchierone, adottano la struttura sociale a nido di tagliatelle e non bastano a se stessi neanche se vincono al superenalotto. Sono amabilmente imprudenti e si incazzano se qualcuno dice loro che le tasse vanno pagate. Se aprono un’attività commerciale in terra straniera hanno già fatto bene i calcoli con le cosche locali e sono certi che con quello che hanno oliato, il loro ingranaggio girerà quanto basta per fare un gruzzolo e poter pensare ad altro. Portano ricchezza alla nazione che li ospita, ma solo se non sono obbligati a rilasciare ricevuta fiscale.
Fallimento
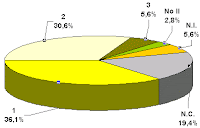 Piccola cronaca di un fallimento. Per un paio di settimane su questo blog ho proposto un sondaggio sullo slogan da suggerire a un candidato sindaco. Credevo che l’argomento fosse stimolante, data l’imminenza delle elezioni amministrative e l’invadenza della pubblicità elettorale: insomma è uno di quei temi ai quali, anche volendo, non si può sfuggire. Invece ho constatato l’assoluto fallimento di questa mia minima iniziativa: pochissimi votanti, nonostante i numeri molto soddisfacenti dei contatti quotidiani. Insomma, avete scansato l’argomento come la peste!
Piccola cronaca di un fallimento. Per un paio di settimane su questo blog ho proposto un sondaggio sullo slogan da suggerire a un candidato sindaco. Credevo che l’argomento fosse stimolante, data l’imminenza delle elezioni amministrative e l’invadenza della pubblicità elettorale: insomma è uno di quei temi ai quali, anche volendo, non si può sfuggire. Invece ho constatato l’assoluto fallimento di questa mia minima iniziativa: pochissimi votanti, nonostante i numeri molto soddisfacenti dei contatti quotidiani. Insomma, avete scansato l’argomento come la peste!
Non sono l’unico a dover essere deluso però. Ho fatto un giro nel web sui principali siti politici (candidati e partiti) e anche su importanti blog cittadini: laddove viene sollecitata l’interattività la partecipazione è scarsa e perlopiù pilotata.
Craxi ammoniva i suoi: “La politica o si fa o si subisce”.
Nell’era della comunicazione globale la politica si dispiega su cittadini annoiati. E per non contribuire a far salire di livello la noia disintegro sondaggino e risultati del medesimo.
Il passato e la scrittura
 Qualche anno fa, quando non eravamo troppi su internet, c’era una comunità di appassionati di scrittura e di lettura che sul web popolava siti paritari e salvifici. Tutti uguali: scrittori, lettori, giornalisti, bibliofili, talent scout, editor, bestselleristi, critici. Tutti salvi: si scriveva, si leggeva, ci si confrontava, c’erano stroncature e promozioni ogni sera ma c’era un giudizio. Ci si ritrovava senza ipocrisia e garantiti da un nickname su siti e forum che si fondavano su una cosa antica: la parola scritta.
Qualche anno fa, quando non eravamo troppi su internet, c’era una comunità di appassionati di scrittura e di lettura che sul web popolava siti paritari e salvifici. Tutti uguali: scrittori, lettori, giornalisti, bibliofili, talent scout, editor, bestselleristi, critici. Tutti salvi: si scriveva, si leggeva, ci si confrontava, c’erano stroncature e promozioni ogni sera ma c’era un giudizio. Ci si ritrovava senza ipocrisia e garantiti da un nickname su siti e forum che si fondavano su una cosa antica: la parola scritta.
Ieri sera, approfittando di un raro momento libero ho ricominciato a spulciare tra i miei “preferiti”: Solotesto, Writerscorner…
Non esistono più. E sono solo due esempi di siti minori.
Progetto Babele, al quale nel passato ho affidato un mio racconto a puntate, vede come ultimo aggiornamento un editoriale del maggio del 2006.
Non sto qui a raccontarvi la mia tristezza, specie in un momento in cui si parla di web.02, una nuova concezione della Rete fatta di idee e di contenuti degli utenti.
La morte di queste iniziative e il conseguente trionfo di scatole vuote come Youtube e MySpace consacra la supremazia dell’effimero sul divertimento puro, della confezione luminescente sul contenuto succulento. Per chi non ha vissuto quella stagione queste potranno sembrare parole vuote e vecchie. Per chi invece ci è passato sa di bel passato.

