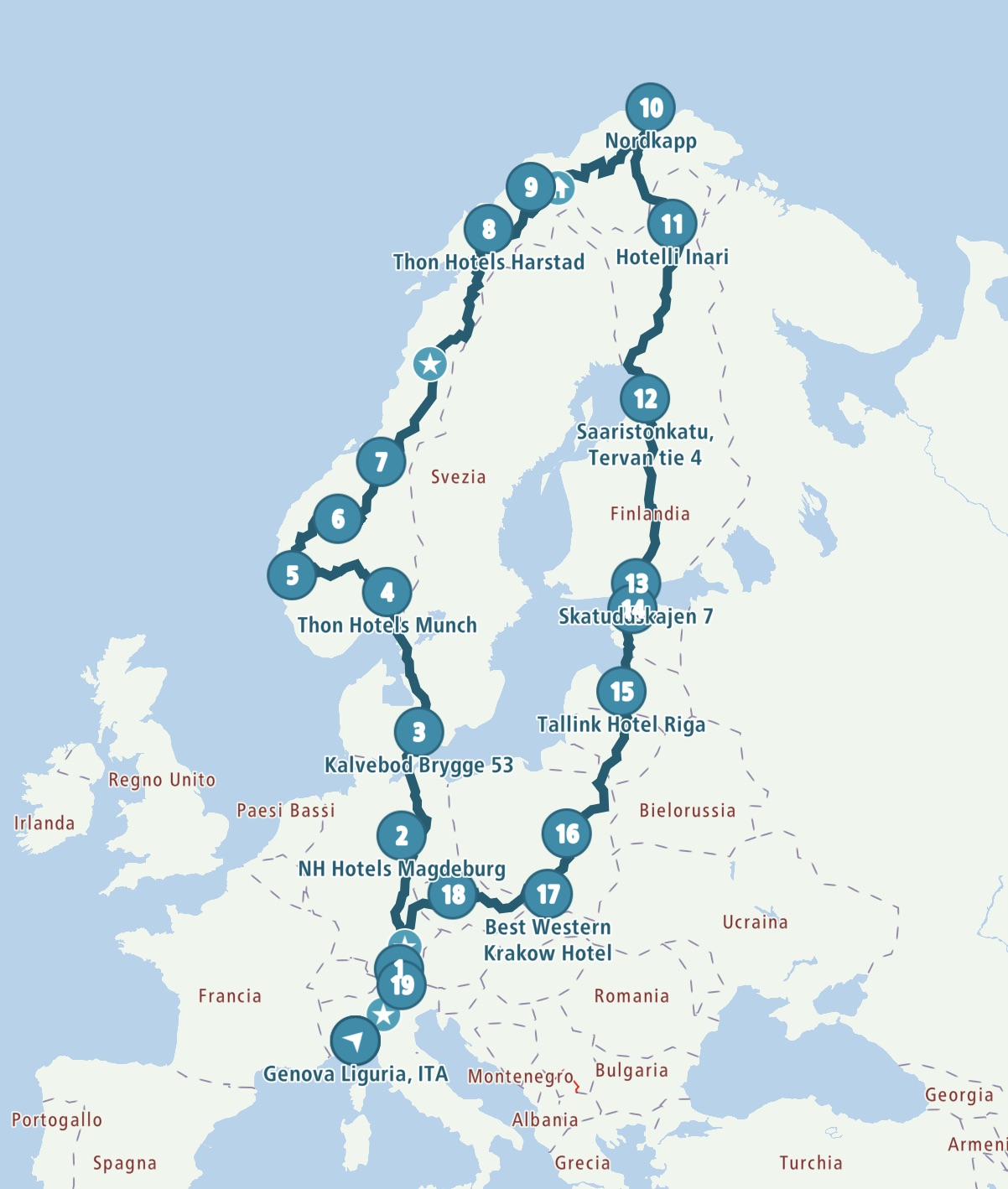Da Islares a Santoña.
Da Santoña a Güemes.
Strapiombi. Ho sempre avuto un’attrazione per gli strapiombi. Una sorta di vertigine alla rovescia, il vuoto che mi incuriosisce anziché spaventarmi. Nulla a che vedere con una forma di attrazione patologica: di deviazioni psicologiche ne ho ben altre e, ritengo, molto più divertenti.
Questa è una passione che origina dall’infanzia, dall’arrampicata sugli alberi di cui ho già parlato qui, e che ieri ha trovato degno coronamento in un sentiero impervio tra Liendo e Laredo. Poche centinaia di metri scoperti, cioè senza nessun tipo di protezione, ma con un panorama mozzafiato (ho postato qualche filmato sui social). Ci sono costoni di roccia che finiscono sull’oceano Atlantico e laddove sono percorribili – sempre con grande attenzione – regalano emozioni indelebili. Parola di ex arrampicatore.
Anche stamattina il Cammino ha fatto la sua parte nel titillare questa mia attrazione: la partenza da Santoña sul colle del Brusco è uno dei tratti più ripidi che abbia mai percorso, ma la vista sulla spiaggia di Berria, dove ieri ho fatto il bagno, è qualcosa che ripasserò inverno dopo inverno, magari in un noioso mercoledì pomeriggio, inutilmente buio e piovoso (la foto sopra non rende, ma serve per capire).
Questo per dire che il Cammino apre molti cassetti: alcuni li credevamo chiusi, di altri non conoscevamo manco l’esistenza. Quando ti ricapita di stare solo coi tuoi pensieri, in scenari inauditi, sotto effetto di endorfine per gran parte della giornata? E quando ti ricapita di non avere alibi e poter finalmente affrontare, senza rotture di coglioni, le discussioni più complicate, quelle con te stesso?
L’effetto straniante di questa esperienza, visto come sconvolgimento della percezione abituale della realtà, è ogni giorno più evidente. E non è una cosa facile da spiegare: uno pensa alla vacanza, alla distrazione, al chi se ne frega… No, qui la cosa è molto diversa perché sai che alla fine questo effetto non svanirà col ritorno alle solite cose. Sai che ti darà una tridimensionalità non usuale: parlatene con chi ha fatto ciò che sto facendo io e capirete perché molti di loro si buttano nel Cammino più volte. E non è fanatismo, ma il suo esatto opposto: tolleranza coltivata in modo estensivo, latifondismo delle idee.
Comunque è inutile recensire l’aria, o la si respira o niente. Quindi o vi mettete in marcia oppure accettate la posizione di retroguardia, che è quella di chi guarda gli altri che fanno, di chi accetta una verità ottriata.
Più si va verso Santiago – e siamo ancora distanti – più cresce l’empatia con gli abitanti del luogo. Soprattutto gli anziani, soprattutto nei piccoli centri. A Guriezo un signore sulla settantina mi ha incrociato e mi ha augurato il buen camino di rito. Poi, non contento mi ha agganciato con la mano – una mano fresca e pulita come quella di una persona che prima di uscire da casa si è lavata e profumata con la colonia – e mi ha chiesto da dove venivo. Gliel’ho detto e lui ha cominciato a raccontarmi la storia di un viaggio che lui aveva fatto molti anni fa in Italia, in pullman, da Genova a Roma a Palermo: lì sul ciglio di un sentiero, alle nove di mattina, lui con la sua camicia fresca e il suo sguardo pulito (perché le mani e lo sguardo sono collegati, sappiatelo), e io con la mia maglietta ancora umida di lavaggio e la mia faccia da boxeur senza pugni. Mentre raccontava, nel suo spagnolo fragrante, mi sono incagliato in una ipotesi canagliesca che riguardava il suo viaggio in Italia: l’ho visto su una specie di carro bestiame gommato, tra bancarelle di paccottiglia, ristoranti-truffa, gruppi vacanze al limite del criminale… Poi, però, all’angolo del suo occhio sinistro è apparso un luccichio. Quella memoria gli aveva risvegliato qualcosa. La memoria è un cane fedele a un padrone che non sei tu. La sua stretta si è fatta più forte fino a quando non ha pronunciato una parola che non ho capito ma che temo fosse un nome proprio di persona. Non ho avuto il coraggio di chiedere, di sottilizzare.
Ma chi cazzo siamo noi per esigere sempre spiegazioni? Ci è mai passato per la mente, in quest’èra di ultime parole usurpate, di furto aggravato della ragione, che se non capiamo qualcosa è solo colpa nostra, fottutamente nostra?
Quell’uomo mi ha lasciato andare solo dopo un lungo silenzio, e tra sconosciuti cinque secondi senza una parola, guardandosi in faccia, sono un’eternità che segna. Lui con la sua camicia fresca di prima mattina, e io con una faccia da boxeur in vacanza ora illuminata di un luccichio all’angolo di un occhio.
Che ho nascosto come un ladro, per liberarlo durante il mio Cammino.
Senza alibi, da solo.
(10 – continua)
Le altre puntate le trovate qui.
A questo argomento è dedicato il podcast in due puntate “Cammino, un pretesto di felicità” che trovate qui.