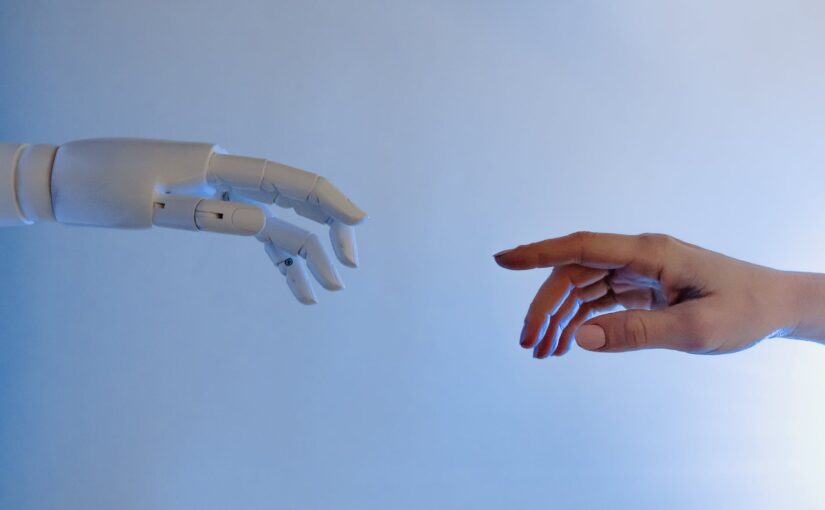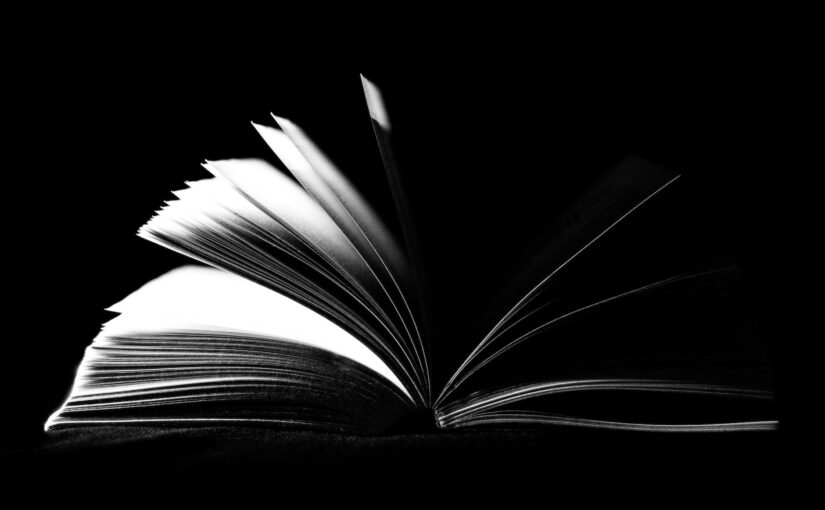Lavorando in un teatro d’opera, scrivendo per mestiere e invecchiando con allegra libertà sono sempre alle prese con le esigenze (altrui) di purismo. Avvertenza per il lettore: il concetto di purismo che qui affronto non ha nulla a che fare con lo storico movimento che tende(va) “a considerare la tradizione linguistica nazionale come qualcosa che deve essere mantenuto incontaminato da influenze lessicali, sintattiche, morfologiche e fonetiche straniere non solo per ragioni funzionali ma anche per ragioni affettive”. Il “mio” purismo ha più a che fare con una stretta osservanza della tradizione, con l’inchino nei confronti di ciò che è classico: diciamo che è qualcosa che sta sull’altra sponda rispetto all’innovazione; non distante, ma di fronte.
Questo tipo di atteggiamento conservatore non va deprecato, è legittimo e ha una sua utilità: i custodi dell’ortodossia servono sempre, sono depositari di una quota di memoria che non va usata come catalizzatore di nostalgie, bensì come perno sul quale far girare nuove idee.
In particolare mi interessa qui ribadire un antico concetto sulla modernità (e ci scappò l’ossimoro): il fatto che il futuro avanza inesorabile non vuol dire che il passato non serva più a nulla.
Negli ultimi mesi ho avuto a che fare con giovani e giovanissimi in università e scuole. Ho incontrato ragazzi in gamba e meno in gamba, autentici gioielli e figure opache. Ma tutti mi hanno scioccato su una cosa: non conoscono i giornali. Alla domanda “dimmi i nomi di almeno due giornali siciliani” praticamente nessuno di loro è stato in grado di darmi una risposta esaustiva.
Se avessi seguito la mia logica novecentesca avrei dovuto indignarmi, ma siccome occuparsi di futuro significa sforzarsi di galleggiarci dentro, ho tirato un sospiro e ho realizzato che quella è la loro ortodossia, è il principio della loro nuova memoria. I giornali sui quali siamo cresciuti, su quali ci siamo accapigliati non esistono più. Esistono altri prodotti, contaminati e un po’ emergenziali, che dovranno imparare a gestire uno dei beni più importanti per la crescita di una generazione: il sapere della cronaca.
Non voglio sbilanciarmi, ma credo che nelle aziende editoriali le idee non siano troppo chiare in tal senso. A ogni modo queste righe non servono per ispirare nuove fabbriche di news, ma per scavare sentieri per il nuovo pubblico: che sia giornale, teatro, cinema, libri, il sistema dell’apprendimento è un flusso che scorre tra due capi e se ne manca uno, non funziona un bel niente.
Il nuovo pubblico dobbiamo essere noi a plasmarlo, intercettando le sue inclinazioni ma mantenendo il nostro diritto a sperimentare. I successi di oggi non hanno nulla a che fare con quello che accadrà l’anno prossimo. La logica di un aureo mantenimento, come un salvagente per non annegare, è proprio quella perdente. Se c’è un momento in cui bisogna rischiare, credo che sia questo: sparigliando, scommettendo.
Il purismo crede di essere un baluardo della preservazione di un bene comune, mentre rischia di esserne il killer più spietato.
Serve coraggio per imbastire nuovi programmi che guardino a dopodomani, programmi che magari non ci risultino pienamente compiuti ma che ci creino suggestioni: il futuro inizia sempre con una sensazione vaga.
Serve la saggezza di dire “io questa cosa non la so fare quindi mi rivolgo a chi la sa fare”.
Serve soprattutto finirla di essere isole senza traghetto e cominciare a ordire trame a lungo termine, tutti insieme, senza preclusioni. E questo è il più difficile dei banchi di prova di chi amministra, di chi governa, di chi decide e sceglie con chi decidere.
Se ci fosse un partito per la cultura del sano stupore lo voterei immediatamente.