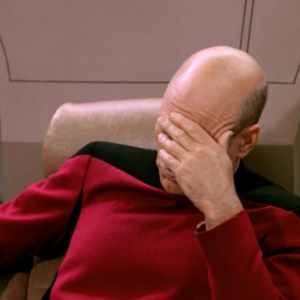Se c’è una cosa che lo stare soli per scelta ti aiuta a valorizzare, è la conoscenza delle cose. Non è che se vai in eremitaggio o ti chiudi in casa per un mese poi, alla fine, sei più colto. Però è probabile che sia più consapevole.
Vi faccio il mio esempio. Dopo un mese di Cammino portoghese, bellissimo e che consiglio, mi sono beccato per la prima volta il Covid. Da quattro giorni sono murato in casa e solo oggi sono in grado di scrivere due righe incatenate poiché sono stato con 38,8 fisso mattina e sera con rincoglionimento totale.
Quindi quest’estate ho sperimentato due tipi di solitudine, molto diversi tra loro eppure complementari: quello del Cammino tutto fatica e larghi orizzonti e quello del Covid tutto brividi da fermo e vista confinata. Senza il primo non avrei valorizzato il secondo, ve lo confesso.
Perché il Covid che mai avevo conosciuto – sono un iper vaccinato e iper anti-antivaccinisti, tifoso della medicina e nemico delle scemenze – mi ha fatto conoscere qualcosa di me e delle mie reazioni. Sono uno che vive da solo, quindi i momenti di malattia sono una bella prova: se non stai bene solo con te stesso quando sei in forze, figuriamoci appena hai un problema di salute. La febbre non era quella dell’influenza, parlo di sensazioni eh. Era come un motore di grossa cilindrata costretto e contenuto: si capiva che voleva rombare, ma qualcosa lo costringeva, lo soffocava. Era questo che non mi faceva dormire la notte: sentire questo rombo persistente, fisso, che non cala mai e che ti dice “se fosse per me esploderei”.
È lì che ho valorizzato la conoscenza dei vaccini. Non per quel virus dentro di me, ma per il sistema di contagio mondiale che è stato depotenziato grazie alle vaccinazioni. Insomma quel brutto motore dentro di me è domato grazie ai vaccini di tutti voi e se fosse stato per quegli imbecilli della dittatura sanitaria di ‘staminchia, quelli del microchip (che a loro un microchip servirebbe davvero, ma nel cervello), io magari a quest’ora sarei boccheggiante in un ospedale o chissà. Invece sono qui a scrivere, deboluccio, ma con la luce e l’umore giusti.
La conoscenza è anche saper mettere in fila le cose nel modo adeguato. Durante i miei cammini ad esempio ho imparato che i muscoli si allenano, quindi poi hanno meno bisogno di riposo, ma i tendini e le ossa sono quelli più a rischio, e che metterli a riposo è complicato (solo oggi, dopo quattro giorni di completa inattività i miei talloni e le mie caviglie tornano a darmi confidenza). Durante il Covid invece ho imparato che non si può usare una pubblicità di oltre un decennio fa di Dolce&Gabbana per stigmatizzare un crimine come lo stupro. È una stupidaggine anzi peggio è una scorciatoia dei social che rende chi la prende credulone: tipo uno che crede di raccontare una barzelletta nuova quando quella storiella la raccontava Gino Bramieri, 40 anni fa, meglio di lui ovviamente. La storia la scrivono gli storici, non l’utente456 di Facebook.
Non si può ignorare di ignorare.
Ecco perché un po’ di solitudine aiuta. Perché ti toglie l’alibi di condividere i passi che non sono tuoi, ti insegna a sperimentare sulla tua pelle, toglie potere ai polpastrelli e lo dà a sensi che normalmente usi poco, come l’olfatto (anche se durante il Covid…). Perché ti obbliga a smettere per una volta di essere pecora in un gregge di cui manco sai chi è il pastore.