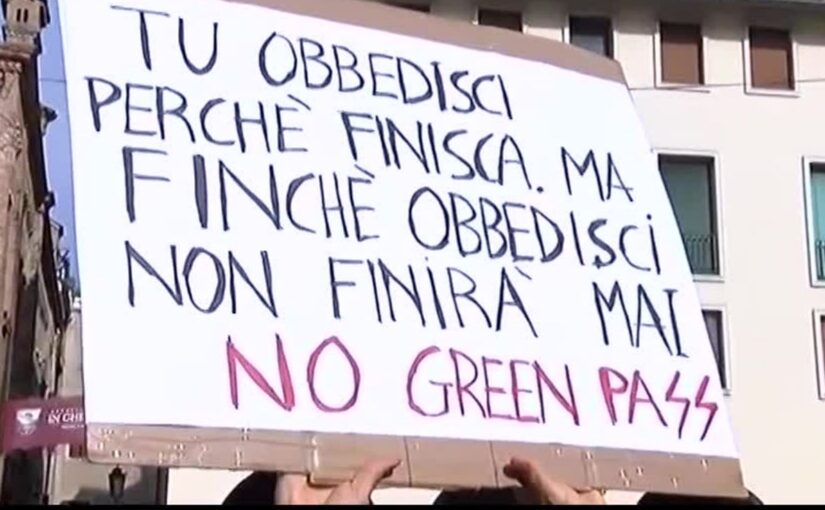Perché gli scienziati stanno anni a violare la privacy di un moscerino? Perché allevano topi? Perché studiano una particolare tartaruga? Perché per ricerche che vanno dallo scorpione africano a una nuova navicella spaziale spendiamo un botto di soldi? Perché ci sono laureati pagati per scrutare il cielo di notte?
C’è una risposta breve che riguarda il nostro nuovo modo di comunicare: perché la scienza è il contrario di un social network in quanto guarda lontano, non è interessata alla compulsività e cerca dove nessuno ha trovato. Quindi in un mondo stratosfericamente diverso da una qualsiasi timeline.
La risposta più lunga invece riguarda la lungimiranza e la caparbietà. La dottoressa Katalin Karikò e il dottor Drew Wiessman iniziarono le loro ricerche sull’Rna messaggero una ventina di anni fa, quando il Covid non esisteva neanche nei nostri incubi peggiori. Nel 2023 hanno ricevuto il premio Nobel per una scoperta che fecero nel 2005. La loro ricerca, come quella di moltissimi altri scienziati, non si occupava di cose pratiche (brevetti, applicazioni immediate) ma di conoscenza e di comprensione dei fenomeni naturali. Funziona così nella scienza, lo sa chi ha studiato come sono stati scoperti i raggi X o gli antibiotici.
Guardare dove gli altri non hanno trovato.
Sopportare chi ti accusa di perdere tempo.
Schivare chi cerca la monetizzazione immediata.
Questo fanno gli scienziati e gli innovatori in generale, ma soprattutto gli scienziati, che stanno agli antipodi dei nuovi arroganti di cui parlavamo qualche settimana fa. Molto dobbiamo a questi discreti signori che spiano moscerini, allevano topi, seguono la vita di una tartaruga, tampinano lo scorpione africano perché hanno intravisto qualcosa. Sono persone che non solo hanno una testa (!!!), ma ce l’hanno che rimbomba di domande: come? Perché? E nel cercare una risposta costruiscono un mondo che può illudersi di essere migliore (dove chi studia sta al timone e chi non sa nulla prende ordini senza fiatare).
P.S.
L’ultima parentesi mi è scappata dalle mani, ma fate finta di niente…