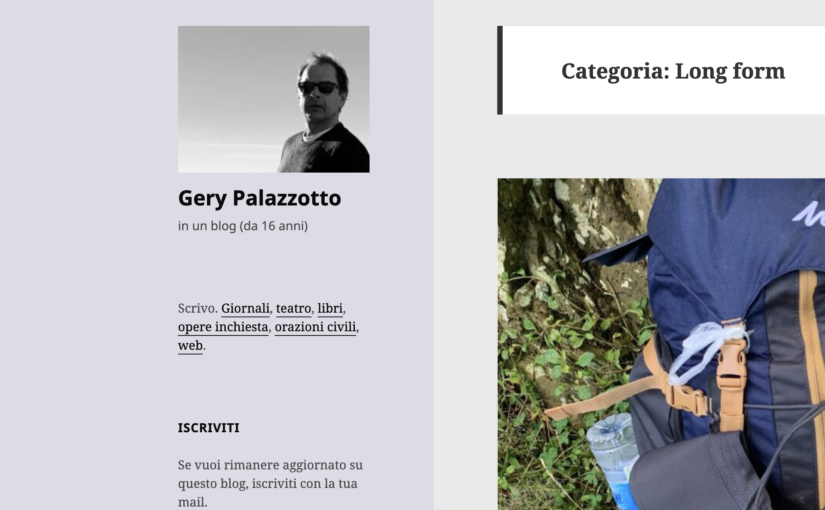Riprendiamo la sana abitudine di parlare di musica. I Can’t Go For That (No Can Do) di Daryl Hall & John Oates è una canzone che nasconde molte storie. La prima, quella più suggestiva, riguarda Michael Jackson che ammise di essersi ispirato a quel giro di basso per la sua Billie Jean: il pezzo di Hall & Oates è nel loro album capolavoro “Private Eyes” del 1981, quello di Jacko è dell’anno seguente inserito in “Thriller”, l’album più venduto di tutto i tempi.
La seconda storia è quella più laterale e riguarda il testo: si pensava in modo istintivo a una relazione d’amore che non poteva andar avanti, ma in realtà, spiegarono gli autori, erano parole ispirate all’esigenza di maggiore libertà in ambito discografico, imprenditoriale (un po’ come Easy dei Commodores per decenni immaginata come una canzone d’amore mentre è lo sfogo di uno che si è liberato di una partner che non sopportava più) . Si narra che I Can’t Go For That (No Can Do) venne fuori da un giro di basso composto da Daryl Hall utilizzando un organo Korg, annodato al ritmo di una drum machine, una delle prime batterie elettroniche usate in modo tosto.
Ma la cosa più interessante è l’uso dei campionamenti che di questa canzone è stato fatto nei decenni. Di seguito varie forme di I Can’t Go For That (No Can Do), ognuna col suo magico senso di unicità
Hai visto Lost?
C’è un anniversario niente male che sta passando in sordina. Riguarda i 13 anni dall’ultima puntata di Lost, puntata su cui si discute da allora, dove c’è questo dialogo tra padre e figlio che spiega l’inspiegabile (“In fondo nessuno muore da solo”).
Come alcuni affezionati lettori sanno, sono un estimatore della serie in questione e la ritengo uno snodo fondamentale della narrazione televisiva: siamo infatti ai confini del cliffhanger di cui parlavo qui e in prossimità di una nuova frontiera, quella del binge watching (vale il link di 18 parole fa).
Ha raccontato Luca Sofri che un giorno “una quindicina d’anni fa un neonominato direttore di un giornale, che voleva avere attenzioni alla contemporaneità e alle culture dei millennials (che allora nessuno chiamava così), gli chiese dei consigli per aggiornarsi: e lui gli rispose «hai visto Lost?». (non lo aveva visto)”.
Perché la dirompenza di una serie che ancora oggi fa discutere è proprio la sua eterna contemporaneità, quasi un ossimoro, in quanto serie fuori dal tempo e dai tempi: credo che dal punto di vista meramente tecnico in Italia solo Pasolini abbia saputo esplorare narrativamente terreni così incolti e difficili.
La forza propulsiva si basa, oltre che sui personaggi e sulla genialità del creatore J.J. Abrams, sui cosiddetti sideways, elementi cinematografici laterali che non raccontano una realtà alternativa: è questo un concetto fondamentale per entrare nello spirito innovativo di Lost. Perché nel corso delle stagioni ci sono i flashback e i flashforward, cioè i viaggi indietro e avanti nel tempo.
Ma ciò che accade nei sideways, nella logica della serie, non è mai successo per davvero. Essi inquadrano un mondo che non ha una precisa collocazione nello spazio e nel tempo. Quindi vanno presi come inserimenti che non influiscono, non devono influire, nella plausibilità della storia: che è tutto tranne che plausibile, e per fortuna.
Detto questo è facile smontare teorie – peraltro divertenti – tipo quella secondo la quale i 48 passeggeri sopravvissuti all’incidente che dà origine alla storia – quando il 22 settembre 2004 l’aereo di linea 815 della compagnia australiana Oceanic Airlines, in volo da Sydney a Los Angeles, precipita su un’isola apparentemente disabitata – erano già tutti morti al momento dello schianto.
No, l’isola è un luogo in cui si celebrano le paure del mondo, in cui si combatte una guerra senza tempo tra il bene e il male, è soprattutto una meravigliosa infinita ode alla ciclicità delle maledizioni e un antidoto al mefitico lieto fine obbligato che non esiste (del resto la fine non è mai lieta, semmai può essere indolore).
Insomma Lost ci insegna non solo come si scrivono le sceneggiature anche quando non hai la minima idea di dove le tue fantasie ti porteranno, ma soprattutto come si guarda un’opera complessa come quella che non deve per forza consolarti, non deve per forza essere un ABC con tanto di disegnino, non deve per forza esaurire la sua spinta emotiva dopo l’ultimo dei titoli di coda.
Se non l’avete mai vista, guardatela. Molto e molto altro vorrei dirvi, ma non voglio spoilerare ulteriormente la serie più spoilerata della storia.
Se l’avete vista e volete riviverla in brevi riassunti, qui c’è qualcosa che vi può interessare.
Il dio ateo del web
Ci sarà un dio del web e sarà pure un pazzo. Sarà burlone e ingiusto, ma è un dio che ci sa fare con gli affari. Fiuta la preda, la insegue e la fa sua: senza finirla, anzi iper-alimentandola e spingendola verso la bulimia. Più lei consuma, più il dio è soddisfatto. Più lei consuma, più lei stessa è sfiancata. Funziona così nel regno del web, nel cielo dei cieli telematici dove vive e regna nei secoli dei secoli il dio algoritmo.
Da Netflix a Angela da Mondello, dal feed di Facebook agli spari a J.R (il cattivo di Dallas), dal Giornale di Sicilia al Teatro Massimo, dal sesso di Apple alla lumaca di Pirandello: ferite e cicatrici in nome dell’innovazione. Questo podcast prova a raccontarle con chiarezza, insomma senza toccarsela con la pinzetta.
P.S.
L’esigenza di essere chiaro non mi mette al riparo dagli errori. Mi scuso per la pronuncia di binge watching che andava con la g dolce, come mi è stato fatto notare… Pardon.

‘Sto Fazio
Non trovo scandalo nell’addio di Fabio Fazio alla Rai perché sta nelle regole del gioco di tutti i precari (seppure di lusso) scegliere di sbagliare da soli o lasciarsi tentare da offerte vantaggiose. Provo fastidio invece per una pervicace sottovalutazione della qualità da parte della classe dominante (politica, economica, sociale) di questo Paese. La logica, molto diffusa sui social, del “tanto non mi piaceva se ne vada a quel paese” è abbastanza pericolosa se estesa a un modello. Il governo di un’azienda pubblica, e persino di quello – azzardo -di un’azienda privata, non si deve basare sul sentimento personale. Per un motivo semplice: perché è tipico delle dittature. La prima cosa che fa un tiranno, è mettere i propri gusti, le proprie manie, le proprie inclinazioni, soddisfazioni, aspirazioni in cima alla lista delle cose da fare.
Quindi una cosa è giudicare, un’altra è amministrare. Ad esempio, io odio la carne rossa e metterei al rogo – tipo sulla carbonella domenicale – tutti quelli che azzannano costate, cotolette e fiorentine. Ma siccome sono solo io che ne scrivo qui tutti vi fate una risata, ma se fossi chessò Kim Jong-un e voi foste i miei sudditi nordcoreani avreste ben poco da scherzare.
Il problema, che molti filosofi contemporanei come Daniel DeNicola stanno affrontando seriamente, è che molto probabilmente non abbiamo il diritto di credere in ciò che vogliamo (ne parlerò domani in un podcast proprio da queste parti).
Scrive DeNicola: “Credere in qualcosa significa ritenerlo vero ma questo non implica in modo automatico che quella convinzione lo sia realmente. Le credenze, per la maggior parte, non sono atti volontari, ma piuttosto idee e atteggiamenti. Il problema è rifiutare questo genere di ‘eredità’ quando si tratta di una credenza eticamente sbagliata – come considerare la pulizia etnica una soluzione politica accettabile. Se una convinzione è immorale è anche falsa. Sostenere, per esempio, che una razza sia inferiore a un’altra, non solo è moralmente ripugnante, ma è anche sostanzialmente falso. Le credenze inoltre hanno uno stretto rapporto con la realtà e con la sua conoscenza: attribuire a un’autorità il fatto che dobbiamo credere in una cosa, oppure negare un avvenimento certo o ancora ignorare evidenti incoerenze è un atto di irresponsabilità, somiglia piuttosto a voler abbracciare un desiderio. Per questo la libertà di credere deve avere dei limiti”.
Questo discorso è strettamente collegato alla questione Fazio perché può contribuire a inquadrare la vicenda in un ambito più ampio e per questo meno piccolo, parziale, angusto.
Siccome Fazio costa, una parte populistica della politica – che non è solo di destra anzi – ci ha indotto a pensare che è bene che se ne vada così si risparmia.
Siccome Fazio è legato a una storia di sinistra, tutti quelli che di sinistra non sono, tirano un sospiro di sollievo come se la qualità fosse appesa all’arco costituzionale.
La qualità, ecco.
Il nodo è la qualità.
Ma non nella televisione italiana, non negli inquilini delle stanze del potere, non nell’esercito dei polpastrelli del web. La qualità è un’emergenza di questo Paese di voltagabbana, di cognati miracolati, di twittatori ministeriali, di analfabeti al comando, di panzane etniche, di disuguaglianze esibite come un trofeo, di refusi imbarazzanti in ogni dove.
Fabio Fazio è uno che sa fare il suo mestiere e che fa un prodotto di qualità (che piaccia o meno non conta una cippa, vedi le prime righe di questo post). Una tv pubblica che lo lascia andare altrove dovrà trovare un prodotto di altrettanta qualità per sostituirlo. Ed è allarmante che alla Rai si mostrino sereni e quasi soddisfatti: perché è delle cose che pericolosamente si ignorano che solitamente si ha un’opinione migliore.
Chiamata senza risposta
Racconto un’impressione, il succo di mie esperienze, e magari chiedo il vostro parere però argomentato cioè non “giusto” o “sbagliato”, non “minchiate” o “sante parole”.
È una cosa che riscontro ormai da un paio di anni, diciamo dalla pandemia in poi.
Prima la short version. C’è un ritirarsi dai contatti umani, una ricerca spasmodica della scorciatoia: messaggi, mail, brevi rimbalzi di frasi. Occhio: parlo di contatti in generale, quindi in primo luogo di cose di lavoro, di relazioni istituzionali, molto meno di affari privati (lì, in fondo, siamo quel che ci meritiamo di essere e vaffanculo).
Poi la long version. Mi appare sempre più lontana la logica interazione tra uno che chiede con tutti i suoi punti interrogativi e uno che risponde con tutti i crismi. I telefoni si ingolfano di chiamate senza risposta, le mail si perdono in tread senza un esito. Prima, sino a poco tempo fa, c’era il gusto anche perverso del contraddittorio: nella mia vita (fortunata) ho avuto scontri epici nelle aziende in cui ho lavorato ed estenuanti botta e risposta con amici, colleghi, compagne, familiari. C’era il piacere della scintilla che, va ricordato, serve sempre per accendere: che sia polemica, idea, amore, sempre fuoco è.
Oggi, da un paio di anni (come sopra), non è più così.
Come se una regina della rassegnazione si fosse impadronita dei territori della nostra vita sociale, tutto scorre senza scorrere. Gli intoppi delle risposte mancate generano laghetti di indolenza, i feedback sono grottesche emoticons, il luogo comune non è più né luogo né comune.
Il nulla.
Discussioni che potevano accenderci (e magari farci incazzare in modo memorabile) si arenano in una faccina whatsapp che rimanda a un deprimente “avanti il prossimo”. Dittature della mediocrità mettono al timone capitani abili del loro navigare nel nulla senza tener conto che nel nulla non si naviga, ma nel migliore dei casi si annega.
È un tema che ci riguarda tutti, come cittadini di città senza un cuore fuori dall’account Instagram dei suoi amministratori, come professionisti di aziende che spesso ridacchiano della meritocrazia, come esseri sociali pigri e rassegnati, come intelligenze che esistono anche lontano da una chat.
Non sono mai stato un nostalgico e – va detto – campo anche grazie alla tecnologia. A dispetto delle recenti suggestioni su intelligenza artificiale e affini, gli sgambetti più fastidiosi li ho (avuti) dagli umani. Che restano ancora la fonte principale delle mie delusioni e della mia felicità.
Ecco, alla luce di tutto questo dovrei farvi una domanda, ma in fondo è inutile che ve la faccia. Perché se vi siete riconosciuti in queste righe, come me cercate risposte, altro che domande.
Però grazie di questo minuto e mezzo di attenzione: un’eternità di questi tempi.
La libertà non è una preda
Settore long form, al confine tra la regione dei cazzi miei e quella della mobilitazione civile. Ieri a Palermo c’era un appuntamento delle Famiglie Arcobaleno alle quali sono particolarmente affezionato per motivi che qui è inutile spiegare.
Per loro ho scritto un breve monologo – recitato da Gigi Borruso per le parole, e da Fabio Lannino per le note – liberamente ispirato all’opera “L’altro” che andrà in scena al Teatro Massimo di Palermo, il 22 giugno prossimo.
Per chi non c’era, e per chi c’era ma ama pensare di non esserci stato perché riassaporare è gustare due volte (ah, che meravigliosa debolezza!), ecco il testo.
Avete presente l’estintore del supermercato, incorniciato nella sua vetrinetta col megafono e la scritta: “Usare solo in caso di incendio”?
Ci avete mai pensato che in realtà vi sta dicendo: “Minchia, ho detto solo in caso di incendio!”
Ecco, il concetto è quello.
Il problema del “tempo di pace” è che funziona solo in funzione dei “tempi di guerra” in cui è incastonato, quindi si porta appresso una vagonata di incomprensioni.
Domande.
È giusto pensare al peggio quando si sta benissimo?
Esiste una zona franca delle intenzioni?
Chiunque si dia dato la pena di sopravvivere sa che il filo sul quale ci muoviamo, da acrobati improvvisati quali siamo, è solido.
Che il vero problema è la nostra capacità di rimanere in equilibrio. E l’equilibrio è solo un artifizio metaforico che non garantisce un bel nulla: esistono persone infide e disequilibrate che se la passano infinitamente meglio di esemplari umani corretti e ottimamente bilanciati. Questo è il labilissimo confine tra ingiustizia e figata, tra religione ed epopea della bestemmia.
Quando ci sono problemi che non ci interessano, nel senso che manco lambiscono il nostro orticello, generalmente ci rifacciamo a una parte intermedia del nostro corpo, che non è né capo né piedi, né arto né vessillo: le spalle.
Alziamo le spalle.
Voltiamo le spalle.
E ci trinceriamo dietro alle cinque parole più pericolose del nostro universo.
Non
Può
Succedere
A
Me
Credere nel “non può succedere a me” è come comprare le azioni di una società di cui non si conosce il prodotto, come salire su una macchina del tempo che ha le marce bloccate.
In realtà le cose accadono a tutti, nessuno escluso, e quelli che si ritengono in salvo, o sono incauti e lo sanno, o sono defunti e non lo sanno.
Se io non ho figli e non ho intenzione di averne, se sono eterosessuale e strafottente, se sono omosessuale ed egoista, se sono bianco o nero, alto o basso, vero o falso, se mi piaccio come normale in un mondo anormale o come anormale in un mondo normale, posso misurare tutti i passi incauti che mi separano dal mio pregiudizio, posso alzare o voltare le spalle e gridare:
Non
Può
Succedere
A
Me
Ma una cosa sola non posso fare: usare la libertà come una preda.
I custodi della tradizione con la T maiuscola, i detentori del libretto di istruzioni della vita con la V maiuscola hanno un problema col tempo.
Il tempo non passa invano. E rendersene conto è già un bel regalo che possiamo farci.
Loro, quelli del libretto delle istruzioni, del manuale Cencelli applicato al sentimento non sanno che comunque sia, qualcosa ci ha lasciato detto, il tempo.
Non sanno che non è vero che si stava meglio quando si stava peggio: quando si sta peggio ci vuole poco a sentirsi meglio e non c’è vergogna a spogliarsi delle solite, trite, visioni nostalgiche.
La nostalgia è il vizio dei pigri: i pigri usano il passato per riverniciare gli ostacoli che non sono riusciti a superare e spacciarli per buone intenzioni.
Ci hanno fatto credere che servono nemici per mostrarsi uniti: che sia famiglia, religione, coalizione politica.
Qui a Palermo abbiamo una grande fortuna che sta proprio nelle nostre contraddizioni. Viviamo in una città in cui accadono cose complesse e semplici al tempo stesso, e non c’è da stupirsi di questa mistura logica in salsa agrodolce perché complessità e semplicità sono categorie soggettive della nostra visione sociale. L’una non esclude l’altra. Come altre categorie meno soggettive: la munnizza e la cultura, il traffico e la libertà di manifestare, lo straniero e il nativo. Siamo terreno fertile per far germogliare la preziosa pianta delle differenze.
Bambini e amore. Servono anime nuove e sentimenti antichi.
Per dipingere un nuovo mondo non basta requisire tutti i pennelli e pasticciare qualcosa sulla tavolozza davanti alla folla plaudente, sui balconi del potere. Servono piuttosto una sana allergia alla noia e la felicità intellettuale di chi sa che l’unica uguaglianza alberga nelle diversità. In tutte le diversità.
C’è un’espressione molto in voga in questo presente storto dove, ironia della sorte, ci riempiamo la bocca di parole inutili come “intelligenza artificiale” (una cosa che non è né intelligenza né artificiale).
L’espressione è “Veri Genitori”, degna scempiaggine di chi confonde la biologia con gli affetti, la scienza con il sentimento.
Non c’è peggior forma di controllo (governativo e non) di quella costruita sulle bugie.
I bambini sanno benissimo che i “Veri Genitori” sono una scemenza di alcuni adulti che vogliono mettere le mutande alla loro felicità, senza sapere che la felicità è nuda, che la felicità non tollera finzioni e travestimenti.
Esistono solo bambini che crescono nell’amore e bambini meno fortunati: il resto è grottesca ipocrisia.
Ecco perché alzare le spalle e fottersene dinanzi a un diritto negato agli altri e non a noi, dinanzi a un’ingiustizia che non sporca il nostro tinello è un peccato grave (in religione per chi ci crede, o in cuor nostro, per chi un cuore ce l’ha).
Se non siamo in grado di amare, perché purtroppo la borsa dei sentimenti non ha sempre i cordoni allentati, si può sempre provare a godere di riflesso dell’amore degli altri per gli altri. Vietarlo per decreto è una forma di violenza strisciante che non riscatta nessuno, ma fa solo ostaggi innocenti.
Vi siete mai chiesti da dove deriva la prosperità?
Io un’idea ce l’ho: la prosperità deriva dall’uguaglianza e dall’istruzione. Dalla libertà di guardarci allo specchio che ci spia dall’anta dell’armadio, di leggere i libri che non abbiamo scritto, di ascoltare frasi che non abbiamo pronunciato, di visitare luoghi che non abbiamo conosciuto e di esplorare emozioni che abbiamo fatto finta di conoscere, di guardare l’altro che fa cose che tu non sai fare, che dà baci che tu non hai dato, che accoglie chi hai lasciato fuori.
La libertà non è una preda.
Il virus, il braciere e l’amnesia
C’è una notizia oggi sulla quale mi sono fermato a riflettere. Mi sono fermato proprio, anche fisicamente. Quella notizia mi ha portato bruscamente alla distinzione tra speranza e ottimismo. Per la quale devo ricorrere a un fulminante ragionamento di Rebecca Solnit che, presentando la raccolta di saggi “Not too late” dedicata all’emergenza climatica, scrive:
“La speranza è diversa dall’ottimismo. L’ottimismo presuppone il meglio e la sua inevitabilità, il che porta alla passività, proprio come il pessimismo e il cinismo che presuppongono il peggio. Sperare, come amare, significa correre dei rischi ed essere vulnerabili agli effetti di una perdita. Significa riconoscere l’incertezza del futuro e impegnarsi a cercare di partecipare alla sua creazione. Significa affrontare le difficoltà e accettare l’incertezza. Sperare significa riconoscere che si può proteggere qualcosa di ciò che si ama anche se si soffre per ciò che non si può proteggere, e sapere che dobbiamo agire senza conoscere l’esito di queste azioni. Sperare significa accettare la disperazione come emozione ma non come analisi. Riconoscere che ciò che è improbabile è possibile, così come ciò che è probabile non è inevitabile. Capire che difficile non equivale a impossibile”.
La notizia che mi ha fermato ma che al contempo mi costretto a muovermi sulla scia di pensieri affollati, di recenti fatiche, di dolori inconsolabili, di piccole vittorie e di insopportabili sconfitte, è questa:
L’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la fine dell’emergenza Covid.
Ecco, ora rileggetevi le parole di Solnit e cercate di capire a quanta speranza e a quanto ottimismo ci siamo aggrappati in questi anni maledetti, anni che ci hanno cambiati per sempre.
Fatelo perché è da selvaggi buttarsi a volo d’angelo nel braciere dell’amnesia.
Long form
Le cose cambiano, lo sappiamo bene anche se ce lo diciamo raramente. Questo blog ha più di sedici anni (è più vicino ai diciassette) ed è una sorta di creatura che ho sempre cercato di trattare bene, anche perché grazie ai contenuti di queste pagine ho cambiato vita e/o lavoro almeno quattro volte.
Le cose cambiano, dicevo. Negli ultimi tempi, direi a partire dalla pandemia, ho notato che in molti lettori c’è l’esigenza di trovare qualcosa di più sostanzioso da leggere: come se non sempre la rapidità di un post potesse soddisfare la curiosità di chi ama il confronto, di chi coltiva il miracolo della curiosità. Analizzando i dati (ci sono vari strumenti per capire gradimento, distrazioni, insofferenze, eccetera) mi sono accorto che alcuni dei post più lunghi, quelli che richiedono un tempo di lettura superiore ai due minuti, sono quelli che restano tra i più graditi: restano, nel senso che c’è chi torna a leggerli, chi ci inciampa più volentieri.
Non l’avrei mai detto sino a quattro anni fa: la rapidità di esecuzione è uno dei pilastri della comunicazione via web, anche se nel blog c’è molto materiale che arriva dalla carta, dal teatro, dalla radio, dalla tv.
Per questo ho deciso di creare una sezione “long form” che troverete nelle “categorie” (qui a sinistra) nella quale sono raccolti questi contenuti di maggiore approfondimento, o semplicemente meno brevi.
Inoltre, presto, molti di questi post diverranno podcast in modo che li possiate ascoltare e non soltanto leggere: un vantaggio per chi ha poco tempo e per chi si annoia in auto, nel traffico o con un compagno di viaggio noioso…
Grazie a tutti e buona lettura.
Il mago dei soldi (in un podcast)
Nell’estate del 1990 a Palermo non c’è solo la febbre dei Mondiali di calcio allo stadio della Favorita con i gol dell’eroe di casa, Totò Schillaci. In quell’estate c’è un miracolo, il miracolo dell’affare della vita, quello che potrebbe cambiare tutto in un batter d’occhio. Gira voce che c’è un tale, un ragioniere dalle mani d’oro che moltiplica i soldi. Tipo che gli dai un milione, lui nel giro di poche settimane te ne da due. E non fa niente se quel ragioniere si fa chiamare avvocato anche se avvocato non è. L’importante è che il miracolo si compia.
Lui è Giovanni Sucato da Villabate. Ha 26 anni e si è inventato un futuro in un modo tanto miracoloso quanto improvvido. Raccoglie soldi e come ricevuta scrive due righe su pezzi di carta: sono e saranno sempre queste il suo unico documento ufficiale, la sua unica garanzia. Due righe e una firma. E il bello è che lui dopo paga davvero.
È così che diventa il mago dei soldi.

Rosso, sangue o vergogna?
C’è un problema che affrontiamo ogni giorno senza sapere di affrontare quel problema ogni giorno. E cioè: tutti abbiamo i cazzi nostri e tutti li abbiamo più o meno ogni giorno, solo che ci sono problemi che si esauriscono in quel giorno, problemi che si ripercuotono in più giorni, e problemi che rischiano di far venire giù le piastrelle di una stanza della nostra epoca. Uno dei più sottovalutati, e al contempo dei più perniciosi, è quello legato al codice comune. Che non è lingua né sistema criptato, ma sistema basilare di discussione, mattone per edificare un muro o sfondare una vetrina (sempre mattone è), unità di misura o arma da duello.
Ci sono due casi di cronaca da prendere come spunto. L’intervista di Elly Schlein su Vogue, che tutti citano e molto meno di tutti leggono, e il passaggio di Caterina Chinnici dal Pd a Forza Italia, che è facile da citare e inutile da leggere.
Il codice comune serve a decrittare in modo univoco un fatto, pur lasciando integre le sfumature che fanno la differenza nella sensazione di quel fatto. La sensazione è fondamentale nel nostro sistema di discernimento giacché toglie alla matematica il governo di ogni opinione.
Su Schlein gran parte della stampa italiana si è esercitata prendendo un brandello (diciamo il più insignificante) della sua intervista, quello sulla armocromia, e ignorando tutto il resto. Resto che è tanto, eh: da Obama alla Meloni, dalle famiglie arcobaleno ai movimenti ecologisti, dall’accoglienza per gli immigrati alle tasse per le multinazionali, dalle serie tv alla musica, dallo sciovinismo ai Radiohead, dalla pandemia all’outing, da Greta Thunberg al Festival di Locarno. Roba che Salvini manco in una vita…
Insomma leggetevela, questa benedetta intervista (vi ridò il link che magari vi siete distratti).
Su Chinnici al contrario si è teso a espandere un concetto piccolo piccolo: l’occasione di vetrina pubblica di una esponente politica atavicamente stitica di argomenti, una che in fondo ha sempre perso senza mai combattere realmente, un’onestissima professionista onestissimamente sopravvalutata. La sopravvalutazione è un peccato che non coinvolge il soggetto, quindi Chinnici è in tal senso incolpevole: voleva fare la solista, suona l’organetto in playback alla decima fila.
Il codice.
Se si fosse usato lo stesso codice per Schlein e Chinnici non ci sarebbe stato scandalo in un caso (Schlein) e meraviglia nell’altro (Chinnici). Perché il codice ci dà il conforto dell’uniformità col contesto: il cambiamento non è un petardo nella stanza da letto né una bestemmia in chiesa, ma capire perché un petardo è esploso nella stanza da letto e come si è arrivati a una bestemmia in chiesa. So che non è un concetto facile, ma so anche che voi siete più avanti di me in tal senso.
Quando nel 1998 la Nasa lanciò la sonda Mars Climate Orbiter per studiare la superficie di Marte nessuno poteva immaginare che, dopo quasi dieci mesi di viaggio nello spazio e mentre stava per entrare nell’orbita di Marte, quella costosissima ferraglia sarebbe esplosa.
Perché accadde questo incidente che – tanto per ricordarlo – costò 328 milioni di dollari di allora? Perché, si scoprì in seguito che – come si legge su Internazionale – il team che si occupava delle operazioni di navigazione del Jet Propulsion Laboratory aveva usato nei suoi calcoli il sistema metrico decimale, mentre la Lockheed Martin Astronautics, che aveva progettato e costruito la sonda, aveva fornito i suoi dati usando il sistema dei pollici, dei piedi e delle libbre.
Si erano scontrati due codici, capite?
E nessuno se ne accorse sino all’esplosione.
Oggi, abusando delle metafore che altri tempi ci elargiscono, sappiamo che usare gli stessi sistemi di misura, adottare linguaggi uniformi, o se preferite non cambiare le regole del gioco a partita in corso, è il migliore degli investimenti.
E fare il contrario – cioè fare come si continua a fare – è l’unico gioco in cui nessuno vince e tutti perdono.
Se tutti perdono i casi sono due: o il gioco è inutile, o inutili lo diventiamo tutti noi.