
A causa di ripetuti danni ai file del computer e quelli del mio cervello, sono stato costretto ad abbandonare il Pc per approdare al Mac. Da una quarantina di ore consecutive cerco di domare la mia compulsiva ricerca di un tasto destro del mouse e, al tempo stesso, di capire dove finiscono i documenti che produco. Mai mi sarei aspettato, alla mia età, di trovarmi a parlare nel cuore della notte con uno schermo di venti pollici. Non voglio tediarvi con mille altre manie che mi colgono anche adesso, mentre ticchetto su questa tastiera di magico (e anche un po’ irritante) design. Spero solo di riuscire a imbastire, entro fine estate, un rapporto di buona convivenza con il mio nuovo compagno di lavoro. Spero soprattutto di riuscire a pubblicare questo post.
Erba in tv
 Alcune brevi considerazioni sulla fiction dedicata alla strage di Erba, e mandata in onda ieri sera da Matrix. I legali dei due assassini (rei confessi) hanno cercato di impedire l’operazione: e si capisce, è come se Totò Riina dovesse essere contento di un film sulle stragi del ’92. Anche la famiglia Castagna si è detta contraria: anche questo si capisce, non fa bene vedere spalmato il proprio dolore sullo schermo. Persino il sindaco di Erba ha parlato di “informazione spazzatura” in forma preventiva, senza cioè aver visto un tubo dei filmati. Quelli che “per difendere il buon nome della città” devono imbracciare il mitra delle minchiate mi destano una certa irritazione. Più opportuno sarebbe stato guardare prima la fiction e poi ragionarci su per difendere la buona creanza innanzitutto.
Alcune brevi considerazioni sulla fiction dedicata alla strage di Erba, e mandata in onda ieri sera da Matrix. I legali dei due assassini (rei confessi) hanno cercato di impedire l’operazione: e si capisce, è come se Totò Riina dovesse essere contento di un film sulle stragi del ’92. Anche la famiglia Castagna si è detta contraria: anche questo si capisce, non fa bene vedere spalmato il proprio dolore sullo schermo. Persino il sindaco di Erba ha parlato di “informazione spazzatura” in forma preventiva, senza cioè aver visto un tubo dei filmati. Quelli che “per difendere il buon nome della città” devono imbracciare il mitra delle minchiate mi destano una certa irritazione. Più opportuno sarebbe stato guardare prima la fiction e poi ragionarci su per difendere la buona creanza innanzitutto.
Non mi ha impressionato la puntata, ho anticorpi Cogne-Vespa che mi corazzano. C’è altro che mi scandalizza in tv. Ricordo un famoso chirurgo che spostò l’intervento sui due gemelli siamesi in prima serata, per farsi accarezzare dalle luci della diretta: parlò prima, operò, parlò dopo, i bambini non ce la fecero, parlò ancora. Non credo che Mentana, ieri sera, volesse indagare le cause del male assoluto. Penso che, semplicemente, abbia voluto fare il giornalista televisivo, raccontando un fatto dal punto di vista migliore possibile. Mostrando, ricostruendo, commentando e fregandosene delle benedizioni/maledizioni.
Il Gay Pride è contro i gay
L’importante questione dei diritti degli omosessuali vive, in questi ultimi anni, di ampie ribalte. Il dibattito politico è fitto, gli spunti di cronaca non mancano.
C’è, in un’ampia fascia di moderati, la sensazione che questo genere di manifestazioni siano tristemente desuete. Un po’ come pretendere di rifare oggi i festival del pop coi nudisti, le canne e altro al vento. Per fortuna i tempi cambiano e ci si adegua anche con le proteste. Il che non significa fare incetta di sedativi: Pannella faceva lo sciopero della fame, poi si è cimentato anche in quello della sete; probabilmente dovrà inventarsi presto qualcos’altro, penso a uno sciopero dei bisogni fisiologici.
Il Gay Pride è vecchio, stantio. E si è trasformato in un triste rito, quello che cerca di lavare vecchie frustrazioni con l’acqua che non bagna. C’è una riflessione in atto, nel Paese, sulle coppie di fatto e su diritti stratosferici come quelli della genitorialità. Perché intorbidire le acque con le sfilate di bancari sadomaso, di segretarie dalla lingua prensile, di uomini travestiti da brutte donne e di donne che sembrano brutti ceffi? Amici gay, rifletteteci, queste manifestazioni fanno di voi caricature, pupazzi su carri allegorici di cui sghignazzare. Gli omosessuali che conosco, e di cui mi fido, non vivono per un giorno da checche liberate. Vivono, più semplicemente, per una vita in cui non li si guardi come diversi. Il Gay Pride rende ridicoli e irraggiungibili.
Giallo splendente
 Reduce da una conferenza sul romanzo giallo (insieme con Giacomo Cacciatore, Valentina Gebbia, Salvo Toscano, Ignazio Rasi e Raffaella Catalano), vi sottopongo le seguenti riflessioni.
Reduce da una conferenza sul romanzo giallo (insieme con Giacomo Cacciatore, Valentina Gebbia, Salvo Toscano, Ignazio Rasi e Raffaella Catalano), vi sottopongo le seguenti riflessioni.
1) La letteratura di genere è viva e vegeta nonostante i funerali anticipati di alcuni iettatori.
2) Il pubblico c’è e mostra interesse, nonostante le tentazioni omologatrici della tv dei format.
3) Molti librai sanno poco e nulla di ciò che vendono e si occupano più del registratore di cassa che di cosa hanno sugli scaffali.
4) Il “romanzo sociale” vive solo nelle intenzioni degli scopritori di nuovi mondi, agli scrittori normali basta il mondo che c’è.
5) Il giallo è un meccanismo universale per raccontare storie interessanti: che vi sia il morto o meno, non conta.
6) I lettori non sono fessi e se qualcuno tenta di prenderli per fessi si vendicano fregandosene se sei uno sconosciuto o un bestsellerista.
La bomba gay
 Becco negli archivi del Tgcom una notizia riempipista, come alcuni brani da discoteca. Una notizia, cioè, di immensa popolarità e di peso specifico prossimo allo zero. La dico d’un fiato tra una risata e l’altra: neglianniNovantailPentagonostudiòunabombagay. Non è una novità, se ne parlo già qualche anno addietro. Però adesso c’è la conferma del governo Usa.
Becco negli archivi del Tgcom una notizia riempipista, come alcuni brani da discoteca. Una notizia, cioè, di immensa popolarità e di peso specifico prossimo allo zero. La dico d’un fiato tra una risata e l’altra: neglianniNovantailPentagonostudiòunabombagay. Non è una novità, se ne parlo già qualche anno addietro. Però adesso c’è la conferma del governo Usa.
C’era un progetto per far diventare omosessuali i nemici in guerra, il tutto con una mistura chimica. Mi chiedo: era un gas da diffondere coi missili? Una pomata da spacciare come antiemorroidario? Una polvere da sciogliere negli acquedotti? Una fiala da iniettare grazie a fucili di precisione?
L’aspetto più grottesco, e meno divertente, della notizia sta nella strategia: grazie alla bomba gay i soldati della parte avversa sarebbero diventati meno aggressivi perché attratti dai commilitoni.
A parte l’inverosimiglianza dell’argomentazione. Con che criterio si può stabilire che un gay (anche se improvvisato) cede alle tentazioni sessuali e non fa il suo dovere di soldato? Se un milite al fronte si scopre omosessuale, chi può credere che appenda il fucile al chiodo per inseguire un pisello 24 ore su 24? Mi sembra che la logica di questa presunta strategia alberghi nel fetido pregiudizio secondo il quale il “diverso” è inferiore. Quindi, molti “diversi”, molti sconfitti.
Se fossi gay andrei da questi scienziati e gli farei un culo così.
L’Italia degli invisibili (al fisco)
 Da pagatore di tasse professionista quale sono mi desta indignazione la notizia dell’analisi fatta dall’Agenzia delle entrate sull’evasione fiscale in Italia. La cifra oltrepassa i 270 miliardi di euro all’anno e corrisponde a circa un quinto del Pil. Secondo un’elaborazione economica, a causa dei malfattori che nascondono il malloppo, il peso fiscale sugli onesti oltrepassa il cinquanta per cento. Perché devono pagare per quelli che non pagano. Obbediente alla logica da Bar dello Sport – quella a me più congeniale – non posso che provare ribrezzo per chi evade il fisco costringendomi a svenarmi per lui. Nella selva del si sa ma non si dice svettano le categorie dei liberi professionisti, degli imprenditori, dei commercianti ma anche dei falsi disoccupati, che gestiscono i propri affari con la stessa disinvoltura di un rapinatore di banche. Il concetto che dovrebbe passare al di sopra di ogni schieramento è infatti questo: chi evade ruba. Un altro concetto basilare mi sembra il seguente: chi evade non è necessariamente una persona importante. Grazie a una certa classe politica ci siamo infatti assuefatti all’idea che l’identikit del perfetto evasore sia quello di una persona di ceto alto, di buon talento (anche criminale), con un discreto numero di impiegati sottopagati, un paio di conti in Svizzera e almeno una villa in un’isola dei Caraibi. In realtà il sottobosco della truffa, almeno nella realtà che mi circonda, comprende lavoratori stagionali, disoccupati ufficiali, gente che non vuole un lavoro in regola, occupanti abusivi di case non proprie, tuttofare da strada. La miseria, quella vera, si annida nelle famiglie degli impiegati: due figli e una moglie da sfamare, muto o affitto, bollette, uno stipendio da poche centinaia di euro al mese. Senza parlare dei pensionati.
Da pagatore di tasse professionista quale sono mi desta indignazione la notizia dell’analisi fatta dall’Agenzia delle entrate sull’evasione fiscale in Italia. La cifra oltrepassa i 270 miliardi di euro all’anno e corrisponde a circa un quinto del Pil. Secondo un’elaborazione economica, a causa dei malfattori che nascondono il malloppo, il peso fiscale sugli onesti oltrepassa il cinquanta per cento. Perché devono pagare per quelli che non pagano. Obbediente alla logica da Bar dello Sport – quella a me più congeniale – non posso che provare ribrezzo per chi evade il fisco costringendomi a svenarmi per lui. Nella selva del si sa ma non si dice svettano le categorie dei liberi professionisti, degli imprenditori, dei commercianti ma anche dei falsi disoccupati, che gestiscono i propri affari con la stessa disinvoltura di un rapinatore di banche. Il concetto che dovrebbe passare al di sopra di ogni schieramento è infatti questo: chi evade ruba. Un altro concetto basilare mi sembra il seguente: chi evade non è necessariamente una persona importante. Grazie a una certa classe politica ci siamo infatti assuefatti all’idea che l’identikit del perfetto evasore sia quello di una persona di ceto alto, di buon talento (anche criminale), con un discreto numero di impiegati sottopagati, un paio di conti in Svizzera e almeno una villa in un’isola dei Caraibi. In realtà il sottobosco della truffa, almeno nella realtà che mi circonda, comprende lavoratori stagionali, disoccupati ufficiali, gente che non vuole un lavoro in regola, occupanti abusivi di case non proprie, tuttofare da strada. La miseria, quella vera, si annida nelle famiglie degli impiegati: due figli e una moglie da sfamare, muto o affitto, bollette, uno stipendio da poche centinaia di euro al mese. Senza parlare dei pensionati.
La nostra lingua
 Tornando a casa, ascoltavo la radio. Tra una canzone e l’altra (canzone mi sembra una parola desueta, che ne dite?) un jingle improvvisamente mi ha fatto capire che viviamo in uno strano paese. Parliamo una lingua nazionale, ma in pubblicità ci piace sentirla storpiata o, addirittura, sentirla tradotta in qualcosa di incomprensibile. Conosco l’inglese scolastico quindi sono in grado di argomentare, almeno per trenta righe. C’è un’emittente che seguo e che ha come proclama “One nation one station” (una nazione una stazione radiofonica). Ora, se uno vuole rimandare meritevolmente al concetto di unità nazionale perché utilizza una lingua che appartiene a un’altra nazione? E’ come dire che marito e moglie devono giurarsi fedeltà mentre si ammicca al terzo incomodo. Ci sono, da decenni, pubblicità di prodotti italiani che si basano esclusivamente su slogan stranieri: profumi francesi di cui si percepiscono solo le erre mosce, capi d’abbigliamento con sigle sincopate che fanno venire il singhiozzo al solo pronunciarle, auto dai dittonghi impossibili.
Tornando a casa, ascoltavo la radio. Tra una canzone e l’altra (canzone mi sembra una parola desueta, che ne dite?) un jingle improvvisamente mi ha fatto capire che viviamo in uno strano paese. Parliamo una lingua nazionale, ma in pubblicità ci piace sentirla storpiata o, addirittura, sentirla tradotta in qualcosa di incomprensibile. Conosco l’inglese scolastico quindi sono in grado di argomentare, almeno per trenta righe. C’è un’emittente che seguo e che ha come proclama “One nation one station” (una nazione una stazione radiofonica). Ora, se uno vuole rimandare meritevolmente al concetto di unità nazionale perché utilizza una lingua che appartiene a un’altra nazione? E’ come dire che marito e moglie devono giurarsi fedeltà mentre si ammicca al terzo incomodo. Ci sono, da decenni, pubblicità di prodotti italiani che si basano esclusivamente su slogan stranieri: profumi francesi di cui si percepiscono solo le erre mosce, capi d’abbigliamento con sigle sincopate che fanno venire il singhiozzo al solo pronunciarle, auto dai dittonghi impossibili.
Tutto questo ci piace. L’esotismo dell’ignoto (o dell’ignoranza) esercita un’attrazione che per noi italiani rasenta – a mio parere – la patologia. Se andate in Francia trovate tradotto persino un termine universale come computer. Se vi trovate in Spagna vi imbattete in un intransigente filtro verso ciò che non è immediatamente comprensibile dal cittadino medio. Se in Inghilterra sbagliate un accento ve lo fanno notare.
Siamo cresciuti con personaggi che hanno fatto fortuna nel nostro Paese senza mai imparare l’italiano. Due esempi due: Josè Altafini fa ancora un programma in una radio privata e ostenta il suo italiano maccheronico con grande successo. Il compianto Don Lurio se n’è andato senza imparare la consecutio temporum.
Fin quando le radio verranno pubblicizzate come rredio e le televisioni come televiscion non potremo scandalizzarci se il primo analfabeta s’inventa un vocabolario della Padania liberata.
Una pernacchia per Selva
 Non sono riuscito a vedere per intero lo spezzone dello Speciale de La7 in cui il senatore di An Gustavo Selva ammette con candore di aver finto un malore e approfittato di un’autoambulanza per dribblare il traffico di Roma pur di arrivare in tempo per una trasmissione televisiva. L’imbarazzo per un uomo di 81 anni, che millanta di aver usato un trucco “da vecchio cronista”, è stato tale che mi è bastato leggere le cronache delle sue annunciate dimissioni per provare vergogna – in un solo colpo – al posto suo, della sua famiglia, dei suoi elettori, del suo partito, dell’ordine dei giornalisti, del Senato della Repubblica, della città di Roma e delle persone civili tutte.
Non sono riuscito a vedere per intero lo spezzone dello Speciale de La7 in cui il senatore di An Gustavo Selva ammette con candore di aver finto un malore e approfittato di un’autoambulanza per dribblare il traffico di Roma pur di arrivare in tempo per una trasmissione televisiva. L’imbarazzo per un uomo di 81 anni, che millanta di aver usato un trucco “da vecchio cronista”, è stato tale che mi è bastato leggere le cronache delle sue annunciate dimissioni per provare vergogna – in un solo colpo – al posto suo, della sua famiglia, dei suoi elettori, del suo partito, dell’ordine dei giornalisti, del Senato della Repubblica, della città di Roma e delle persone civili tutte.
C’è poco da dire quando la tracotanza si miscela con l’incoscienza, se resta fiato è solo per una solenne pernacchia. E a poco vale l’interrogazione annunciata dallo stesso Selva in cui si chiede per giunta conto di un ritardo del presunto soccorso. La pernacchia per un finto navigato come lui è l’unico linguaggio universale per fargli sapere quanto è sgradevole la sua presenza tra i rappresentanti di quello che una volta si chiamava popolo. Un esperanto riabilitato per un politico da non riabilitare.
Palermo e basta
Giacomo Cacciatore è uno scrittore testardo. Si ostina – lui che è di origini calabresi – ad ambientare le sue storie in una Palermo scomoda e per nulla folkloristica. Il suo ultimo romanzo, Figlio di Vetro (Einaudi), parla di mafia scavalcando moralismi e lezioncine di etica. Cacciatore è anche un polemista tanto impetuoso quanto riservato. Io, che sono suo amico, ne raccolgo quotidianamente gli stimoli e gli sfoghi ricambiando come posso. Oggi ho ottenuto il permesso di pubblicare una sua riflessione, a mio giudizio preziosa.
ti confesso che la Palermo che leggo su alcuni siti web e giornali non mi piace. Giriamola come vogliamo, ma ’sto giovanilismo nostrale del tipo “cucì, compa’” (quando non entra in ballo di peggio, cioè il mastro della broscia o il poeta della panella) non mi diverte né mi induce alla riflessione. Secondo me questi trasudano da ogni riga quell’autocompiacimento (nel parlare bene così come nel parlare male di Palermo) che mi sembra mooolto provinciale. Mi pare di vedere i cumpari che si girano i pollici e fanno piriti ai tavolini del bar della piazza, impantanati nei classici discorsi di cafè su quanto facciamo schifo e però… “ce la possono sucare”. E allora mi chiedo: ma questa cazzo di città non si può abitare e basta? Perché bisogna sempre farne un soggetto-oggetto filosofico da quattro copechi, il tema portante di un sito con centinaia di post, il perno di intere bibliografie, come se non esistesse altro al di là di Villabate e di Capo Gallo? Non si può essere abitanti di Palermo senza per forza essere “palermitanazzi” e “palermitanare”? E poi, questa presunta “distintività” dei palermitani, che ci sboccia irrefrenabile a ogni pie’ sospinto, come l’herpes da stress, è davvero una cosa così provata e significativa agli occhi del mondo da andarne fieri, farne argomento di conversazione o lamentarsene di continuo? Anche i newyorkesi, dico io, sproloquieranno ogni tanto su cosa significa essere newyorkesi. Ma la maggior parte del tempo la passano a lavorare sodo, diventare pittori, scrittori, registi, tassisti, drag queen, elaboratori di sistemi informatici che cambiano il mondo e l’assetto dell’economia internazionale, suicidi o, male che vada, serial killer. Se Palermo fosse una vera metropoli, nel senso di “città madre” di idee, che contagia innovazioni originali e memorabili al resto del globo, allora capirei tutto questo annacamento. Capirei la voglia o la necessità di spiegare e spiegarsi “che cosa è Palermo in tutte le sue strabilianti sfaccettature”. Ma lo vogliamo capire che non ci caca nessuno? Che questa è sempre stata una città in cui la gente che conta viene, mangia, defeca, si asciuga il culo, prende la nave e l’aereo e manco tira l’acqua? Che l’unica cosa che riusciamo a produrre ed esportare sono le scatolette di caponata e quattro bottiglie di vino? Che le persone che hanno avuto e hanno ancora qualcosa da dire e di cui far parlare, qui, si contano sulla punta delle dita? Che questo guardarsi di continuo l’ombelico e lo ziniero è la tomba delle potenzialità, dei talenti, della necessaria umiltà per crescere e produrre come si deve?
Lo stesso si potrà dire dei napoletani, per carità. Ma l’essere apparentati (fin dai tempi del regno delle due Sicilie, probabilmente) nella mentalità del “povero e superbo”, non mi sembra una gran consolazione. Non lo era prima, non lo è adesso.
Con universale amicizia,
M come macroeconomia… e mortadella
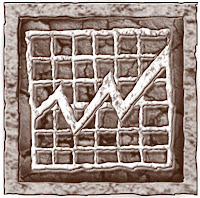 Quel divertentissimo istituto della fantascienza che è l’Istat ci comunica che il Pil italiano è cresciuto nel primo trimestre 2007 dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia c’è l’avvertenza che sono state riviste “al rialzo le stime preliminari di una crescita dello 0,2%… rispetto al quarto trimestre 2006 si tratta comunque di un brusco rallentamento, visto che negli ultimi tre mesi dell’anno il Pil era cresciuto dell’1,1%… a livello tendenziale l’Istat ha invece confermato una crescita del 2,3%”.
Quel divertentissimo istituto della fantascienza che è l’Istat ci comunica che il Pil italiano è cresciuto nel primo trimestre 2007 dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia c’è l’avvertenza che sono state riviste “al rialzo le stime preliminari di una crescita dello 0,2%… rispetto al quarto trimestre 2006 si tratta comunque di un brusco rallentamento, visto che negli ultimi tre mesi dell’anno il Pil era cresciuto dell’1,1%… a livello tendenziale l’Istat ha invece confermato una crescita del 2,3%”.
Se avete avuto la pazienza di leggere fin qui, tirate un sospiro di sollievo: il peggio è passato. Sappiamo, o dovremmo sapere, che il Pil è la misura della ricchezza prodotta in un Paese. Cioè una cosa concreta, come l’ora che guardiamo sul nostro orologio o la taglia sull’etichetta della camicia che indossiamo. Una misura, praticamente un numero reale che esprime il valore del rapporto tra una grandezza e un’altra.
Il trappolone scatta quando l’orticello in cui ci addentriamo è quello della cosiddetta macroeconomia, cioè un sistema che si occupa per definizione di variabili, di effetti complessivi. Solo quando facciamo i primi passi ci accorgiamo di essere finiti in un deserto immenso e pericoloso, altro che orticello!
Se il Pil cresce, siamo più ricchi. Ma variabilmente e complessivamente. Se il Pil cresce, ma tradisce il livello tendenziale, vuol dire che saremo meno ricchi di quanto la fantascienza aveva previsto. Non è infrequente poi che l’Istat (che, ricordiamolo, sta per Istituto Studi Teorici Applicati al Tutto) si azzuffi col governo quando gli capita di prevedere un futuro che al premier di turno non piace. Questo complica le cose perché capire se un etto di mortadella nel 2010 ci costerà 500 euro non è più una questione di fantasia, ma anche di politica. La tentazione del qualunquismo è reale come l’ostinazione della massaia: abolire gli enti di previsione e fondare osservatori sulla politica dei prezzi, sulle tasse, sui beni. Sarebbe più semplice emanare un bollettino semestrale che dice: stando così le cose abbiamo tanto in cassa, i creditori che hanno pagato sono questi, i malfattori sono i seguenti. E lasciare il “livello tendenziale” e le “stime preliminari” agli eredi di Giulio Verne.

