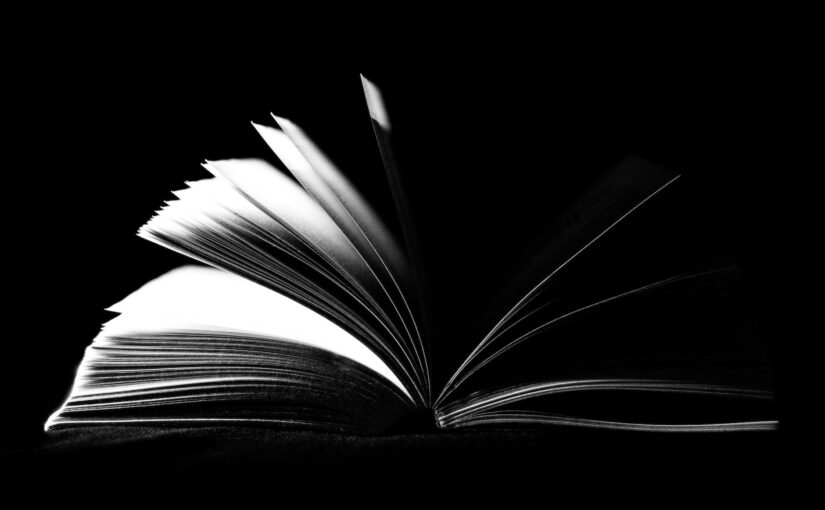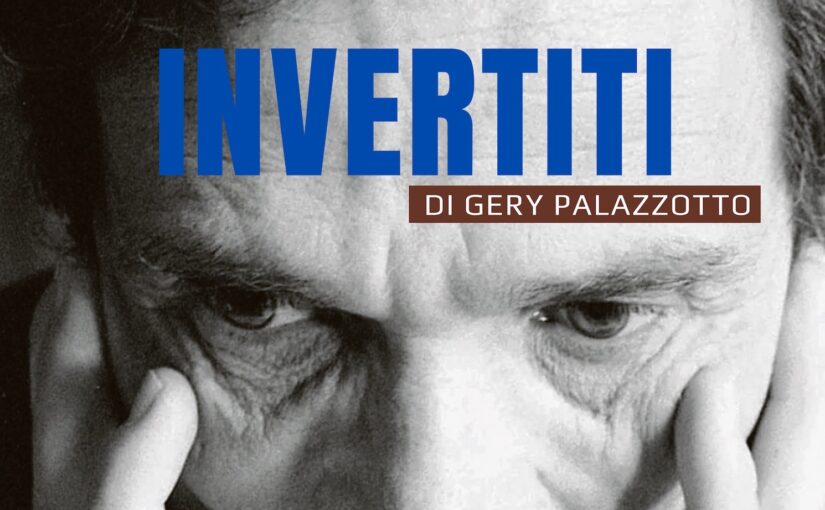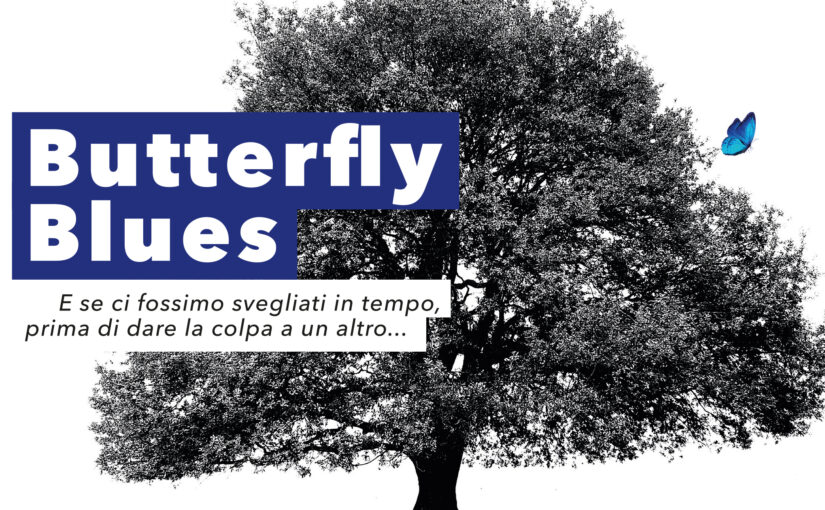Il carnevale l’ho sempre odiato, a parte una volta in cui organizzai una mega festa in maschera a Palermo (in realtà non la organizzai, feci l’istrione in cambio di una quota dei profitti) e guadagnai un mazzo di soldi col quale mi comprai una moto. Per il resto, delle carnevalate con annesse maschere e finzioni ricordo un orribile costume che mi venne imposto da bambino: frac, cappello alto (ancora oggi non so come si chiama), pantaloni a tubo e bastone. Io pensavo di essere travestito da vecchio e invece appresi con orrore che il mio era un costume da lord inglese. Non lo dimenticherò mai: lord inglese. Che minchia voleva dire lord inglese?
I miei amici avevano Zorro, Superman, Strega (c’era una strega di dieci anni che mi toglieva il sonno), cowboy. Mio fratello era vestito da indiano: col copricapo di piume (ancora oggi non so come si chiama), un paio di stracci colorati addosso, quattro strisce in faccia e faceva la sua figura.
Io ero lord inglese. Che nella mente di un bambino significa una persona poco pulita che sta oltremanica (oltremanica è un concetto che ho metabolizzato molto dopo, ma ora serve per sdrammatizzare).
Tutti gli zombie, gli sceriffi, le principesse, le fate (c’erano fatine truccate che ancora oggi ricordo con imbarazzante turbamento) mi chiedevano “da cosa sei vestito”? E nell’attesa disperata di trovare una risposta – i vestiti di carnevale duravano anni, mica si smaltivano in tempi ragionevoli – mi inventai una risposta che era anche una soluzione. Riuscii a farmi regalare un bastone diverso da quello da vecchio che mi era stato assegnato: era un bastone che svelava un’anima da spada, ovviamente finta, di plastica.
Quindi aggiornai la narrazione: chi poteva portarsi appresso un arnese del genere? Non certo un fantomatico lord inglese, ma…
… un agente segreto!
Fu così che trasformai un handicap in un’occasione.
Ero travestito da agente segreto!
Un vestito insulso – devo avere qualche foto se non si è autodistrutta – per miracolo diventò un travestimento del travestimento.
Ero uno 007 con licenza di sopravvivere in mezzo a costumi più divertenti, finzioni vere.
Solo molto tempo dopo avrei imparato che i carnevali passano, ma certe maschere restano.