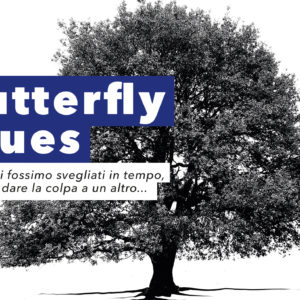Il gigante dorme in una penombra e in un silenzio irreali. Stamattina sono rientrato in teatro dopo interminabili settimane di lontananza forzata, un po’ come gli amanti di Battisti, quelli di “cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu”. Ma la mia, anzi la nostra, non è una storia d’amore finita, bensì un doloroso distacco imposto da un nemico invisibile. Quindi è sofferenza cruda, senza manco la consolazione del tempo o della sfida a singolar tenzone.
Immagino il disagio, quasi una crisi di astinenza, degli artisti che vivono sul e per il palcoscenico. Io, che artista non sono, quando mi sono ritrovato al cospetto del gigante addormentato ero tentato di gridare, applaudire da solo al centro della Sala Grande: volevo essere tutti gli occhi e tutte le mani del mondo per restituire ammirazione e applausi a quel luogo di gioia imbavagliata. Perché un teatro chiuso è rapina di tempo e bellezza, è un pizzo pagato all’odio del mondo che è fatto non solo di miserie umane ma anche di orribili e per nulla ammalianti vendette della natura.
Ci sono cose che ci mancano a tradimento, come certi amori che diventano solidi quando evaporano. A me è capitato con stanze secondarie del teatro, luoghi seminascosti dove scorre una vita anonima ma non meno importante delle altre: locali tecnici, la impervia regia televisiva, una sala prove caldissima d’estate e fredda d’inverno. E poi i corridoi, i palchi di proscenio, quelli dai quali uno spettacolo gli addetti ai lavori lo assorbono, godendoselo come una cosa propria: il fruscio delle vesti di un cantante, il soffio delle pagine di uno spartito, il respiro di un danzatore. Noi non-artisti di un teatro siamo morti mille volte in gloria sul palcoscenico, abbiamo suonato mille strumenti da solisti, siamo risorti tra gli applausi, abbiamo ucciso felicemente, abbiamo dichiarato guerre e siglato paci familiari con lo stesso effetto scenico, abbiamo saltato e piroettato leggiadri nelle nostre panze, abbiamo concesso bis tra i sorrisi e abbandonato le assi tra le lacrime. Noi non-artisti siamo il riverbero del soffio vitale di un teatro. Siamo Gianni Rivera e Marco Tardelli ai Mondiali. Siamo l’ingranaggio che sogna da motore. E che gode nel sentire un rombo che, per una piccola parte, è anche suo.
A tutto questo pensavo stamattina quando tutto era fermo, terribilmente fermo, intorno a me. Se volete sentire il vero rumore del silenzio, per mia esperienza, ci sono solo due luoghi in cui perdersi con cautela: le viscere di una montagna e l’interno di un teatro chiuso.
Dovremo ricominciare da qui, per raccontare questi tempi di prigionia democratica, di privazioni feconde, di assenza forte e presente. Dal non sentirci traditi dalle cose che si allontanano da noi, perché non è vero che l’anima ce l’abbiamo solo noi. L’anima è nel silenzio e nel buio di luoghi fatti per scacciare i mostri del silenzio e del buio. L’anima è nell’aria che attraversa gli spazi che ci dividono e che ci eravamo dimenticati di accorciare, quando tutto era più facile.
Il gigante si sveglierà. È sempre stato così, non sono bastate guerre e mafia, sciatteria e malamministrazione a spegnerlo. Solo che stavolta il risveglio sarà più lento e ci vorrà più cura per lasciarci accogliere tra le sue braccia.