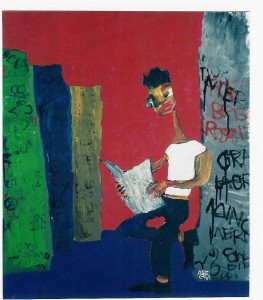Appunti di Natale e scusate il ritardo (per riprendermi c’è voluto tempo).
Si chiama Domenico Torta. Ha 79 anni, occhi piccoli e appuntiti, baffi neri, capelli lunghi e codino. E’ mio padre, ma non gli assomiglio per niente. Prendete una tunica nera, mettetegliela e avrete un inquisitore, di quelli che mandavano le streghe al rogo.
Come ogni Natale sono qui a casa sua, seduto davanti a lui, per il solito pranzo a cui non rinuncerei per niente al mondo perché ogni anno, da quando ne ho compiuti 15, aggiunge una riga al suo testamento. Il mio è vero affetto. Finita la parte dove mi ha lasciato la casa, siamo arrivati alla riga dove sta indicando me – e solo me – unico figlio devoto, erede della villetta di Pantelleria. L’anno scorso la riga si è interrotta a “Pant… “.
Io non potrei fare più a meno di questa festa – specchio, in cui guardo gli altri e mi guardo. Guardo soprattutto la badante rumena di mio padre, 30 anni, che ha il sedere più maestoso d’Europa, isole comprese. Si chiama Julia. L’ho già castigata: l’anno scorso, sempre a Natale. Ora è incinta, e il fatto che porti in grembo un figlio non mio è la dimostrazione che Dio esiste e merita tutto il mio rispetto.
Siamo seduti a tavola. C’è anche quella simpaticona della mia ex moglie che ha fatto qualcosa al labbro superiore. Non ha più le sue micro rughe, testimonianza imperitura della sua maestria nel chiudere e aprire la bocca: e non solo per parlare.
Regali. A me arrivano quelli più brutti. Mentre io li faccio sempre “pensati”. Dalla mia segretaria – che mi conosce benissimo – alla quale do mille euro, una lista di nomi che si riduce sempre di più. E lei compra. Cose tipo questo massaggiatore da piedi per mio padre, che per un pelo non vomita solo guardandolo, e una trousse per la mia ex consorte che mi sta dando un pacchettino. Lo apro e che meraviglia! Un pezzo di sapone alla cannella. La bacio sulla guancia e lei mi sussurra “stronzo”. Poi do il regalo a mia figlia, una sciarpa viola. Non la scarta neanche e manda sms. Ma lei è mia figlia e so che mi vuole bene.
Ci siamo. Abbiamo mangiato il pandoro e mio padre estrae il testamento. “La villetta di Pantelleria la lascio a Julia e a suo figlio che poi è mio figlio. Nascerà tra 4 mesi. Se dovessi morire prima, per favore, non chiamatelo Roberto”.
Infatti si chiamerà Natale.