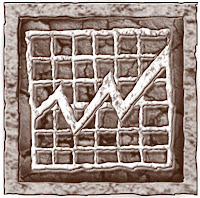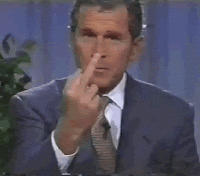Giacomo Cacciatore è uno scrittore testardo. Si ostina – lui che è di origini calabresi – ad ambientare le sue storie in una Palermo scomoda e per nulla folkloristica. Il suo ultimo romanzo, Figlio di Vetro (Einaudi), parla di mafia scavalcando moralismi e lezioncine di etica. Cacciatore è anche un polemista tanto impetuoso quanto riservato. Io, che sono suo amico, ne raccolgo quotidianamente gli stimoli e gli sfoghi ricambiando come posso. Oggi ho ottenuto il permesso di pubblicare una sua riflessione, a mio giudizio preziosa.
ti confesso che la Palermo che leggo su alcuni siti web e giornali non mi piace. Giriamola come vogliamo, ma ’sto giovanilismo nostrale del tipo “cucì, compa’” (quando non entra in ballo di peggio, cioè il mastro della broscia o il poeta della panella) non mi diverte né mi induce alla riflessione. Secondo me questi trasudano da ogni riga quell’autocompiacimento (nel parlare bene così come nel parlare male di Palermo) che mi sembra mooolto provinciale. Mi pare di vedere i cumpari che si girano i pollici e fanno piriti ai tavolini del bar della piazza, impantanati nei classici discorsi di cafè su quanto facciamo schifo e però… “ce la possono sucare”. E allora mi chiedo: ma questa cazzo di città non si può abitare e basta? Perché bisogna sempre farne un soggetto-oggetto filosofico da quattro copechi, il tema portante di un sito con centinaia di post, il perno di intere bibliografie, come se non esistesse altro al di là di Villabate e di Capo Gallo? Non si può essere abitanti di Palermo senza per forza essere “palermitanazzi” e “palermitanare”? E poi, questa presunta “distintività” dei palermitani, che ci sboccia irrefrenabile a ogni pie’ sospinto, come l’herpes da stress, è davvero una cosa così provata e significativa agli occhi del mondo da andarne fieri, farne argomento di conversazione o lamentarsene di continuo? Anche i newyorkesi, dico io, sproloquieranno ogni tanto su cosa significa essere newyorkesi. Ma la maggior parte del tempo la passano a lavorare sodo, diventare pittori, scrittori, registi, tassisti, drag queen, elaboratori di sistemi informatici che cambiano il mondo e l’assetto dell’economia internazionale, suicidi o, male che vada, serial killer. Se Palermo fosse una vera metropoli, nel senso di “città madre” di idee, che contagia innovazioni originali e memorabili al resto del globo, allora capirei tutto questo annacamento. Capirei la voglia o la necessità di spiegare e spiegarsi “che cosa è Palermo in tutte le sue strabilianti sfaccettature”. Ma lo vogliamo capire che non ci caca nessuno? Che questa è sempre stata una città in cui la gente che conta viene, mangia, defeca, si asciuga il culo, prende la nave e l’aereo e manco tira l’acqua? Che l’unica cosa che riusciamo a produrre ed esportare sono le scatolette di caponata e quattro bottiglie di vino? Che le persone che hanno avuto e hanno ancora qualcosa da dire e di cui far parlare, qui, si contano sulla punta delle dita? Che questo guardarsi di continuo l’ombelico e lo ziniero è la tomba delle potenzialità, dei talenti, della necessaria umiltà per crescere e produrre come si deve?
Lo stesso si potrà dire dei napoletani, per carità. Ma l’essere apparentati (fin dai tempi del regno delle due Sicilie, probabilmente) nella mentalità del “povero e superbo”, non mi sembra una gran consolazione. Non lo era prima, non lo è adesso.
Con universale amicizia,