 C’era uno splendido editoriale ieri sul Corriere della sera, firmato da Claudio Magris (se ve lo siete persi, lo trovate qui). Il tema è quello del ruolo degli scrittori, del valore della letteratura nel destino degli uomini. Da più parti e in varie epoche si è invocata, temuta o combattuta una politicizzazione dell’arte. Da anni, specie nei dibattiti sul cosiddetto romanzo sociale, si chiedono ai narratori strumenti e modi per risolvere i misteri del nostro tempo. Spesso gli si imputa di frequentare un’ideologia piuttosto che un’altra. Ancor più spesso di non sposarne una. Una variante più perniciosa di polemisti addirittura si spinge ad accusare una classe (intesa in senso anagrafico) di scrittori di tradire le proprie origini geografiche e culturali, di debordare rispetto all’orticello nel quale sono nati e cresciuti. E via criticando.
C’era uno splendido editoriale ieri sul Corriere della sera, firmato da Claudio Magris (se ve lo siete persi, lo trovate qui). Il tema è quello del ruolo degli scrittori, del valore della letteratura nel destino degli uomini. Da più parti e in varie epoche si è invocata, temuta o combattuta una politicizzazione dell’arte. Da anni, specie nei dibattiti sul cosiddetto romanzo sociale, si chiedono ai narratori strumenti e modi per risolvere i misteri del nostro tempo. Spesso gli si imputa di frequentare un’ideologia piuttosto che un’altra. Ancor più spesso di non sposarne una. Una variante più perniciosa di polemisti addirittura si spinge ad accusare una classe (intesa in senso anagrafico) di scrittori di tradire le proprie origini geografiche e culturali, di debordare rispetto all’orticello nel quale sono nati e cresciuti. E via criticando.
La statura intellettuale di Claudio Magris è tale da togliermi ogni possibilità di manovra nell’adoperarmi per dargli ragione, applaudire e sorridere quasi commosso. Perché chi vive di scrittura sa quanto sia difficile la scelta di questo non mestiere che riempie e svuota al tempo stesso. Lo scrittore non è una persona giudiziosa che pianifica, risparmia, investe. No, è un dannato nato per la sua dannazione che non sa fare altro, e se lo sa fare non gliene frega niente. Vive per le sue storie, che risultino belle o no, che siano pubblicate o cestinate. Si sveglia nel cuore della notte con un’idea in testa e corre ad appuntarsela prima che svanisca a causa della piena coscienza. E’ talmente abituato ai fallimenti che quando inanella qualche successo si chiede dove stia il trucco. Presuntuoso per quanto sia, si sente nudo davanti ai suoi personaggi, che sono la vera incarnazione del suo paradosso: un creatore condizionato dalle vite riflesse che lui stesso ha generato.
Gli scrittori, famosi e sconosciuti, conclamati e in pectore, hanno il compito di inventare un mondo sempre nuovo, pagina dopo pagina. Molti lo fanno gratis, altri lo farebbero gratis. Se non sognano nuove storie, sognano che qualcuno li legga. Invecchiano così, e non chiedetegli altro.
Autore: Gery Palazzotto
Cose strane
Una roba domenicale. Rilassiamoci un po’.
Il Papa e lo Stato
 Facendo leva su un argomento non da poco, la “salvaguardia del creato”, il Papa scende (torna) in campo contro le minacce alla «vita umana» e alla «famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna». E precisa di non parlare in difesa solo dei principi cattolici, ma della gamma completa dei valori umani.
Facendo leva su un argomento non da poco, la “salvaguardia del creato”, il Papa scende (torna) in campo contro le minacce alla «vita umana» e alla «famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna». E precisa di non parlare in difesa solo dei principi cattolici, ma della gamma completa dei valori umani.
La Cassazione ha quindi qualcosa di disumano quando decide di riaprire il caso di Eluana.
Le coppie che convivono fuori dal matrimonio sono da mettere al rogo.
I gay… non ne parliamo.
Un Papa che vuole farsi Stato, laddove nemmeno lo Stato è Stato fino all’estremo, potrebbe scegliere una via più consona e dire: in questo mondo ci sono molte cose che non vanno, la mia soluzione è questa. Invece dice: in questo mondo ci sono molte cose che non vanno perché non fate come dico io.
Se persino dinanzi a un problema complesso come il precariato il Pontefice sembra pronto alle scomuniche, sarebbe utile che prima di scagliare il primo fulmine ci dicesse come migliorare la Finanziaria.
E l’Ici? Ah, di quello è meglio parlare in confessionale.
La briscola del Nobel
 I premi non sono tutto. I pubblici riconoscimenti non sono un certificato di garanzia. Il fatto che uno abbia vinto il Nobel non esclude che possa sparare delle cazzate atomiche. Se il professore Watson, lo scopritore della struttura del Dna, pensa che i neri siano meno intelligenti dei bianchi non bisogna scandalizzarsi troppo: il signore in questione è anziano, ne ha già sputate altre su omosessuali e libido razziale.
I premi non sono tutto. I pubblici riconoscimenti non sono un certificato di garanzia. Il fatto che uno abbia vinto il Nobel non esclude che possa sparare delle cazzate atomiche. Se il professore Watson, lo scopritore della struttura del Dna, pensa che i neri siano meno intelligenti dei bianchi non bisogna scandalizzarsi troppo: il signore in questione è anziano, ne ha già sputate altre su omosessuali e libido razziale.
Ha fatto la sua bella scoperta, Mr Watson, negli anni Sessanta. E forse ha pure avuto un certo culo. Ora si goda la pensione. Qualcuno lo tenga lontano da microfoni e telecamere. A una certa età, meglio imparare a giocare a briscola.
Carcere durissimo
 Il 41 bis come una tortura? Un giudice di Los Angeles ha negato all’Italia l’estradizione di un membro della cosca dei Gambino, sostenendo che il regime di detenzione previsto dall’articolo 41 bis della legge sull’ordinamento penitenziario al quale il mafioso sarebbe destinato equivale a una forma di tortura e viola la convenzione dell’Onu.
Il 41 bis come una tortura? Un giudice di Los Angeles ha negato all’Italia l’estradizione di un membro della cosca dei Gambino, sostenendo che il regime di detenzione previsto dall’articolo 41 bis della legge sull’ordinamento penitenziario al quale il mafioso sarebbe destinato equivale a una forma di tortura e viola la convenzione dell’Onu.
L’interpretazione non è nuova, già da tempo in Italia una corrente giuridica guarda storto il cosiddetto “carcere duro”. Certo, non si può ribattere a queste critiche negando l’essenza del problema: il 41 bis è un provvedimento estremo al quale si è dovuti ricorrere per fronteggiare una situazione estrema. In quale altro paese moderno i carcerati potevano avere contatti disinvolti con l’esterno, al punto di impartire ordini sui traffici del clan o di commissionare omicidi? In quale altra nazione all’avanguardia era consentito ai detenuti di poter importare stili e vizi di vita libera dietro le sbarre?
La struttura mentale di un mafioso conclamato – cioè nato, cresciuto, invecchiato nel fango di Cosa Nostra – non è facilmente scalfibile. Il carcere come luogo di redenzione e di recupero va bene per chi non ha simili incrostazioni direi quasi congenite. Prendete uno come Provenzano: capo della più grande organizzazione criminale del mondo, sanguinario dalla faccia di mite contadino, imprendibile per 40 anni pur rimanendo a un tiro di schioppo da Palermo… Uno che ha già conosciuto il 41 bis quand’era libero, vivendo in un fetido casolare, con minimi collegamenti con l’esterno. Come si fa a sterilizzare la sua capacità di comunicazione monosillabica ora che è in cella? Come si può impedire a un criminale sanguinario come Totò Riina di esercitare il suo potere sugli altri detenuti (che sono a loro volta cinghie di trasmissione di ordini)?
Con un modo semplice e, lo ammetto, discutibile: isolandoli in modo ferreo.
I mafiosi non sono prigionieri di guerra, sono sanguinari che hanno sgozzato, strangolato, incaprettato e sciolto bambini nell’acido senza neanche un’aberrante “ragione di stato” dalla loro parte. Non si sono ritrovati a dover difendere un ideale o un pezzo di terra, hanno attaccato chi aveva ideali e pezzi di terra. Per spegnere i primi e impadronirsi dei secondi. Non sono neanche, come qualcuno li ha definiti, i ”nuovi barbari” perché, non conoscendo la storia, non sanno neanche di cosa dovrebbero rappresentare il rinnovamento.
C’è una frase che non si scrive in nessun giornale, ma che molte persone oneste, di destra o di sinistra, vittime di mafia o no, colte o ignoranti, siciliane o lombarde, hanno sulla punta della lingua.
La frase è questa: i mafiosi devono marcire in galera.
Con le regole imposte dal 41 bis.
Quelli che vanno a votare
 Alle primarie per il Partito democratico una fila di oltre tre milioni di persone. Il risultato è eccezionale, se si tiene conto che la catapulta che ha scaraventato ogni singolo individuo fuori di casa nella santa domenica è puramente politica. Perché, non dimentichiamolo, questa era una consultazione puramente politica. Non c’era il parente da mandare ad amministrare, o il consigliori da promuovere, e nemmeno l’amico degli amici da ringraziare o da ingraziarsi. Qui c’era un meccanismo, anche desueto se vogliamo, per scegliere, designare. Fuori dalla convenienza di quartiere o di cosca.
Alle primarie per il Partito democratico una fila di oltre tre milioni di persone. Il risultato è eccezionale, se si tiene conto che la catapulta che ha scaraventato ogni singolo individuo fuori di casa nella santa domenica è puramente politica. Perché, non dimentichiamolo, questa era una consultazione puramente politica. Non c’era il parente da mandare ad amministrare, o il consigliori da promuovere, e nemmeno l’amico degli amici da ringraziare o da ingraziarsi. Qui c’era un meccanismo, anche desueto se vogliamo, per scegliere, designare. Fuori dalla convenienza di quartiere o di cosca.
Nessun trionfalismo però.
Un Paese che assiste al mobilitarsi di tante persone per scegliere un leader di partito deve prendere atto di qualcosa (che mi sorprende): la voglia di partecipare. La politica distante, quella che per luogo comune si chiama “del Palazzo”, non può ignorare la sete di cose fatte che l’elettorato manifesta. Siamo una nazione abituata a guardare con distacco le promesse dei nostri stessi rappresentanti. Abbiamo un sistema elettorale che fa del paradosso un’antipatica regola, consentendo al vincitore il brivido della sconfitta. I programmi politici esistono solo se si chiamano “contratti” e se vengono siglati in diretta televisiva. Non ci indigniamo più di tanto se una coalizione per la quale abbiamo votato si spacca e decide di prendere una direzione zigzagante, che porta lontano da dove si era stabilito. Assistiamo a una frammentazione di sigle (e di contributi economici) insopportabile, con partiti che diventano ago della bilancia pur essendo composti dai parenti intimi di Pappagone.
Tutte quelle persone che si sono messe in coda per eleggere gli organi di una coalizione (sembra ancora) virtuale meritano rispetto e impegno, di maggioranza e opposizione. Perché sono gli ultimi esemplari di una razza che si sta estinguendo: quella che ancora va a votare.
Coraggio
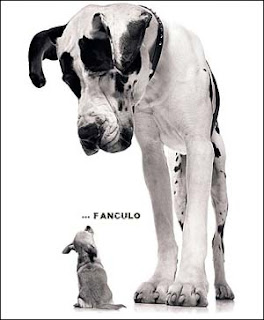 I momenti migliori della nostra vita, secondo me, sono quelli in cui non sappiamo che fare. E in cui ci illudiamo che serva solo coraggio.
I momenti migliori della nostra vita, secondo me, sono quelli in cui non sappiamo che fare. E in cui ci illudiamo che serva solo coraggio.
Non ci vuole coraggio per pensare che i vizi non sono importanti.
Non ci vuole coraggio per dire: “Cambio strada”.
Ci vuole coraggio per mollare gli ormeggi quando le previsioni annunciano tempesta.
Ci vuole coraggio per raccontarsi a chi già ti conosce.
Non ci vuole coraggio per dire: “Io dico quello che penso”.
Non ci vuole coraggio per cambiare partito politico.
Ci vuole coraggio per guardare la propria patente e non pensare a quando ti sei fatto quella foto.
Ci vuole coraggio per lasciare il mondo con un sorriso.
Non ci vuole coraggio per governare col pugno di ferro.
Non ci vuole coraggio per dimenticare presto.
Ci vuole coraggio per fare l’elenco delle promesse non mantenute.
Ci vuole coraggio per avere dubbi.
Non ci vuole coraggio per decidere cosa fare, quando giunge il momento.
Non ci vuole coraggio per mandare a fare in culo tutto e ricominciare. Quello è davvero divertente.
Lettera da un cervello in fuga
 Ieri, a proposito della fuga di cervelli italiani all’estero, ho citato Massimo Marino. Massimo è un palermitano, oggi responsabile del settore ricerca scientifica della Apple e capo del progetto ARTS (Apple Research & Technology Support). Ovviamente non vive in Italia da decenni. La sua risposta mi sembra un ottimo spunto di riflessione.
Ieri, a proposito della fuga di cervelli italiani all’estero, ho citato Massimo Marino. Massimo è un palermitano, oggi responsabile del settore ricerca scientifica della Apple e capo del progetto ARTS (Apple Research & Technology Support). Ovviamente non vive in Italia da decenni. La sua risposta mi sembra un ottimo spunto di riflessione.
Carissimo Gery, la tua chiosa mi ha fatto pensare. A tante cose. Quest’estate sono stato alla SISSA di Trieste per una conferenza: sforniamo PhD di talento… che poi, spesso per i motivi che citi, vanno quasi tutti all’estero.
Anche il professore, Luca B., con cui abbiamo co-organizzato l’evento, non è più in Italia: niente spazio. Contribuisce ora alla ricerca e all’insegnamento superiore in Francia.
Penso ad una mia ex-collega di Berkeley. Penso a quando, prima di Berkeley, lavorava alla Sapienza di Roma in uno scantinato con odore di muffa e di piscio delle latrine del piano di sopra. A Berkeley ha avuto un budget di un milione di dollari per le sue ricerche e adesso forma giovani fisici americani.
Penso a quante volte in tanti, anche tra i più prossimi hanno detto, con una punta d’invidia, (e scusate il termine): “Massimo, che culo che hai avuto ad andartene”. Ultimo mio fratello. Per lui non ho fatto che avere culo nella vita. Culo con mia moglie, culo con la mia laurea in Fisica, culo per il CERN, culo per Berkeley, culo per…
Non è certo la storia di Capecchi, ma se di culo si può parlare si tratta del culo che ci siamo fatti e che continuiamo a farci dal primo giorno all’estero: grande come una casa.
Tempo fa, mentre eravamo ancora a Berkeley, ricevetti da Forza Italia un questionario destinato “ai cervelli in fuga”, essenzialmente per capire cosa si vorrebbe per decidere di tornare in Italia. Per tutti noi non si tratta di soldi, ma di possibilità, di meritocrazia, di disponibilità, del riconoscimento a volte così diretto ed immediato negli altri paesi. Negli USA mi sono sentito dire: “You all are contributing to the greatness of this country, for this you are as American as we are”.
Che differenza rispetto alla umiliazione e alla frustrazione di tanti bravi ricercatori italiani!
Penso a un mio carissimo amico anatomo-patologo, che ogni tanto “fugge” a San Francisco per fare in tre mesi tanta ricerca quanta ne riesce a fare in tre anni in Italia.
Ripensando alle condizioni per tornare in Italia alla fine ci si rende conto che non saranno mai realizzate. Che fortuna avere culo!
Quindi, carissimo Gery, grazie a nome di tutti quelli che sono fuori. I tramonti sulla Bay Area di San Francisco sono mozzafiato, le montagne svizzere innevate, Ginevra, il lago, un posto ideale per crescere i bambini, Londra, una città eccitante e vivissima… Ma come sarebbe bello se tutto questo lo potessimo avere a Mondello!
Massimo
Il nobel ai cervelli in fuga
 Ho letto la storia di Mario Capecchi, il nuovo nobel per la Medicina, prima di andare a dormire. E sono rimasto sveglio a pensare. Poi ho riacceso il computer, stregato dalla vicenda, crudele e felice al tempo stesso, di quest’uomo.
Ho letto la storia di Mario Capecchi, il nuovo nobel per la Medicina, prima di andare a dormire. E sono rimasto sveglio a pensare. Poi ho riacceso il computer, stregato dalla vicenda, crudele e felice al tempo stesso, di quest’uomo.
Nelle vene di Mario Capecchi scorre – come si dice – sangue italiano. Il padre scomparso in Africa, la madre prigioniera dei nazisti a Dachau. Un’infanzia di vagabondaggio nella Bassa Padana, furti per sopravvivere, sofferenza per crescere. Poi il ricovero, a opera di un ignoto benefattore, in un ospedale emiliano e il ricongiungimento a sorpresa con la madre. A otto anni la fuga verso gli Stati Uniti. Il resto è la cronaca di un miracolo di determinazione e meravigliosa curiosità. La scuola senza conoscere una parola di americano, l’università, la laurea, i progressi di una mente inarrestabile.
Ciò che mi ha commosso di questo scienziato è la totale assenza risentimenti: verso la Gestapo che ha deportato la madre, verso il regime italiano che ha spedito suo padre al martirio, verso la nazione di cui è rimasto orfano da giovanissimo, verso quel mondo che lo voleva fango e che se lo è ritrovato oro. Alla scuola delle difficoltà non ci sono esami di riparazione. Capecchi incarna il vero, antico, concetto di sopravvivenza, nel senso di vivere sopra. E’ facile, per noi figli di un’epoca tridimensionale, incensarlo adesso. Davanti a lui si può solo stendere un tappeto di ammirazione e scegliere, per quanto è politicamente possibile, di chiamarlo italiano solo ed esclusivamente nel rispetto di tutti gli emigranti vecchi e nuovi. Il nobel al professore Capecchi deve essere un omaggio a tutti quei cervelli in fuga – penso a Lesandro o ai miei amici Mara e Massimo Marino – da eterne emergenze: i disagi sociali, la disoccupazione, i baroni delle università, l’ingratitudine del nostro apparato economico, l’inerzia e la protervia. Onore a tutti voi.
Il cibo in movimento
 Vi siete mai chiesti quanti litri di carburante ci vogliono per spostare sei litri di succo d’arancia dal Sudamerica a casa vostra? O quanti chilometri ha percorso, da morto e stecchito, il tacchino che avete appena infilato in forno? O quando è stato staccato dalla pianta il kiwi che state sbucciando?
Vi siete mai chiesti quanti litri di carburante ci vogliono per spostare sei litri di succo d’arancia dal Sudamerica a casa vostra? O quanti chilometri ha percorso, da morto e stecchito, il tacchino che avete appena infilato in forno? O quando è stato staccato dalla pianta il kiwi che state sbucciando?
Domande inutili, diranno alcuni. Domande obbligatorie, dicono altri. Ad esempio quelli del Food Miles, un movimento anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, il cui obiettivo è ridurre gli spostamenti del cibo per evitare inquinamento ambientale e deterioramento del prodotto alimentare. Se un’idea è semplice rischia sempre di essere sottovalutata. In questo caso, la saggia massaia di provincia si fa una risata: da sempre lei fa la spesa dall’ortolano che ha il terreno coltivato proprio fuori dal paese; mette in tavola solo alimenti di stagione; storce il naso davanti alla “roba in scatola”. Le nostre città invece sono invase da uva imbalsamata, arance sempiterne, zombie di angus, prugne rinsecchite della California, e via elencando.
Il concetto base su cui riflettere è il seguente: più il cibo si sposta, più inquina. Perché il pollo non va dal Trentino a Bagheria con le sue zampette. Se vogliamo c’è un altro concetto ancora più semplice, al limite dell’imbarazzante: il cibo che resta per settimane su un camion invecchia e diventa brutto. Mi piacerebbe che un tg qualunque dedicasse un millesimo dello spazio riservato a questioni di fondamentale importanza come – chessò – l’autunno caldo del Partito Democratico, al Food Miles e ai suoi sani principi. Non tutti andiamo a votare, però tutti andiamo a tavola.
Ps. La risposta alla prima domanda è: un litro di gasolio.
